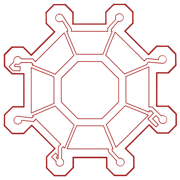Sono passati trent’anni da quando, fra scene di giubilo, Helmut Kohl annunciò la riunificazione della Germania e del suo popolo, culmine di un processo iniziato con l’ apertura delle frontiere tra l’Austria e l’Ungheria, proseguito con le fughe in massa verso Ovest e il progressivo sfaldamento dei governi del “socialismo reale” e accelerato definitivamente, dopo la caduta del Muro di Berlino, dalle sempre più imponenti marce di protesta dei cittadini della Ddr. Il bilancio di questo trentennio, con le sue luci e le sue ombre, è stato tratteggiato e discusso in un gran numero di occasioni celebrative da una pletora di commentatori. Come era prevedibile, la questione è stata sviscerata negli aspetti che maggiormente interessano il grande pubblico: le ricadute economiche, sociali e geopolitiche che, pur investendo in primo luogo lo scenario tedesco, sono rimbalzate sullo scacchiere internazionale, determinando aggiustamenti o spostamenti di equilibri che sembravano cristallizzati, se non dal 1945, perlomeno dall’apertura della guerra fredda. Altri lati della vicenda e delle sue conseguenze, meno evidenti, sono rimasti pressoché inesplorati.
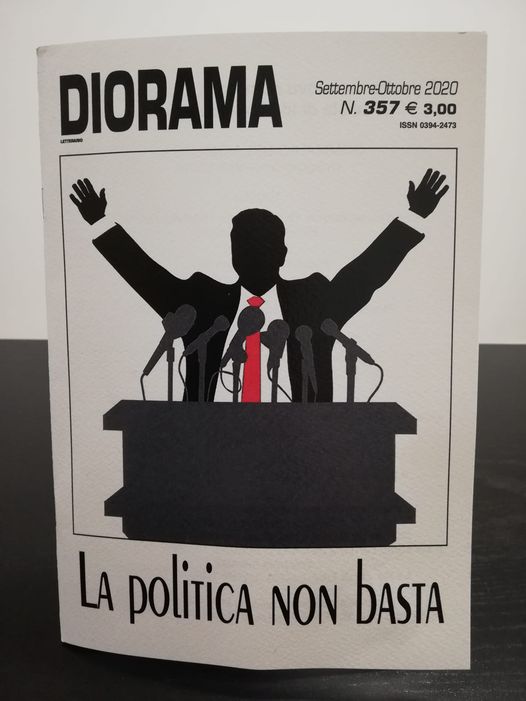
Fra questi ultimi, ce n’è uno che sta particolarmente a cuore a quanti non si arrendono all’idea che quello in cui stiamo vivendo sia il migliore dei mondi possibili e si sforzano di cercare via di uscita da un panorama in cui predomina sempre più nettamente il modello della società consumistica, con la sua quotidiana overdose di individualismo egoistico, indebolimento dei tradizionali legami sociali, materialismo spicciolo e logoramento delle identità collettive – un universo ancor più unidimensionale di quello descritto da Herbert Marcuse nel libro che diventò la Bibbia dei movimenti sessantottini. Ed è su quello che è opportuno orientare l’attenzione e, sperabilmente, la discussione delle disperse frange dell’arcipelago che ama definirsi non conformista.
Stiamo parlando delle speranze che gli avvenimenti compresi fra l’estate del 1989 e quella del 1991, in cui si compì l’atto conclusivo della parabola dell’Unione sovietica, suscitarono in chi, da anni o da decenni, si batteva contro il duopolio planetario delle superpotenze, vedendo nell’Urss e negli Usa, per dirla con la formula, forse semplicistica come lo sono tutti gli slogans, ma efficace del fondatore di Jeune Europe Jean Thiriart, «complici sempre, concorrenti spesso, nemici mai». Il crollo del tanto detestato Muro berlinese fu, per quel microcosmo, una sorta di inattesa rivelazione, quasi la prova dell’esistenza dei miracoli, il segnale della chiusura di un ciclo e dell’apertura di uno nuovo e completamente diverso.
Cominciarono quindi a fiorire le ipotesi su come si sarebbe disegnato il futuro assetto del Vecchio continente e, per estensione, dell’intero pianeta, e sul chi e come avrebbe potuto influire sulla direzione del cambiamento che stava avviandosi. Anche chi sta scrivendo queste righe partecipò al momento di enfasi generalizzata, immaginando che la tanto agognata Terza via proiettata oltre le storture del capitalismo e del collettivismo e rimasta sempre allo stadio di abbozzo utopico si sarebbe trasformata di fatto in Seconda via, unica alternativa credibile all’egemonia della forma liberale della gestione della società. C’era, in quella che si sarebbe poi rivelata un’illusione, la voglia di riscattare una lunga storia di marginalità dei sopravvissuti – psicologicamente piuttosto che fisicamente, dato che gran parte di loro era nata dopo il 1945 – alla catastrofe che, decretando la sconfitta dei fascismi, aveva liquidato anche tutti gli altri progetti fioriti tra i “non conformisti degli anni Trenta” con l’intento di costruire un nuovo ordine capace di fondere identità nazionale e giustizia sociale, autorità e libertà, comunità e persona. Ma c’era anche la convinzione di poter finalmente favorire, in ambienti intorpiditi dai torcicollo nostalgici, un ripensamento radicale degli errori commessi da quei regimi e movimenti, per gettare le basi teoriche di formule innovative, capaci di coniugare i valori da sempre coltivati in forme aliene dai difetti che avevano afflitto il neofascismo, a partire dalle propensioni autoritarie, dalle indulgenze verso la pratica della violenza, dal militarismo, dalla retorica autocelebrativa, dal nazionalismo sciovinista. Poiché in quegli stessi ambienti erano fiorite, fin dagli anni Settanta, iniziative rivolte ad un confronto aperto con la modernità e i suoi problemi – la questione ecologica, la difficile costruzione di un’Europa politica in grado di elevarsi a “grande spazio” autonomo, la crescita vertiginosa del potere della Tecnica, la scomparsa del sacro, l’involgarimento dei costumi e così via –, coagulatesi in Francia attorno al nucleo propulsore della Nouvelle Droite e in Italia nella componente “movimentista” rautiana del Msi che in buona parte avrebbe dato vita alla Nuova Destra, si pensava che la situazione aperta dalla frana del comunismo avrebbe costituito l’humus ideale per fare un decisivo passo avanti. L’obiettivo era dar vita ad un’area culturale, plurale al suo interno ma convergente nelle linee di fondo, in grado di guadagnarsi una presenza non occasionale nelle sedi del dibattito massmediale e di lì esercitare una graduale influenza sull’opinione pubblica, partendo dai suoi strati colti o comunque più sensibili agli stimoli intellettuali, incontrando su un terreno finalmente sgombrato dai lasciti delle antiche appartenenze un certo numero di “irregolari” ed “eretici” di altre famiglie di pensiero, riallacciando i fili di quel tentativo di oltrepassamento della barriera eretta fra destra e sinistra che aveva registrato qualche significativo successo qualche anno prima, a partire dal dialogo con Massimo Cacciari, Giacomo Marramao, Alex Langer ed altri intellettuali engagés, facendo scorrere molto inchiostro di stampa, ma poi si era arenato per effetto del fuoco di fila – e/o degli studiati silenzi – dei politici e degli operatori dell’informazione che abitavano le casematte (così le definì Cacciari in un’intervista che fece scandalo) poste a difesa dello status quo.
Un po’ in tutta Europa sembrava che fosse riunite le condizioni per un balzo di qualità che avrebbe riportato al centro della scena mediatica quel movimento di idee che, sbrigativamente battezzato Nuova Destra, ne era stato escluso, soprattutto in Francia dove si era manifestato prima e più attivamente, da campagne diffamatorie senza precedenti[i]. E in Italia, in particolare, le prospettive apparivano particolarmente favorevoli, perché era ormai evidente che sul terreno politico le idee non conformiste non avevano nessun veicolo per affermarsi. I Verdi, sulla cui capacità di sfondare le vecchie linee di conflitto e promuovere convergente inedite in nome della qualità della vita e di un modello di sviluppo “decrescente” si era per un breve lasso di tempo pensato di scommettere, si erano arenati nelle dispute intestine provocate dall’afflusso dei reduci del naufragio di partitini dell’ultrasinistra, ansiosi di riciclarsi, e nel timore di affrontare lo scontro frontale con i pregiudizi progressisti. Le Leghe autonomiste, altrettanto litigiose sia prima che dopo l’unificazione nella Lega Nord, rimanevano rinchiuse nel recinto di un miope localismo. Il Msi, infiacchito prima dalla gestione cesaristica e immobilista di Almirante e poi dai duelli ad esiti alterni tra gli aspiranti alla sua successione, raccoglieva sempre meno consensi nelle urne e perdeva pezzi tanto alla base quanto ai vertici. E, diversamente da quanto accadeva oltralpe, dove dal 1984 il Front national si era prepotentemente proiettato sulla scena istituzionale sottraendo un certo numero di esponenti al Grece, allora colonna portante della Nouvelle Droite, si stava diffondendo la convinzione che la via della politica si fosse ormai trasformata in un vicolo cieco per chi intendeva difendere e diffondere nella società le idee a cui abbiamo accennato.
Fu a seguito di queste riflessioni che nacque, con ambizioni ben più vaste che in passato, la terza serie di una delle pubblicazioni in cui si era a suo tempo incarnato il progetto della Nuova Destra, «Elementi», non più rivista sofisticata nei temi ma un po’ confidenziale, come era stata nelle precedenti versioni, ma – almeno nelle intenzioni – proiettata in una dimensione più “combattiva” di contestazione delle idee mainstream su più fronti. Per dirla con altre parole, meno intellettuale e più metapolitica. Trovato inaspettatamente il sostegno di un piccolo editoriale amatoriale ma volenteroso ed ottimista, la testata venne lanciata nelle edicole con una tiratura – che ai promotori pareva impressionante – di 50.000 copie e qualche modesta inserzione pubblicitaria sui quotidiani. La volontà era quella di riempire uno spazio vuoto e contrastare la riduzione dello scenario politico-culturale a un confronto in punta di fioretto tra liberali “storici”, ormai convinti, sulla scia dei vaticini di Francis Fukuyama, che la storia fosse giunta al capolinea decretando il loro definitivo trionfo e liberali freschi di conversione, transfughi dal marxismo di varie sfumature ed in cerca di una collocazione ideologica che consentisse loro di non perdere le posizioni acquisite nell’establishment accademico, editoriale e giornalistico.
L’avventura non finì bene. Anche se non fu accolto dallo scherno e dalla diffusa ostilità con cui il microcosmo neofascista di ogni obbedienza aveva anni prima liquidato, denigrato ed ostacolato l’esperienza neodestra, accusandola di tradimento dell’ortodossia e di snobismo intellettualistico, il mensile non sfondò, ancora una volta per la diffidenza di quegli ambienti che, se avessero tenuto fede ai loro proclami, avrebbero dovuto convintamente sostenere il tentativo di sfidare sul suo stesso terreno l’egemonia culturale progressista. Sui destini della rivista e del progetto che ad essa si collegava prima pesò lo stato di prostrazione psicologica degli eterni “esuli in patria”, molto più propensi ad affondare con il vascello missino, e a ritirarsi nel privato, che a misurarsi con nuovi strumenti di lotta. Quindi incise, a seguito delle esternazioni di Cossiga e dei primi sintomi dello sconquasso di Tangentopoli, l’euforia di quegli stessi ambienti per lo scampato naufragio, condita dalla sensazione di poter finalmente – e del tutto inaspettatamente – passare dalla condizione di eterni ed impotenti oppositori a quella di partecipanti a coalizioni di governo.
L’ebbrezza per quella metamorfosi riportò in auge, sul versante che si dichiarava non conformista, la convinzione che «solo la politica paga», che il lavoro sulle mentalità presupposto dai progetti metapolitici è troppo lento ed incerto, che la cultura non ha niente da dire alle masse e che per cambiare le cose davvero occorre impugnare il bastone del comando. Con l’approdo nei palazzi del potere di Alleanza nazionale, la suggestione di questa prospettiva fu tale da richiamare in campo un buon numero di ex militanti prepensionati, da indurre animatori di turbolenti gruppuscoli radicali a indossare giacca e cravatta per puntare ad incarichi elettivi o di sottogoverno e persino da far mutare opinione a taluni dei primi adepti della strategia metapolitica. Motivo conclamato di tutte queste convergenze? La convinzione della necessità di cambiare il sistema “dall’interno” e così agire sulla società.
Fra alti e bassi, lo svolgimento di quel tentativo è durato poco meno di vent’anni. I suoi frutti li abbiamo sotto gli occhi quotidianamente. Così come possiamo misurare i risultati prodotti dalle partecipazione ad altre esperienze governative di partiti populisti di altri paesi, in Europa e altrove. Raccogliendo un ragguardevole numero di voti in elezioni di vario grado e natura, conquistando ministeri anche di primo piano, governando regioni e comuni, portando i loro massimi esponenti a non molta distanza dal successo in elezioni presidenziali o addirittura vincendole – come nel caso di Trump e di Bolsonaro –, quali trasformazioni delle rispettive società hanno prodotto questi soggetti, ferocemente critici del “politicamente corretto” e assertori di drastiche inversioni di rotta finché si trovavano all’opposizione? Che attuazione hanno avuto le loro parole d’ordine? Quali segni hanno lasciato negli orientamenti delle rispettive pubbliche opinioni?
Il bilancio, da questo punto di vista, è desolante. Prive di personale all’altezza dei compiti legati alle nuove responsabilità, di una chiara strategia, di progetti a lunga scadenza, timorose di perdere la legittimità a fatica conquistata, imbrigliate da vincoli esterni e burocrazie interne ostili, desiderose di non trovare intralci in quei “poteri forti” e in quelle “élites” contro cui avevano scagliato i loro fulmini, queste formazioni hanno ripiegato sul piccolo cabotaggio e rinunciato a radicare idee nuove nel tessuto connettivo delle società.
Come risultato di questo misto di incapacità e timore, i comandamenti della political correctness hanno trovato applicazioni ancora più stringenti. Sul piano legislativo, nessuna misura efficace ha portato ad un’inversione di tendenza, o almeno ad un arresto, dei flussi migratori; le norme legate ad una visione individualista e progressista dei rapporti interpersonali (procreazione per conto terzi, matrimoni e adozioni omosessuali, limitazione della libertà di opinione sui temi considerati “sensibili”) non sono state abolite, ed anzi se ne sono aggiunte altre; la colonizzazione dei media del servizio pubblico e delle istituzioni educative statali da parte di propalatori del Pensiero Unico è proseguita senza opposizione. Non solo. Quando governi “populisti” o “conservatori” hanno adottato provvedimenti che andavano, seppur parzialmente, in senso contrario a questa tendenza, si sono scatenate manifestazioni di piazza – raramente moltitudinarie, ma sempre amplificate dai mezzi di informazione – per esercitare pressioni tali da indurle a revocarle. La “teoria del genere” ha trovato ulteriori tribune, la lobby Lgbt etc. ha segnato punti a proprio favore e in nome di un ambiguo antirazzismo (di fatto spesso trasformatosi nel suo opposto, come ha argomentato su queste colonne Alain de Benoist citando i casi francese e statunitense) si è scatenata un’opera di travisamento e demolizione della memoria storica delle popolazioni eredi di una civiltà “bianca” ed europea, con gli abbattimenti della statue, l’epurazione dei nomi delle vie, l’imbrattamento delle targhe che ricordano eventi e personaggi sgraditi.
Il tutto – e questo è un punto non secondario – è avvenuto senza alcuna reazione di segno opposto. Alle piazze contestatrici non si sono opposte piazze di sostegno, se non in casi rarissimi. Alle altrui campagne non se ne sono opposte di proprie. Non si è aperta alcuna strada a chi avrebbe potuto efficacemente opporre argomenti ad argomenti, tesi a tesi, idee a idee, nei palinsesti televisivi, nelle redazioni giornalistiche, nelle programmazioni delle case editrici. È mancato tutto ciò che fa la forza di un progetto di penetrazione nelle mentalità collettive, nelle abitudini, nei modi di vita: una visione coerente della società, una strategia, una capacità di mobilitazione. Si è puntato solo su un acquiescente consenso dei già (più o meno) convinti, sui sentimenti antipolitici della “gente comune”, su sentimenti transitori come la paura e la rabbia, su quello che un tempo veniva definito qualunquismo.
Si è, soprattutto, pensato che occupando un certo numero di posti retribuiti nelle sedi istituzionali si sarebbero potuti distribuire incentivi a qualche clientela, accontentare seguaci, rabbonire gli alti funzionari dell’amministrazione, eventualmente tagliare qualche flusso di denaro pubblico a enti e associazioni ostili. Si è puntato, insomma, tutto su una politica intesa come routine, gestione ordinaria dell’esistente, più sottogoverno che governo. Come i conservatori classici avevano fatti nella loro epoca d’oro. Ma da allora ad oggi è passato un abbondante secolo, e lo scenario è molto cambiato. Quando gli strumenti di comunicazione che forgiano l’immaginario collettivo e propongono – per imporli con le tecniche del marketing – i modelli di comportamento da additare come esemplari alle masse sono al servizio di una visione del mondo (intesa non solo come una astratta Weltanschauung ma anche come una concreta way of life) basata su credenze opposte a quelli in cui ci si riconosce, e ovunque – nelle scuole, nelle università, negli istituti di ricerca, nella letteratura, nel cinema, nel teatro, nei programmi televisivi, su giornali e riviste ed in ogni altra forma di intrattenimento destinata al tempo libero – quelle credenze sono coltivate e diffuse, dovrebbe essere chiaro anche a chi non ha grande dimestichezza con la riflessione che la politica non basta ad arginare la marea. Solo un’azione metapolitica intensa e coordinata può, perlomeno nei tempi medio-lunghi, sperare di raggiungere questo obiettivo. Aver rifiuto di capirlo mezzo secolo addietro ha condotto alla situazione che stiamo vivendo. Continuare a farlo sarebbe una condanna definitiva all’impotenza.
Marco Tarchi
[i] Alle azioni della “polizia del pensiero” e della “nuova inquisizione” contro la Nouvelle Droite, le sue iniziative e i suoi esponenti, a partire da Alain de Benoist, «Diorama» ha dedicato a suo tempo due fascicoli monografici e numerosi articoli.