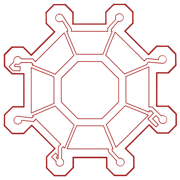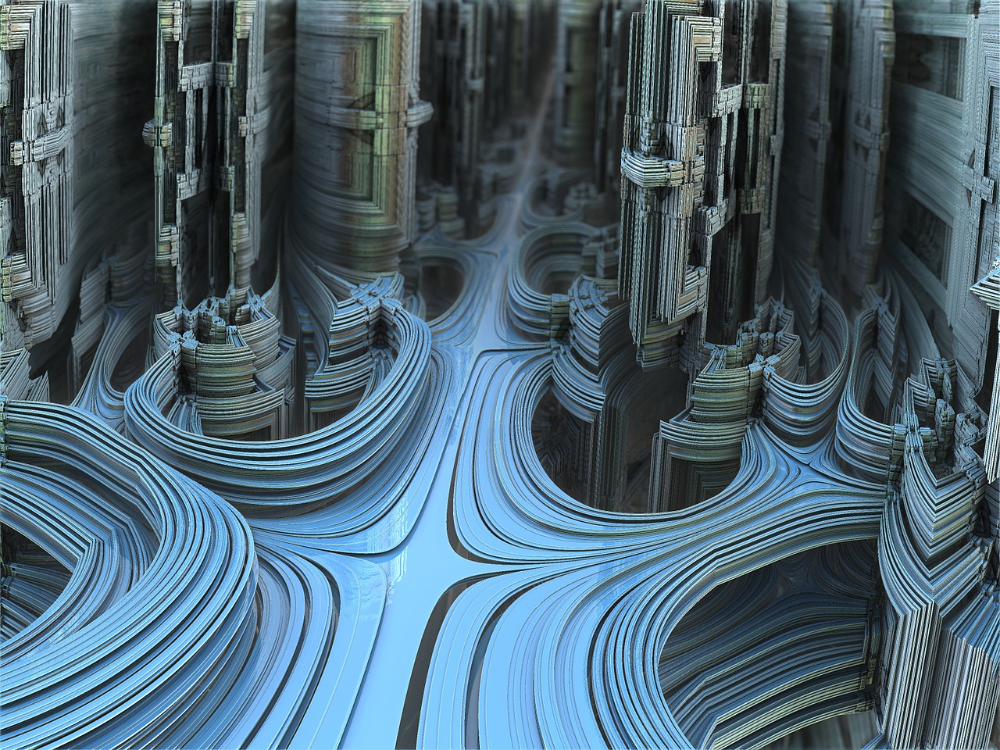Molti studiosi si interrogano in che misura abbia reagito l’intero dispositivo capitalista con l’avvento della pandemia. Tra questi, pochi si interrogano sull’andamento dell’ultimo decennio, l’anticamera della pubertà della geopolitica del capitalismo. Una ricorrenza in cui si intrecciano i conflitti tra stati, aziende e multinazionali.
A partire da febbraio scorso, periodo che coincide con l’inizio della pandemia ed il primo confinamento, le speculazioni inerenti all’emergere di un “nuovo mondo” hanno monopolizzato il dibattito pubblico, economico e massmediatico. Cosa che comunque non ha precluso l’elaborazione di più disamini attente sullo stato delle cose. Ma facciamo un po’ di chiarezza, fermo restando che nessuno è un indovino e men che meno è in possesso di un’unica verità assoluta.
Ormai è una prassi, in questo periodo particolare, quando si parla del capitalismo, ridurre il tutto all’insegnamento e all’apprendimento a distanza, al “lavoro agile”, alle sole questioni sanitarie o economiche, confidando ciecamente in una “transizione ecologica” con tanto di Ministero adibito al Green Deal europeo sulla scia delle “sollecitazioni” alla Greta Thunberg. Un piccolo inciso: in un prossimo articolo andremo a fondo sulla questione ecologica e ambientale, specificatamente nelle disamini dell’ecologia profonda e radicale, sull’ambientalismo che va per la maggiore.
Ma occupiamoci per ora d’altro, andando diretti alla questione: siamo davvero giunti ad una radicale rottura politica, economica ed ecologica con il passato? Dubito che le vicissitudini e lo sbigottimento dovuti al Covid-19 possano essere da sprono, per un’ipotetica presa di coscienza che metta in luce le contraddizioni dei nuovi approcci allo sviluppo. È già da tempo che abbiamo imboccato una strada irta di insidie che non è mai stata a lungo ritardata, così come viene erroneamente descritta, in ottica di una ancor più ipotetica ricerca del benessere che dovrebbe diventare la pietra angolare delle società post-crisi sanitaria.
In campo scientifico sono in auge due tesi rilevanti, imperniate sulle trasformazioni del lavoro dal XXI secolo in poi. La prima è ben espressa nel saggio di Benedetto Vecchi, intitolato “Il capitalismo delle piattaforme”, facente riferimento all’offerta dei servizi digitali e logistici accessibili a tutti. Incentivando, in scala, la concorrenzialità monopolistica degli attori principali spesso in conflitto tra loro nell’ambito transnazionale ma, intenti ad una attenta ed “equa” redistribuzione dei proventi del mercato.
La seconda invece, riguarda il dispiegamento dei capitalismi a guida degli stati, che dovrebbe, secondo alcuni indicare un ritorno al dinamismo degli Stati-nazione, in particolar modo interessati agli sviluppi nell’ambito economico. Uno degli interrogativi che si pone l’ambito scientifico è il seguente: ci sono delle contraddizioni tra l’avvento di un «capitalismo delle piattaforme» a trazione “internazionalista” e il presunto ritorno del potere economico degli stati?
Provando a dare una risposta esaustiva a questo interrogativo, partiamo col dire che per chi vi scrive, trattasi più di una contraddizione inerente alla tipologia dei capitalismi. Spiegandomi meglio: chi si pone un quesito come questo, lo fa solo adottando un metro di giudizio che non è per nulla dissimile dalla dottrina economica, finanziaria, politica e sociale, del liberalismo. In primis, la mentalità liberale continua a rinnovare una radicale opposizione teorica tra Stati e aziende private, quando in realtà il «capitalismo delle piattaforme» è in parte il prodotto di un certo potere degli stati.
La geometria variabile dei capitalismi
Vuoi per le politiche comunitarie dettate in seno alla UE e vuoi per l’assoggettamento a tali politiche dei singoli attori, che ha scoperchiato il vaso di pandora dei conflitti tra gli stati proprio a causa del voler avvantaggiarsi rispetto ad altri di tali piattaforme e tecnologie. Insomma, dal Taylorismo, al Fordismo e Toyotismo, qualcosa è cambiato. Basti pensare che una delle giustificanti per un cambio di governo in Italia, concerne l’ottima gestione, tutta da dimostrare, del “Recovery fund” e della successiva implementazione della digitalizzazione (in questa sede soffermiamoci a questo).
Due esempi in tal senso sono la Cina con le sue piattaforme tra le quali, citandone alcune, spiccano BATX, Alibaba, Baidu, Tencent, Xiaomi ecc., contrapposte a quelle create dagli Stati Uniti grazie all’ausilio degli investimenti pubblici impiegati per la difesa e la sicurezza, come il progetto GAFAM, Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft. Dunque, pensare a questi due sviluppi capitalistici solo in un quadro nazionale ed eccezionalmente positivo perché racchiuso in determinati confini, è un errore cognitivo che sfocia spesso nella poca conoscenza dei processi del capitalismo degli ultimi trent’anni.
Le grandi aziende multinazionali del settore sono strumenti del potere per alcuni stati, ma sono anche quelle entità private dedite all’espansione ed alla incentivazione dell’uso di tali piattaforme e tecnologie, dettando l’agenda alla politica degli stati. Ma visto che trattandosi di uno strumento del potere di alcuni stati, USA e Cina in particolar modo, ne consegue un uso atto a minacciare la sovranità di quei governi che provano, in tutti i modi, a colmare lo squilibrio tecnologico, cercando di bilanciare una corsa che sembra persa in partenza. Chiarito questo, il punto di forza delle “nuove” dinamiche capitalistiche, è indubbiamente la concentrazione delle informazioni e delle conoscenze sulle nuove tecnologie impiegate in svariati ambiti, capitali investiti, profitti ed il potere economico da contrapporre in direzione di quegli stati “non al passo coi tempi”.
La concentrazione di questi capitalismi evidenzia il ruolo preminente che hanno nelle relazioni internazionali e nello scacchiere geopolitico. Osservando le cose da un’angolatura del tutto libera dalle leggi di Snell-Cartesio, va da sé che in un mondo del genere non è possibile porre l’attenzione protinus vive sull’importanza delle organizzazioni multilaterali e del mancato rispetto per le regole, nel bel mezzo di tali contrapposizioni che pervadono ogni ambito e sfera degli stati e delle unioni sovranazionali. Quando ci si oppone al «capitalismo delle piattaforme» non si può pensare che il capitalismo degli Stati-nazione sia nel suo complesso differente, distinguendosi dalle metodologie abituali degli altri capitalismi. Lo studio delle relazioni politiche ed economiche internazionali è molto chiaro: le interazioni tra i vari soggetti, gli stati, le unità sovranazionali e quant’altro, sono subalterni alla legge di mercato delle piattaforme e non sono totalmente svincolati da essa.
La Cina è l’estrema sintesi della combinazione del controllo di un partito-stato che sta incentivando l’imprenditorialità interna e decentralizzando sempre più le attività amministrative, vietando l’uso indiscriminato delle piattaforme straniere. Il modello politico ed economico cinese è in netta competizione con quello statunitense, a tal punto che c’è chi immagina un mondo diviso in due a seconda della sfera d’influenza delle due superpotenze in termini di rapporti commerciali, strettamente connesse alle tecnologie e alle due valute internazionali. Nonostante ciò, una certa “espertologia”, quella che tiene parecchio alle “buone cose del mondo”, è convinta che l’esistenza di diverse varietà di capitalismi, vincoli necessariamente a delle relazioni di potere asimmetriche tra gli stati.
Le relazioni geopolitiche e il ruolo dell’Unione Europea
Ma è evidente che non tutti gli stati hanno la capacità di opporsi alle multinazionali del settore, per la ragione che non sono in grado di emettere debito pubblico quasi senza vincoli, o di avere una produzione che soddisfi in pieno la domanda interna. Tra gli stati che soffrono di più questo “nuovo” equilibrio, troviamo quelli che esportano maggiormente le proprie materie prime. Il loro potere economico e geopolitico è stato notevolmente ridotto dalle politiche economiche ed energetiche degli Stati Uniti, soprattutto dalla politica di indipendenza energetica (lo sfruttamento del gas di scinto) e dal sostanziale rallentamento della crescita cinese degli ultimi anni.
I dati del 2020 pubblicati dall’Eurostat, dicono che la Cina ha superato nelle esportazioni europee gli Stati Uniti, diventando il maggiore esportatore di prodotti in Europa. L’Unione Europea ha importato merci quantificabili in 383,5 miliardi di euro. Quelle che importa la Cina dall’Europa ammontano ad una cifra di 202,5 miliardi di euro, con un aumento del 2,2%. I maggiori prodotti importati dalla Cina sono: mobilio, forniture mediche, prodotti elettronici, tessuti, giocattoli, biciclette, ecc. Quelli importati dall’UE in Cina sono le apparecchiature meccaniche ed elettroniche, gli impianti di trasporto ed i prodotti chimici.
Andando oltre lo squilibrio delle cifre che riguardano le importazioni e le esportazioni tra i due poli, quello che balza agli occhi è il «Sistema» della dipendenza europea, per prodotti e merci che potrebbero essere prodotti in loco, promuovendo una politica di incentivazione, specialmente su quelle merci di primaria importanza per l’autonomia dei paesi membri della UE. Parallelamente, possiamo dire che il capitalismo della rendita energetica di stati come la Russia, Arabia Saudita, Algeria etc., è nel pieno di una crisi che non ha precedenti in passato.
Mentre il «capitalismo delle piattaforme» statunitense, è alle prese con l’esplosione ed il convergere di tutte le forme di disuguaglianza, che se ad oggi non minacciano direttamente l’innovazione tecnologica, stanno però provocando una forte destabilizzazione politica. Cosa che non tocca minimamente il capitalismo, dal forte impulso statale in Cina, che ha dimostrato di sapersi adattare agli shock provocati da ben due crisi, quella sistemica del 2008 e quella sanitaria del 2020. A questo, dobbiamo sommare il forte potere di “seduzione”, diciamo così, che esercita la Cina nei confronti di altri paesi asiatici, in Africa ed in America Latina.
L’Europa sembra essere l’anello debole delle nuove relazioni geopolitiche, intessute dai singoli stati, Germania e Francia su tutti. Ma senza un’impronta unitaria che possa essere efficace a beneficio dell’ossatura comunitaria, le cose si complicano non poco. Il voler difendere un «capitalismo democratico al servizio dei cittadini» ha in parte evitato le ingerenze commerciali ed economiche americane e cinesi, senza però riuscire a ridimensionare quelle stesse disuguaglianze simili a quelle statunitensi, che stanno aumentano ad un ritmo vertiginoso; dimostrando un agire, ancora una volta inefficace, se non addirittura essere, la foglia di fico del declino della socialdemocrazia europea. A tutto questo, dobbiamo aggiungere la preoccupante dipendenza tecnologica dall’estero, l’insufficienza dimostrata dal coordinamento europeo nella gestione della pandemia, il fallimento di una superiorità presunta del modello socialdemocratico della UE, ricordiamolo, parecchio tempo prima della pandemia.
Precisamente, la crème degli economisti italiani è convinta che l’Unione Europea possa riprendersi da questa fase di stallo. Quando in realtà la questione era ben visibile già ai primi vagiti della UE. Per superare le grandi difficoltà rappresentate da un’inesistente coesione politica, escludendo i trasferimenti di bilancio tra gli stati membri che nessuno vuole adottare e che non possono certo essere la panacea di tutti mali, la mancanza dei presidi ai confini comunitari e la costituzione di un esercizio comune, presi caso per caso, non basterebbero a risolvere i problemi. Questo in assenza di una politica economica da riscrivere totalmente, affidandosi esclusivamente ai piani come “Next Generation EU”, al rafforzamento della cooperazione e degli scambi tra gli stati comunitari in materia di istruzione digitale.
Altro discorso riguarda le “Piattaforme Tecnologiche Europee (ETPs)”, inserendo nel progetto l’istruzione, l’università ma anche i gruppi finanziari “europei” «che operano su scala europea in uno specifico settore di innovazione tecnologica», salvo essere interessati principalmente a promuovere le PTE (Bio-based economy, Energy, ICT, Production and Processes, Transport, Environment, Cross-cutting) ed escludendo dal progetto la manifatturiera (industria tessile, siderurgica, chimica e meccanica), il settore dei servizi, quello primario (estrazione di risorse naturali o produzione materie prime), il settore secondario (industria pesante e industria leggera), e tutti i comparti produttivi di massima importanza per l’Italia, che non possono essere lasciati indietro per finanziarizzare (altro che finanziare!) solo i progetti delle piattaforme. Senza una redistribuzione tra le due cose, al posto della tanto decantata alfabetizzazione digitale, è probabile che assisteremo in tempi brevi ad un incremento mai visto della disoccupazione e della perdita di assets di primaria importanza. Italiani, s’intende…
Il corso del capitalismo non segue sempre una regolarità ripetendosi in modo univoco. Qui la metodologia c’entra poco. Per essere più chiari: a seconda dei contesti delle crisi pandemiche nel corso della storia, dei processi economici, politici e sociali che abbiamo attraversato, fatti specie nei momenti di rottura con il paradigma precedente, è riuscito a sviluppare delle segmentazioni singole a seconda dei contesti e dei processi. Una buona soluzione di una politica fiscale e industriale comune, può esserlo solo se si tengono presenti le differenze che intercorrono tra gli stati membri e, in base a questo, proporre un qualcosa che sia diametralmente opposto dai particolarismi dei singoli stati, dalla biforcazione degli stati europei del Nord e del Sud.
Le prospettive e cosa è possibile fare
Cosa che obiettivamente pare essere più facile a dirsi che a farsi, visto che il «capitalismo delle piattaforme», agisce in una società lacerata e antinomica dagli inizi degli anni duemila. Dalla pandemia in poi, parliamo di un automatismo estremamente dipendente economicamente e finanziariamente da un mondo interconnesso, malgrado le popolazioni aspirino sì a delle sovranità nazionali, ma all’interno dei grandi poli della cultura di cui fanno parte. Una cosa che non può non essere presa in considerazione.
Per quanto riguarda un coordinamento che si avvale di investimenti privati a lungo termine, con a capo uno Stato manager o «dirigente di progetto», non può certo essere la soluzione. Non lo è per il motivo che questo ruolo dello Stato, comporta un ritorno di fiducia in uno Stato chioccia (totalmente assistenzialista) o totalmente dedito al sistema fiscale (dedito al riformismo fiscale, all’aumento delle imposizioni fiscali), aumentando la poca fiducia in tutte le fasce della società. Una fiducia che esula dal Governo Draghi e pressoché inesistente se parliamo dell’Europa Unita.
Un altro dei problemi maggiori è anche la questione del debito pubblico che non permette di limitare i danni della pandemia. È sottinteso che se è importante un blocco politico che non sia subalterno a certe logiche, lo è anche il fatto che non può certo esserlo su basi socioeconomiche di un altro tipo di capitalismo, senza ripudiarne la logica a priori. Un vero e proprio freno sull’acceleratore che potrebbe inibire un pensiero difforme, prendendo in considerazione altre alleanze possibili e approcci differenti nell’assetto geopolitico e nelle relazioni internazionali.
Può bastare un modello di sviluppo «antropogenico» che articola insieme phoné e logos , come dice Agamben oltre «all’evento antropogenico», perché «il diventar umano dell’uomo non sia mai compiuto una volta per tutte, non cessi mai di avvenire»? Diciamo che nel suo L’uso dei corpi, a pagina 266, non ci va molto lontano. Sempre che non si voglia escludere dal ragionamento la salute, l’educazione, l’istruzione e la cultura, senza troppo soffermarsi su di un vago benessere delle popolazioni fra «primitivismo» e progresso. È tempo di pensieri lunghi e meno “voli pindarici”. Anche perché, tornando al filo conduttore di questo scritto, è ampiamente dimostrato che i capitalismi di stato possono appropriarsi dei problemi inerenti alla salute come strumento di legittimazione, quanto il «capitalismo delle piattaforme» gli è speculare, traendo da essi una formidabile fonte di profitto.
Dando per scontato che esistono diversi capitalismi e l’obiettivo che hanno in comune è certamente quello di continuare ad accumulare profitto, per mezzo di una “nuova” società di mercato ma su altre conversioni che attualmente gli sono più congeniali (il periodo di incertezza gioca a favore), l’avvenire può dipendere sicuramente dalle scelte politiche che si attueranno ma soprattutto dall’abbandono di una mentalità mercatista, utilitarista, individualista ed economicista-societaria, della nostra civiltà. La complementarietà e la forma degli assetti istituzionali, differiscono tra i momenti storici e, ovviamente, tra le diverse evoluzioni del capitalismo. Alcuni di essi si sono rilevati essere più stabili di altri ed alcuni per nulla. In quelli riconosciuti essere validi, abbiamo osservato una maggior complementarietà tra i vari ordinamenti delle istituzioni sociali, economiche, politiche, ecc.
Complementarietà o ritorno a Keynes?
Ma la questione non è riducibile, a proposito di JM Keynes, nella virtù degli accordi per stemperare l’incertezza degli agenti economici. Ad oggi siamo alle prese con la finanziarizzazione dell’economia che fa degli agenti economici, dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle operazioni economiche ma volatili. Fortemente influenzati dai gruppi di interesse, il vecchio adagio “clienti, fornitori e finanziatori”, perde del suo significato senz’altro discutibile. L’ago della bilancia pende solo in direzione di quest’ultimi. Sono diventati a tutti gli effetti degli stakeholder, dei «titolari di una posta in gioco», così come li descrive l’etimo inglese che gli è proprio.
Non è difficile capire in che misura si sia persa la sincronizzazione/regolazione dei tempi sociali, della sfera dell’economia e del sociale. Le contraddittorietà istituzionali (la mancanza di complementarietà e reciprocità) e l’inguaribile asincronia sono un volano per l’incertezza economica, uno sprono per la destabilizzazione delle modalità di regolazione dell’economia. A dominare è indubbiamente la logica economica ma a vincere è un monopolio autoreferenziale, indifferenziato e dalle deregolamentazioni, quelle “gentili” concessioni che sia gli stati e le unità sovranazionali accettano di buon grado, nonostante siano con l’acqua alla gola: dal dimezzamento delle forniture dei vaccini (“AstraZeneca dimezza fornitura prevista alla Ue”), alla dura legge della concorrenzialità e dell’approvvigionamento delle piattaforme tecnologiche, passando dalla medicalizzazione di stato (lo “Stato terapeutico”), al trasferimento delle comunità umane sul Web, social network e piattaforme di videoconferenza.
Questo chissà fino a quando, forse il prossimo decennio, in attesa di un’altra inaspettata opportunità congiunturale, per i capitalismi prossimi a venire.