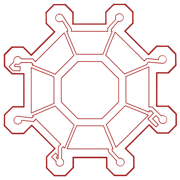La Grande Trasformazione è un libro di Karl Polanyi pubblicato per la prima volta nel 1944. L’opera tratta delle conseguenze sociali e politiche dell’affermazione della teoria liberista del mercato auto-regolantesi. Secondo l’autore – che utilizzava una prospettiva antropologica nello studio dei fenomeni economici – prima della “grande trasformazione” l’economia era integrata nella società e le persone basavano i loro scambi eminentemente sul valore d’uso, non sul profitto ma sulla redistribuzione dei beni fondata su relazioni personali, comunitarie e su rapporti di reciprocità. Le conseguenze dello sradicamento del passato in favore del nuovo modello economico si rivelerà tanto distruttivo quanto insostenibile per le società date. D’altronde sarà Joseph Alois Schumpeter a celebrare, la “distruzione creativa” indotta dal capitale come il «processo di mutazione industriale che rivoluziona incessantemente la struttura economica dall’interno, distruggendo senza sosta quella vecchia e creando sempre una nuova».
Tecnicamente, un “reset” è un re-inizio: nel linguaggio informatico, la parola significa cancellare tutta la programmazione pregressa per un nuovo riavvio dell’elaboratore. Trasposto all’attività umana, significa una trasformazione profonda e radicale di tutto ciò che fino a quel momento, si faceva e si pensava comunemente. Il tema del prossimo simposio di Davos, ad appannaggio delle oligarchie tecnocratiche e finanziarie in sintonia con la nuova presidenza statunitense, l’Unione Europea e quella ampia fetta di mondo legata alla catena di valore della occidentalizzazione sarà appunto il “great Reset” inteso a governare i radicali cambiamenti nell’era post-epidemia. La definizione fu usata per la prima volta come titolo del libro The Great Reset: How the Post-Crash Economy Will Change the Way We Live and Work di Richard Florida, pubblicato nel 2010 in seguito alla crisi economica del 2008; il libro proponeva cambiamenti profondi che, partendo dall’economia, ristabilissero un equilibrio smantellato dal capitalismo neoliberale che ha modellato il mondo negli ultimi decenni. Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum nel 1971, e Thierry Malleret partono dallo stesso concetto nel loro recente Covid-19: The Great Reset che esamina i cambiamenti necessari ad uscire dalla crisi conseguente alla epidemia e propone modelli di gestione della società che proseguono idealmente il percorso indicato nel libro di Florida. Si tratta di ricalibrare un obiettivo comune: l’estensione del libero commercio globale, l’istituzione di regole mondiali capaci di sostituire il processo decisionale sovrano dei diversi popoli e, appunto, la promozione della uniformità inclusiva dei diritti civili per «trasformare le economie e le società», come affermano gli stessi autori e organizzatori degli incontri di Davos. In pratica, l’evento epidemico è il fattore di rottura epistemica e operativa per transitare il sistema mondo capitalistico nella quarta rivoluzione industriale e conseguente disintermediazione sociale dell’individuo. Dietro le quinte dell’ordinatore economico si tratta di un esplicito adattamento antropologico.
Tale impostazione presuppone a sua volta una sorta di nuova gerarchia dei poteri tra i poteri, di cui il World Economic Forum si pone come centro intelligente, come luogo di costruzione e gestione di una nuova immagine del mondo e sua narrazione condivisa tra chi vuole mantenere il proprio potere egemonico. Tale posizione è universalistica, cosmopolita-ecumenico-umanitaria, liberale e liberista di massa, globalista, ambientalista, vettoriale, progressista, ponendo la forma capitale non solo nelle condizioni assertive date, ma capace di socializzarsi e assumere una responsabilità politica mondiale con la volontà di costituire un centro sistemico governante. Coopta gli interessi possenti del futuro (fatto di finanziarizzazione, digitalizzazione, rizoma informatico, biotecnologia, delocalizzazione, logistica e polverizzazione sociale in remoto), capaci di sussumere l’obsoleto vecchio sistema di accumulo del capitale industriale elettro-meccanico basato sullo sfruttamento controproducente di energie carbonifero-petrolifere da sostituire con fonti energetiche difformi e durevoli.
Il sociologo Zygmunt Bauman è stato probabilmente uno dei più accreditati pensatori negli ultimi decenni nel descrivere il processo di occidentalizzazione del mondo come perdita di certezze. La solitudine del cittadino globale ha descritto un essere umano non più produttore del suo tempo storico ma spettatore edonista sradicato della società dei consumi. La metafora della società liquida – che poi oggi potremmo azzardarci a definire addirittura “aeriforme” – è diventata universale, d’altronde non meno felice l’immagine dell’uomo occidentale come passeggero di un aereo «che si accorge che la cabina di comando è vuota e che la voce rassicurante del capitano suona come la ripetizione di un messaggio registrato». In realtà, vi è del compiaciuto in quelle metafore calzanti, nel momento in cui l’autore ha letto tale deriva come connaturata all’incedere del relativismo nichilista liberal-democratico, ponendo l’individualismo di massa come orizzonte irreversibile del cosmopolitismo apolide, tanto da stigmatizzare qualsiasi declinazione comunitaria del bene comune, portatore – per il pensatore polacco tardo illuminista – del peccato capitale di una identità collettiva forte, quindi populistica e politicamente sovranista.
Meno conosciuto al vasto pubblico un altro sociologo, Ulrich Beck – anch’esso scomparso qualche anno fa – che invece risulta all’oggi assai più persuasivo e meno scontato nell’analisi della modernità, di cui non vede una irreversibile linearità giustificata dal determinismo del progresso. Scrive La società del rischio influenzato dalla cultura ecologista mitteleuropea e dalla esplosione della centrale nucleare di Cernobyl nel 1986, in cui pone il processo di civilizzazione esposto strutturalmente alla rottura e discontinuità paradigmatica, sia sul piano teorico che su quello materiale. Non esistono «le magnifiche sorti e progressive» liberal-social-democratiche che emancipino tutto e tutti dalla cogenza della realtà, emarginando la decisione politica al cospetto di una mera amministrazione funzionale dell’esistente. La tecnica non risolve i problemi da essa creati, né tantomeno riduce a sé la natura e la dinamica entropica della trasformazione dell’ambiente. Vi è anzi un rapporto inversamente proporzionale tra la capacità di governo della società contemporanea e i pericoli da essa ingenerati e, in particolar modo, che il rischio e la rottura di equilibrio non sono il prodotto del passato, della superstizione, cioè delle sconfitte della modernità, ma proprio paradossalmente delle sue vittorie. Scriverà, ad esempio, due decenni dopo che «il mutamento climatico è un prodotto dell’industrializzazione riuscita che ha conseguenze sistematiche per la natura e per l’essere umano». Non è una questione di mera redistribuzione che affligge il modo di produzione capitalistico, ma della sua essenza, lo sviluppo illimitato, il prometeismo.
In tal senso, è possibile far conciliare i limiti della natura e il progresso economico? Esiste davvero uno sviluppo sostenibile? Una risposta condivisibile su questo ossimoro è già riassunta nell’efficacia del titolo di un recente saggio a cura di Giuseppe Giaccio, Serge Latouche, Frédéric Dufoing: Ecologia/economia. Una alleanza im/possibile. L’ecologia ha un lato conservatore e un lato rivoluzionario. È eminentemente conservatore in quanto cerca di salvaguardare la natura delle cose e proteggere l’equilibrio degli ecosistemi. Ma è rivoluzionaria se intende olisticamente che non invertiremo la tendenza attuale con misure funzionali, ma ritornando ai fondamenti, al principio. È il paradigma generale che deve essere cambiato. Questo aspetto può scandalizzare solo la narrazione dominante del pensiero unico liberale e, in generale, tutti quelli che pensano che il mondo possa morire finché l’esistenza umana rimanga governata dal nichilismo tecnocratico e la mercificazione di uomini e cose, mentre noi continuiamo a obbedire alle “leggi dell’economia”, fondate sulla pretesa titanica dello smisurato.
Dalle colonne di questa pubblicazione, fin dall’inizio dello stato di eccezione e regime sanitario, ci si interroga legittimamente – con le voci più autorevoli – sui condizionamenti prodotti nella personalità individuale e sulla identità collettiva del corpo sociale sottoposto alla passivizzazione “vegetale” della dignità umana. La paura securitaria e la mera autoconservazione si introducono profondamente nell’animo umano e lo conformano a sé, sminuendo la libertà spirituale, generando abitudine alla sottomissione, serialità, reificazione, fobia dell’altro, eterodirezione, dipendenza dal comando. Stiamo sicuramente vivendo una transizione epocale, ma proprio per questo va declinata in modo complementare e opposto al determinismo progressista, all’inerzia del materialismo pratico e alle metamorfosi della forma capitale mondiale. La sovranità politica è l’unica legittima espressione della volontà popolare comunitaria, il bene comune come partecipazione, responsabilità, sostenibilità, giustizia, misura. Bisogna certamente auspicare una metanoia, un mutamento di paradigma, ma come inversione di tendenza, contrastando apertamente la mistificazione operata dai centri di potere che dettano le priorità di un processo di civilizzazione quantitativo, quindi entropico e suicida. Ognuno di noi è chiamato a tale sforzo che è basato sulla intenzionalità, cioè l’opposto dell’asservimento al totalitarismo pervasivo dei nostri tempi: la riduzione all’unico, all’identico, all’atomico.