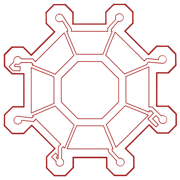In Afghanistan ritiratesi le truppe occidentali occupanti, dopo venti anni della guerra più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti (e i suoi alleati), il Paese torna sotto il governo dei talebani; in Iraq la guerra del 2003 contro Saddam Hussein fece precipitare il Paese e il Medio Oriente nel caos da cui venne partorito l’ISIS e il fanatismo del terrorismo islamista; la guerra alla Libia del 2011 contro Mu’ammar Gheddafi ha devastato e ora spartito il Paese tra la Turchia neo-ottomana di Recep Tayyip Erdoğan e l’Egitto del generale Abdel Fattah al-Sisi; in Siria la guerra jihadista figlia anche dell’ingerenza occidentale ha distrutto un intero Paese, causando 500 mila morti e contribuito alla instabilità generale del Mediterraneo. Cosa l’Italia e l’Europa, direttamente o indirettamente coinvolte, abbiano avuto da guadagnare in questi interventi militari? È sotto gli occhi di tutti e sottolinea una volta ancora la necessità che il continente europeo miri al fine di emanciparsi dalla subalternità atlantica in un contesto geopolitico multipolare, favorendo relazioni internazionali multilaterali. La sovranità neutrale dell’Europa significa ritornare nella storia, assumersi la responsabilità della propria difesa, in alleanza continentale con chi intende un mondo plurale, sostenibile, capace di ricomporre il divario tra cultura e natura, dato il suicida progetto della forma capitale di una crescita illimitata in una Terra finita. Di questo è ben consapevole Gastone Breccia, nel suo recente saggio Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in Afghanistan. Il 7 ottobre 2001 gli Stati Uniti attaccarono l’Emirato Islamico dell’Afghanistan, allora recente creazione del movimento dei talebani che avevano ospitato e protetto il gruppo estremista al-Qa’ida e il suo capo Osama bin Laden, responsabili dell’attacco contro le Twin Towers. Oggi, che la guerra sta per concludersi, vengono meno le speranze di costruire un paese stabile, di imporre dall’esterno la democrazia, capace di integrarsi nell’economia globale. Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato non soltanto non sono riusciti a piegare la resistenza dei talebani e a produrre ordine e sicurezza in Afghanistan, ma hanno perso buona parte della loro credibilità militare e politica. In tal senso, quali considerazioni storiche possiamo dedurre dagli eventi in corso in quell’angolo tanto remoto quanto rilevante dei destini della politica mondiale, in cui i più deboli stanno avendo la meglio sui più forti? Un luogo caratterizzato da una umanità severa, basata sul rispetto di sé, dove non ci si lamenta di nulla, anche dell’indicibile di decenni di guerra senza soluzione di continuità, ignari di qualsiasi vittimismo.
La guerriglia può essere descritta nella sua essenza, con una definizione concisa e immediata utile a comprendere questo tipo di conflitto dai contorni sfuggenti, come l’asimmetrica lotta del debole contro il forte. Il glossario della guerriglia, tuttavia, si compone di molti attributi, necessari per circoscrivere quest’arte bellica che, a ogni latitudine nel contesto moderno, si presenta come indiretta, dinamica, elusiva, flessibile, rapida e invisibile, oggi definita ibrida… La guerriglia è perciò un fenomeno che non si esaurisce nella semplice dialettica “debole vs forte”. «Occorre operare da partigiani ovunque vi siano partigiani», esortava Napoleone nel tentativo di rispondere alla guerriglia spontanea, che da anni, in Spagna, teneva in scacco la più imponente e perfezionata macchina militare dell’epoca. Napoleone e i suoi contemporanei non potevano saperlo, ma con quei guerrilleros aveva fatto irruzione sulla scena la figura, che ne avrebbe rivoluzionato il corso. E di questa figura conosciamo l’analisi stringente fatta nel 1962 da Carl Schmitt in Teoria del partigiano, dove si illustrano i caratteri distintivi del combattente “irregolare”, ossia di colui che «si è posto al di fuori dell’inimicizia convenzionale della guerra controllata e circoscritta per trasferirsi in un’altra dimensione: quella della vera inimicizia». Muovendo dunque dal remoto progenitore spagnolo, Schmitt arriva alla contemporaneità e in modo lapidario scrive che «la guerra dell’inimicizia assoluta non conosce alcuna limitazione. Trova il suo senso e la sua legittimità proprio nella volontà di arrivare alle estreme conseguenze. La sola questione è dunque questa: esiste un nemico assoluto, e chi è in concreto?». Si può però dire che solo oggi siamo in grado di misurare la pervasività planetaria del fenomeno. Anche oggi non v’è area del globo che ne sia immune. Gastone Breccia già lo aveva ben argomentato ne L’arte della guerriglia, dove racconta la guerriglia così come è stata teorizzata o praticata – da Sun Tzu a Clausewitz, da Lawrence d’Arabia a Che Guevara – ripercorrendo vicende concrete, relative alla resistenza degli Indiani d’America, al Vietnam, all’Algeria, alla Cecenia e da ultimo all’Afghanistan, di cui l’autore ha potuto avere esperienza diretta e su cui proietta un’analisi aderente, vera summa enciclopedica della prassi bellica irregolare.
Il guerrigliero è tellurico, le sue ragioni sono radicate nella terra che difende o nella causa che – per quanto universale – si declina in un territorio, ma agisce come l’acqua che, per dirla con Lao Tze, è cedevole e fluida, non può essere distrutta e riesce a penetrare anche nel metallo e nella pietra: «Niente esiste al mondo più adattabile dell’acqua. E tuttavia quando cade sul suolo, persistendo, niente può essere più forte di lei». Non è un caso, quindi, che la definizione teorica più concisa e attagliata al risvolto operativo della guerra di guerriglia l’abbia formulata Mao Zedong, quando ha scritto che «nella guerriglia, bisogna scegliere la tattica di far finta di venire da oriente e attaccare da occidente; evitare il solido e attaccare il vuoto; aggredire, ritirarsi, infliggere un colpo con la rapidità del lampo, cercare una soluzione fulminea. Se i guerriglieri affrontano un nemico più forte, si ritirano quando avanza, lo disturbano quando si ferma, lo colpiscono quando è stanco, lo inseguono quando si ritira»; un altro “letterato” di una guerra alternativa allo scontro frontale, T.E. Lawrence, evoca l’uso dell’astuzia anziché della forza, con l’asserzione sulla guerriglia come «più intellettuale di un assalto alla baionetta».
Sul piano dell’azione, nel confronto con la superiorità avversa, tatticamente la guerriglia richiede profonda conoscenza del territorio, rapidità e sorpresa dell’agire, mimetismo notturno e/o del contesto naturale, piuttosto che urbano; il “terrore”, il combattere “senza quartiere” – come si usava dire fin dal XVIII secolo – getta il soldato regolare in una condizione cui è impreparato e può indebolirne in modo fatale la tenuta psicologica nei momenti apicali dello scontro. Relativamente a quest’ultimo punto, in teoria, potremmo ascrivere la figura del terrorista nell’ambito della criminologia e quella del guerrigliero nell’arte della guerra. In realtà, le cose sono più complesse: l’asimmetria oggettiva – in fatto di tecnologia e potenza di fuoco – tra le parti in causa non consente di trovare un terreno comune neanche per ciò che riguarda il riconoscimento reciproco e la liceità (o meno) dei mezzi di lotta. In un conflitto, in cui solo una parte possiede armamenti strutturati e una superiorità tecnologica imparagonabile, la guerriglia adopera qualsiasi espediente – si pensi, ad esempio, agli ordigni esplosivi improvvisati, più comunemente conosciuti come IED (Improvised Explosive Device), disseminati in ogni dove del Medio Oriente – per colpire. In un conflitto, in cui le forze armate occupanti provocano sistematicamente vittime civili con bombardamenti da alta quota pilotati in remoto, non si può pensare che gli insorti limitino le proprie azioni a prendere di mira i soli militari nemici in uniforme; in tal senso, il termine terrorismo diviene più un appellativo propagandistico che un correlativo oggettivo della realtà di un conflitto asimmetrico che è lo specchio di una violenza indistinta in cui è ben difficile distinguere le parti del barbaro e del presunto “civilizzato”. Un conflitto, poi, si protrae nel tempo e nello spazio, facendoci quindi entrare nella strategia della guerra di guerriglia. La determinazione a lottare senza una limitazione temporale è decisiva. La guerra convenzionale e di apparato tecnologico-industriale necessita della brevità risolutiva; specularmente, la guerriglia si alimenta nella dilazione dell’azione al fine di logorare la superiorità militare del nemico. Anche lo spazio – l’estensione geografica in cui si applica la proiezione dell’attrito bellico guerrigliero – ha un valore strategico determinante: un territorio sufficientemente ampio, con aspetti accidentati e financo impervi, è difficile e oneroso da presidiare, così come è adatto a colpire repentinamente con efficacia, per poi ritirarsi con adeguato margine di sicurezza e continuare la lotta ad libitum.
Come sopra indicato, l’autore applica la sua puntuale ricostruzione storica anche in un terzo pregevole volume, Le guerre afgane. Dal “Grande gioco” degli imperi ottocenteschi, che ha contrapposto Gran Bretagna e Russia, fino ad oggi: due secoli di conflitti nell’inospitale quanto strategico cuore dell’Asia Centrale, nel corso dei quali sono emersi spesso i lati più oscuri della politica delle grandi potenze coinvolte nella “selvaggia terra degli afgani”, in cui la guerriglia è una costante e una realtà senza soluzione di continuità dal 1978; essa infatti iniziò come opposizione alla “modernizzazione” imposta dal Partito Democratico del Popolo dell’Afghanistan, marxista e filosovietico, che aveva appena conquistato il potere, e proseguì poi come “guerra santa” contro le truppe dell’Armata Rossa, entrate nel Paese per sostenere il nuovo governo di Babrak Karmal. Dieci anni dopo, quando i sovietici lasciarono l’Afghanistan, incalzati dai guerriglieri condotti dal carismatico Ahmad Shah Massoud, la jihad si trasformò in una guerra aperta per abbattere il regime di Najibullah, il successore di Karmal; ottenuta la sua caduta (aprile 1992), il conflitto continuò nella confusa lotta tra le varie fazioni dei mujahidin, in cui si affermarono i talebani, gli “studenti coranici” sostenuti dal Pakistan, che raccolsero consenso tra la popolazione ripristinando l’ordine e imponendo con inflessibilità la legge coranica (shaaria). L’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle provocherà l’intervento militare statunitense, finalizzato ad abbattere il regime talebano, accusato di avere ospitato e protetto Osama Bin Laden e la sua organizzazione. Da allora, dopo la rapida conquista, la coalizione occidentale viene impegnata in una estenuante guerra a bassa intensità, di cui, dopo venti anni siamo all’epilogo della cosiddetta “guerra umanitaria” e assistiamo ora al ritiro delle truppe occidentali con una fine ingloriosa del regime “collaborazionista” di Hamid Karzai prima e Ashraf Ghani adesso.
In tal senso, risulta interessante il libro di William Dalrymple, Il ritorno di un Re, che ricorda come già 170 anni fa si sia combattuto aspramente tra le montagne dell’Hindu Kush. Vi si narra in modo rigoroso – utilizzando fonti originali anche indiane, afghane e persiane – uno dei momenti più drammatici di quello che Rudyard Kipling definì il «grande gioco», la sfida senza esclusione di colpi tra Londra e Mosca per il controllo delle vie commerciali per l’Asia nella prima metà dell’Ottocento. In realtà, però, il lettore è spinto di continuo a riflettere su modalità e conseguenze della invasione dell’Afghanistan a caccia di Al Qaeda, di Bin Laden e del mullah Omar e l’imposizione del modello occidentale alle etnie afghane. «La storia non ripete sé stessa. Eppure, l’attuale disastroso coinvolgimento occidentale nel Paese ricorda molto da vicino la catastrofe coloniale di allora», ammette l’autore. Le similitudini sono incalzanti: l’incapacità di comprendere e fronteggiare la realtà tribale locale; il disprezzo per i valori tradizionali afghani; la convinzione, tuttavia presto smentita dalla durezza della resistenza opposta dalle popolazioni locali, che la campagna sarebbe stata una “scampagnata”. Da qui la facile vittoria iniziale e l’impossibilità fattiva di consolidarla. Nel 1840, dopo aver raggiunto Kabul, gli alti comandi inglesi sottovalutarono la capacità di ripresa delle tribù pashtun e tagike e sguarnirono i presidi per andare a combattere la prima Guerra dell’Oppio in Cina. Esattamente come, nel 2003, l’amministrazione Bush si lanciò nell’aggressione all’Iraq, abbandonando l’Afghanistan al suo destino. L’autore non ha alcuna remora nel denunciare l’immensa crudeltà della repressione: «I comandi inglesi furono responsabili di errori clamorosi e gli attacchi dei loro soldati contro i civili per vendicare i propri morti furono peggio delle torture inflitte dai guerriglieri afghani ai prigionieri»; infine, nelle ultime pagine trae le logiche conclusioni: «Più avanzavo nelle mie ricerche per la preparazione del libro, più il primo disastroso coinvolgimento occidentale nel teatro afghano mi sembrava contenere l’eco delle avventure neocoloniali dei nostri giorni». Il suo parallelo tra le due “avventure” si estende anche alle dinamiche del ritiro, ora all’ordine del giorno. La NATO sta uscendo dal Paese e Dalrymple sentenzia: «Nel 1842 gli Inglesi sarebbero potuti restare. Ma l’impresa costava troppo, il gioco non valeva più la candela».
Così sono andate le cose in Afghanistan anche due secoli dopo. I guerriglieri talebani hanno dimostrato un decisivo vantaggio sulle forze convenzionali cui si oppongono: non hanno timore di morire, particolare non accessorio in guerra. Sono motivati da un’etica guerriera tradizionale, che li rende moralmente superiori alla rimozione occidentale della morte, quindi alle perdite in combattimento. Scrive Gastone Breccia: «Negli sguardi degli uomini che osservano impassibili i soldati occidentali, protetti da elmi e corazze antiproiettile, mentre avanzano con estrema cautela tra le case del loro villaggio, temendo a ogni passo un agguato, si può leggere facilmente un misto di fastidio e disprezzo; e quegli stessi sguardi dicono, senza bisogno di parole, che un nemico così ossessionato dalla propria sicurezza non potrà che abbandonare la lotta, perché non è disposto a sacrificarsi per vincere». Nei rapporti di forza del conflitto asimmetrico, l’ossessione per le operazioni a zero casualties (“perdite zero”) induce gli Stati maggiori “democratici” e “umanitari” a programmare interventi dal costo economico esorbitante, che finiscono così per rendere insostenibile, nel lungo periodo, l’intera campagna; inoltre induce i comandi sul campo a richiedere sistematicamente l’appoggio aereo o il fuoco indiretto dell’artiglieria e, quindi, a seminare la morte tra i civili, cosa che – indipendentemente dalla sua enormità a livello etico – rende controproducente l’utilizzo stesso della forza nella conquista dei “cuori” della popolazione; infine, l’ossessione per la sicurezza dei soldati occidentali offre un vantaggio insuperabile ai guerriglieri che, anche se scalzi e armati inadeguatamente, percepiscono intimamente la propria superiorità morale. Il funzionalismo tecnico si affanna frustrato a inseguire un risultato dietro le lancette degli orologi, i ribelli non si preoccupano dello scorrere del tempo, vincono la morte e attendono – per logoramento – il maturare della sconfitta dell’occupante, consapevoli del fatto che devono soltanto aspettare e sopravvivere abbastanza a lungo – ormai non molto a lungo, per la verità – prima di trovarsi ad affrontare solo le truppe governative, inadeguate al compito che si prospetta.
Vale la pena allora di non sottrarsi alla evidente lezione dagli eventi in corso, che non rimanga presuntuosamente inascoltata in Occidente, dove la prepotenza dei rapporti di forza materiali rende insensibili sul piano etico, nella deriva nichilistica della modernità. L’Afghanistan non è mai stato lontanamente Occidente e mai lo sarà, con o senza Talebani. Ben diceva Ivan Illich in Nello specchio del passato che «la guerra tende ad uguagliare le culture, mentre la pace è la condizione in cui ciascuna cultura fiorisce nel proprio modo incomparabile. Da ciò ne segue che la pace non è esportabile: inevitabilmente la si deteriora nel trasporto, il tentativo stesso di esportarla significa guerra». L’alternativa – su cui conveniamo – è una visione realistica, conflittuale e policentrica, che rivaluti il rapporto fra principi e identità culturali, fra neutralità e autodeterminazione, fra tutela delle libertà e sovranità politica.
La repentina ritirata occidentale dall’Afghanistan ci dice di più del singolo evento storico. La globalizzazione e gli universalismi non sono più il contesto della realtà, ma un portato ideologico. Siamo in una transizione epocale e su scala mondiale si stanno ridistribuendo le carte, un nuovo Nomos della terra. Il ruolo che avrà l’Europa in tutto ciò è un enigma a sé esistenziale. Parafrasando Nietzsche, l’Europa si farà nel rischio della sua venuta meno, cioè al cospetto del tramonto occidentale.