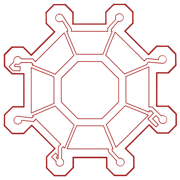Inevitabile. È questa la parola chiave attorno alla quale ruota la maggior parte dei dogmi su cui si fondano l’ideologia oggi dominante e l’azione di proselitismo che vi si accompagna. Ogni fenomeno che intervenga a modificare, o a sconvolgere, il modo di vivere o di pensare che si è consolidato nel tempo fra la “gente comune” all’interno di una collettività finisce …
Inevitabile. È questa la parola chiave attorno alla quale ruota la maggior parte dei dogmi su cui si fondano l’ideologia oggi dominante e l’azione di proselitismo che vi si accompagna. Ogni fenomeno che intervenga a modificare, o a sconvolgere, il modo di vivere o di pensare che si è consolidato nel tempo fra la “gente comune” all’interno di una collettività finisce col trovare la sua accettazione – prima – e la sua consacrazione – dopo – grazie all’applicazione di questo aggettivo da parte dei “leaders di opinione”. È la formula magica del progressismo, la visione del mondo che sin dalla sua nascita, nella celebrata “epoca dei Lumi”, ha puntato a scalzare l’assetto delle società basate sulle tradizioni per imporre nuovi criteri di valore. Primo fra tutti, come il termine da cui è derivato fa capire, la convinzione che ciò che viene dopo, nella dinamica di sviluppo degli eventi, sia sempre e comunque migliore di quel che c’era prima. Un passo in avanti nella direzione segnata – ecco un’altra espressione cruciale – dal «vento della Storia». Che è quello che gonfia le vele delle élites intellettuali, chiamate a sollevare il popolo ignorante dalla sua congenita pigrizia e a portarlo ad accogliere come positiva ogni novità.
Molto più del marxismo, oggi più in rotta che in ritirata, è questo sistema di credenze, veicolato in maggiore o minore misura da tutte le versioni del liberalismo ed incardinato sulla sua antropologia individualistica, a costituire lo “zoccolo duro” dell’egemonia politico-culturale che oggi detta legge e, secondo i casi, include o esclude dal dibattito pubblico le voci che mirano ad esservi ascoltate. È in ordine ai suoi parametri che dagli schermi televisivi e cinematografici, dalle pagine dei giornali e dei romanzi, dagli apparecchi radio, dai palchi dei concerti musicali, dalle mostre d’arte e da ogni altra fonte comunicativa – oltre che, è bene non dimenticarlo, dalle aule delle scuole, delle università e dei tribunali, dove la giustizia è amministrata non solo in nome di un’astratta giustizia ma anche e non di rado soprattutto secondo le convinzioni e le interpretazioni ideologiche dei singoli magistrati – ci vengono impartite le direttive per distinguere il Bene dal Male. Relegando dalla parte sbagliata e bollando come passatista, reazionario, ottuso chiunque si ostini a non piegarsi al credo ufficiale.
Gli esempi che illustrano questa situazione sono ormai innumerevoli e forniti a ritmo quotidiano. Per coincidenza, proprio nel momento in cui stavamo scrivendo queste righe ce ne è capitato sotto gli occhi uno – l’intervista ad Alain de Benoist pubblicata dal quotidiano «La Stampa» che riportiamo nelle pagine seguenti – che ne fornisce un catalogo particolarmente efficace.
Le domande dell’intervistatrice sciorinano un impressionante rosario di luoghi comuni desunti dal vademecum del perfetto progressista, dove l’ipotetica inevitabilità dei fenomeni da lei considerati positivi fa la parte del leone. Inevitabile, e quindi ingovernabile, incontrollabile e globale – di nuovo, una parola-talismano – è l’immigrazione di massa, per cui la volontà di contrastarla non può che essere dettata dalla «paura del diverso, dell’altro da sé». Inevitabile è l’ibridazione dei popoli, perché «tutti siamo figli di un miscuglio di culture e di incroci e di migrazioni» (e, s’intende, ogni cultura e ogni migrazione vale l’altra: europei, asiatici, africani… il melting pot è la regola) e, di conseguenza, la famigerata sostituzione etnica non può esistere (forse sarebbe il caso di chiedere informazioni in merito ai residui serbi del Kosovo). Inevitabile è accettare «identità che non sono canoniche» e il principio secondo cui «ognuno è ciò che vuole essere», e dunque sottoscrivere, in spregio delle leggi di natura, la teoria del genere, perché quest’ultimo «chi lo deve decidere, se non l’individuo?». E inevitabile è accogliere tutte le rivendicazioni Lgbtq+, a partire dai matrimoni omosessuali, perché chi non lo fa dimostra di avere «paura del futuro. Ha sempre uno sguardo rivolto al passato, si rifugia in una cultura di nicchia […] non riesce ad affrontare i temi più attuali, posti da una società che cambia».
Già: la società che cambia. La maggiore astuzia degli alfieri del progressismo è di far credere che i cambiamenti della società e dei modi di pensare che si diffondono nell’immaginario collettivo siano spontanei, automatici, logici. Inevitabili, appunto. Nascondendo il fatto che essi sono il prodotto di intenzioni, di azioni, di progetti, di conflitti che vedono vincitori e vinti, assai più che di casualità od evoluzioni spontanee. E che, pertanto, la rappresentazione del divenire storico che sottostà alle loro affermazioni è pura mistificazione.
Per sincerarsene, basta spostare lo sguardo dalla contemporaneità e fissarlo su quanto accadeva un po’ più e un po’ meno di un secolo fa. Quando in Europa la grande cultura di inizio Novecento – ma la tendenza durava già da alcuni decenni: le ricerche di Zeev Sternhell, partendo dalle vicende francesi ma non limitandosi ad esse, ne forniscono adeguata documentazione, ma non sono certo le sole – riteneva esaurite le spinte utopiche della filosofia illuminista e ne giudicava disastrosi gli effetti, spendendo parole caustiche sulla “ribellione delle masse” e il “tramonto dell’Occidente” che trovavano eco tanto nei circuiti accademici quanto negli ambienti artistici di avanguardia, che celebravano all’unisono le esequie sia del “vecchio mondo” liberale e borghese sia di un socialismo esangue e incapace di tradurre in realtà le promesse tanto generosamente sparse, che Georges Sorel e sodali spingevano a depurarsi e rinvigorirsi ricorrendo alla violenza e alla forza dei miti. Di lì a poco, a proclamare di voler fare piazza pulita del passato e a decretare la fine di un ciclo storico mai più riproducibile sarebbero stati i movimenti e poi, in alcuni paesi, i regimi fascisti, che si proclamavano interpreti della volontà e delle aspirazioni dei “popoli giovani” e relegavano gli avversari al ruolo di protettori di un ordine costituito liberal-democratico ormai scricchiolante e marcio nelle fondamenta. E quelle loro categoriche affermazioni avrebbero trovato larga eco, e una sostanziale condivisione, in molte altre aree del globo: dagli Stati Uniti all’India e perfino alla Cina, passando per l’America Latina e i paesi arabi.
Ebbene: che ne è stato di quello spirito del tempo, di quell’atmosfera, di quella effervescenza degli anni della belle époque e dei decenni successivi, che legava il concetto di rivoluzione non ai Lumi o all’Ottantanove, ma al rovesciamento dei princìpi cui entrambi si erano richiamati, dopo la fine della seconda guerra mondiale? Solamente macerie. Su cui gli sconfitti dell’allora recente passato – comunisti, liberali, socialdemocratici, alcuni settori del mondo cattolico – hanno, interpretando consciamente o inconsapevolmente la lezione gramsciana, edificato passo dopo passo il sostrato della futura egemonia.
La storia, come si può ricavare da queste brevi considerazioni, non ha una direzione precostituita e guidata da volontà metafisiche, da un senso superiore e quasi di ispirazione divina. È il campo di scontri continui, che attraversano nazioni e continenti e si dispiegano su più livelli, dal confronto delle idee nelle sedi intellettuali alle partite geopolitiche, dalle guerre che si combattono con le armi sul terreno a quelle mediatiche che attraversano l’etere e a quelle che hanno come teatro le borse e come risorse i flussi finanziari e le speculazioni. In questo contesto, le dispute politiche svolgono una funzione senz’altro rilevante ma tutt’altro che decisiva, perché i loro attori sono oggi più che in ogni epoca precedente condizionati dai fattori e dai risultati degli altri conflitti paralleli.
Questa verità ci viene ricordata ogni giorno dai commenti che i mezzi di comunicazione ci riversano addosso, prendendo spunto dagli argomenti più disparati, perché l’ideologia egemone non trascura alcun canale, alcun tema, alcun pretesto per manifestarsi. Il filo rosso dei suoi riferimenti di valore si dipana in questo periodo, come ancora di recente abbiamo ricordato, soprattutto attraverso la costruzione dell’immagine idealizzata di un Occidente liberale terra di tutte le virtù e le libertà – di fatto, essenzialmente quelle individuali – contrapposta alla caricatura di un Nemico poliforme, una sorta di piovra dai molti tentacoli, identificata come autoritarismo e caricata di ogni ludibrio, oltre che sospettata di aver disseminato i propri agenti nel campo avverso.
È sulla base di questa raffigurazione scenografica e propagandistica che l’ideologia progressista esercita la sua strategia egemonica, coinvolgendovi non solo le sue abituali pedine ma anche alcuni settori di una sinistra che vorrebbe ancora immaginarsi rivoluzionaria e certi ambienti di destra che pure credono di potersi dire conservatori. Facendosi casse di risonanza delle retorica dei diritti umani, trasformando in dittatori o despoti tutti i governanti che, pur essendo stati eletti in regolari consultazioni popolari, non sono di loro gradimento – i casi di Putin e di Erdogan non sono che i più recenti di una lunga serie –, agitando per apparire più graditi alla Casa Bianca lo spauracchio di una Cina ansiosi di divorarsi militarmente ed economicamente il resto del mondo, tutti costoro si consegnano ad un futuro di sudditanza non soltanto a quella che a tutt’oggi è l’unica superpotenza mondiale, ma anche all’ideologia che, svuotando le identità degli altri popoli e indebolendo i legami delle loro società, ne assicura, con il suo soft power, il dominio.
Si spiega così perché oggi i media di tutta Europa si facciano instancabilmente eco degli spettacoli di propaganda di Zelensky e continuino ad alimentare la leggenda delle “interferenze decisive” degli inafferrabili hackers russi in ogni elezione persa dai beniamini di Washington (negli scorsi giorni abbiamo letto addirittura della «cambiale che ora Erdogan dovrà pagare a Putin per l’aiuto ricevuto»…). E perché, contemporaneamente, tramite la giaculatoria dei “diritti”, dell’”inclusione” e del “dovere di umanità” – rafforzata dall’improvvido intervento di autorevoli voci “spirituali”, che della vera partita in gioco sembrano non aver colto né la sostanza né le forme – e con il consueto ricatto emotivo della compassione e della commozione, quegli stessi mezzi di (dis)informazione stiano tentando (con un certo successo, specialmente fra le generazioni più giovani, allevate sin dalla più tenera età a interiorizzare il Verbo da insegnanti che fanno dell’indottrinamento la propria missione) di inculcare nel pubblico la convinzione che il futuro di pace, felicità e prosperità dell’umanità sarà assicurato solo dalla cancellazione di ogni tipo di diversità dalla faccia della Terra. Cioè dall’omologazione di individui, popoli e culture ad un unico parametro: quello stabilito dall’Impero del Bene e dai suoi rappresentanti. Indispensabile alla riuscita di questo progetto è convincere quello stesso pubblico che, anche se questo futuro può apparire sgradevole, niente ne potrà impedire la realizzazione. Così come prevedeva Francis Fukuyama quando profetizzò la fine della storia come stadio conclusivo del processo di civilizzazione del genere umano.
Battersi per impedire che questa mistificazione penetri nelle menti dei nostri contemporanei è il compito che spetta a tutti coloro che ne hanno compreso la pericolosità. Con le risorse delle quali dispongono, molte o – come è nel nostro caso – poche che siano. Perché solo così si combattono le egemonie.
Marco Tarchi