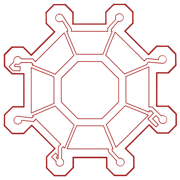Dove finisce l’Europa, dove inizia l’Occidente? È una delle domande affrontate nel primo numero del «Cahier d’études pour une pensée européenne» (La Nouvelle Librairie), la rivista del Pôle Études de l’Institut Iliade. Abbiamo intervistato l’accademico Walter Aubrig, uno dei due coautori dello studio intitolato «Européens hors d’Europe. Où en sommes-nous de l’Occident?», per risolvere questa spinosa questione. Lo trovate anche sull’ultimo numero di «Éléments» attualmente in edicola.
François Bousquet
ÉLÉMENTS: La questione dell’Europa e dell’Occidente agita, se non addirittura lacera, gli ambienti identitari, spesso a partire da un divario generazionale, con i più giovani che generalmente si richiamano all’occidentalismo. Avevi in mente questa divisione quando hai iniziato a scrivere questo studio? Se sì, cosa ti ha ispirato? Più in generale, quali questioni di civiltà concerne questa frattura?
WALTER AUBRIG: Questo articolo è per molti versi l’estensione di una riflessione già iniziata nel 2022, quando il contesto internazionale che conosciamo aveva dato luogo a un’improvvisa ripresa dei vecchi riflessi atlantisti. Va tuttavia sottolineato che, nella sua forma attuale, questo lavoro, volutamente, non ha principalmente uno scopo geopolitico. Questa dimensione è stata trattata con grande acutezza e discernimento da Max-Erwann Gastineau, nella lunghissima intervista al Cahier d’Études. Piuttosto, la nostra intenzione con questo articolo è quella di affrontare la questione fondamentale dell’identità. Perché è anche e forse soprattutto di questo che parliamo quando oggi parliamo di Occidente. Mettere in discussione questa terminologia non significa decidere a favore o contro una scelta strategica. Si tratta infatti, più semplicemente, di chiedersi cosa c’entrano ancora gli Europei con l’Europa. In questo dilemma, molto più che in una situazione globale che va affrontata soprattutto con freddo pragmatismo, si riflette sotto molti aspetti la crisi d’identità di una generazione. Una generazione che cerca risposte nelle ragioni contraddittorie messe a sua disposizione, attraverso i «contenuti» più diversi. Essa mantiene un rapporto complesso e composito con questa questione, nel quale anche la provocazione sembra giocare un ruolo importante. Esiste quindi innegabilmente un problema, soprattutto perché l’eterogeneità delle posizioni lascia spazio a tutte le possibilità.
Naturalmente sarebbe illusorio pensare che un articolo di giornale possa intervenire in questo dibattito, sempre che di dibattito ce ne sia. Questione di registro, questione anche di stile. Non è impossibile che questa riflessione sia stata, per noi, innanzitutto un’occasione per confrontarci a modo nostro con una preoccupazione che è parte integrante dei tempi e alla quale, almeno sotto questo aspetto, non possiamo sottrarci del tutto. Che il lettore possa trovare in questo ragionamento una strada percorribile, in assenza di certezze già pronte, è quindi quanto di meglio si possa sperare.
ÉLÉMENTS: Cos’è l’Occidente da un lato? E l’occidentalismo dall’altro? I due termini non dovrebbero essere distinti?
WALTER AUBRIG: Direi che non solo bisogna distinguere l’Occidente dall’occidentalismo – ci arriverò – ma è fondamentale evidenziare la polisemia della nozione stessa di Occidente, altrimenti ci esporremmo necessariamente a malintesi. La lingua francese, pur essendo così ricca di sfumature e sottigliezze, fa ben poco per aiutarci a trovare la nostra strada. Una piccola deviazione attraverso il tedesco, però, ci permette di vedere le cose più chiaramente: quello che da tempo è stato inteso come Occidente, è ciò che al di là del Reno, viene chiamata Abendland, la terra del tramonto. La parola porta con sé tutta la carica romantica di un’epoca in cui il mondo era diviso in due metà: da un lato l’Occidente cristiano, erede dell’omonimo Impero Romano; e dall’altro l’Oriente, che ebbe inizio a Bisanzio, e le cui dimensioni trovavano i propri limiti solo nel ricordo mitico delle conquiste di Alessandro, o nei prodigi riportati dal racconto di Marco Polo. Tuttavia, questo Occidente svanì progressivamente a favore dell’idea di Europa con l’ingresso nella modernità, durante il Rinascimento. Era l’epoca delle grandi scoperte, l’inizio del nomos della terra, per dirla in schmittiano. Da quel momento in poi gli Europei non si definirono più in relazione ad un asse est-ovest, ma in relazione ad un territorio: il continente europeo nel suo confronto con il resto del mondo. Fu solo nel corso del XX secolo, e in particolare nel faccia a faccia tra i grandi blocchi durante la Guerra Fredda, che il termine Occidente fu riutilizzato per designare una realtà dalle implicazioni molto diverse: il Grande Occidente, il Western World. Ed è ben inteso che quando Dominique Vener intitolava il suo libro-testamento Un samurai d’Occidente, era all’antica Hespéria, molto più che all’organizzazione atlantica, che pensava.
Veniamo quindi all’occidentalismo. Non siamo più ai tempi di Henri Massis, il quale, nel suo Défense de l’Occident, si opponeva al tradizionalismo di René Guénon, difensore della tradizione metafisica orientale; e nemmeno in quelli di Denis de Rougemont, quando ripercorse il tragitto spirituale dell’Aventure occidentale de l’homme. L’occidentalismo oggi è la riduzione dell’europeità come identità a un numero relativamente limitato di denominatori comuni specifici del mondo occidentale, e che dovrebbero imperativamente essere rivendicati e difesi. Tra questi criteri ricorrenti ritroviamo un insieme di valori orientati all’ideale di emancipazione e ai diritti individuali (in particolare delle minoranze), alla democrazia parlamentare, al progresso tecnologico che va facilmente di pari passo con lo sviluppo di un’economia basata sul più ampio accesso possibile ai consumi, e così via. Per i più essenzialisti, questo Occidente è caratterizzato anche dal colore della pelle, e si sovrappone quindi all’idea del «mondo bianco», rispondendo così in maniera quasi mimetica ai nuovi discorsi indigenisti e decoloniali. Talvolta, e ciò è particolarmente vero nel contesto attuale, l’Occidente viene anche assimilato all’idea di un mondo giudaico-cristiano, anche se con un significato molto variabile data la grande diversità delle Chiese cristiane.
Criticare questo occidentalismo non equivale, ben inteso, a negare il fatto che un certo numero di questi indicatori caratterizzano effettivamente l’Europa oggi, e nemmeno a rifiutarli del tutto, sebbene la loro legittimità, almeno in parte, sia più che discutibile. Si tratta piuttosto di dire che una riflessione sull’identità basata su tale retorica è destinata a fallire più o meno a lungo termine, perché non tiene conto di ciò che rende un’identità collettiva capace di proiettarsi nella storia.
ÉLÉMENTS: Nella tua analisi ti basi sull’antropologia culturale e sull’ecologia culturale. Se la prima è nota ai lettori della Rivoluzione Conservatrice, per non parlare di quelli che conoscono l’opera di Arnold Gehlen, la seconda lo è un po’ meno. In cosa consiste e qual è il suo contributo in questo caso?
WALTER AUBRIG: L’ecologia culturale, sviluppatasi a partire dagli anni Cinquanta sulla scia del lavoro dell’antropologo americano Julian Steward, è per molti versi una risposta ai temi centrali dell’antropologia culturale, o più precisamente al loro conseguente sviluppo, in un approccio disciplinare significativamente diverso. L’approccio caratteristico dell’antropologia culturale, così come possiamo utilizzarlo per il nostro argomento, consiste nell’affermare che la natura degli uomini si realizza attraverso la loro formazione culturale. Storicamente, esso si è determinato in una relazione critica con il riduzionismo, senza negare l’esistenza di dati innati. Si trattava piuttosto di formulare in modo nuovo il rapporto tra biologico e culturale. La conseguenza di questo approccio, che trova molti punti di contatto con i nomi che hanno contraddistinto l’antropologia come disciplina scientifica, è quindi quella di concepire ogni identità, individuale o collettiva, come espressione di un particolare sviluppo storico. Il contributo significativo dell’ecologia culturale è stato quello di mostrare che questo destino storico è sempre legato a uno spazio, quello a contatto con cui è emersa la comunità, e che essa ha gradualmente trasformato, con uno sviluppo creativo proprio. A differenza delle specie animali, che sono naturalmente integrate in un ambiente definito una volta per tutte, l’uomo lega il proprio destino a un dato spazio proiettandosi in esso. Genera, in un certo senso, il biotopo in cui prende forma il suo modo di esistere, e questo biotopo quindi ha necessariamente sempre un tempo e un luogo. Qui potremmo prendere in prestito da Michel Maffesoli il concetto di radicamento dinamico.
Cosa c’entra quindi questo con la nostra questione? Un pensiero esclusivamente riduzionista tenderebbe, ad esempio, a credere che, come gli innesti di un albero, i gruppi di emigranti europei partiti per stabilirsi nel Nuovo Mondo non hanno fatto altro che continuare, su un terreno diverso, un’avventura che resta essenzialmente quella degli europei. Le rotture geografiche e storiche sarebbero, quindi, dati trascurabili. Da questo punto di vista, la cultura americana, ad esempio, sarebbe un’espressione tra le altre di una civiltà comune, allo stesso modo della cultura tedesca e della cultura francese. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare a prima vista, non si tratta di valutare, attraverso l’osservazione empirica, il grado di differenza di queste culture per misurare la forma di deviazione in rapporto a una base comune – anche in questo caso si tratterebbe di ragionare esclusivamente per essenza, ignorando il peso delle dinamiche collettive, e quindi in fine sia gli orientamenti politici sia le grandi tendenze dello sviluppo antropologico. Perché in effetti, per il suo aspetto e per la manifestazione quotidiana del suo retaggio culturale, è molto probabile che un napoletano abbia più somiglianze con un italo-americano che con uno svedese. Ma ciò che fa di lui un napoletano, un italiano, e quindi un Europeo, lega nondimeno la sua intera esistenza culturale a un destino che, ad ogni livello di appartenenza che lo definisce, differisce e talvolta si oppone a quello del lontano cugino. Sia l’antropologia che l’ecologia culturale consentono quindi una comprensione più fine e differenziata di questi fattori dinamici, essenziali per definire le questioni che dobbiamo affrontare.
ÉLÉMENTS: Sottolinei, non senza ragione, la tentazione universalista – e l’impasse – dell’occidentalismo. Ma la sua matrice non è da ricercarsi in Europa?
WALTER AUBRIG: In un certo senso ciò è assolutamente corretto. Perché l’aspirazione all’universale è stata parte integrante della proiezione dell’Europa nel mondo. È soprattutto nelle grandi rivoluzioni atlantiche, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, che l’occidentalismo dei valori affonda le sue radici. Il colonialismo civilizzatore è stato solo un avatar passeggero, una lontana prefigurazione dell’umanitarismo strategico che ancora osserviamo nei processi decisionali occidentali. Questo universalismo sembra oggi definitivamente condannato dalla storia.
Tuttavia, vediamo imporsi un’altra forma di universalismo negativo, molto più ambigua e paradossale, soprattutto perché è essenzialmente costruita su un discorso anti-universalista. Quella di una concezione identitaria liberata da ogni forma di coesistenza storica e da ogni spazio specifico, che si riconosce in assegnazioni così assolute e regressive come il colore della pelle o il genere. Tali concezioni possono, ad esempio, portare i loro sostenitori, confondendo le cose, a semplificare le problematiche del nostro tempo come un confronto tra i popoli, determinato esclusivamente dalla loro essenza. Qui, tuttavia, la funzione matriciale dell’Europa diventa molto meno certa.
Ciò merita qualche spiegazione. Sarebbe infatti facile criticarci per aver ignorato, nella nostra riflessione, l’importanza della questione etnica. Ed è qui che tocchiamo il punto più delicato, per molti senza dubbio essenziale. Ci sembra, in rigorosa applicazione della nostra concezione del mondo e dell’esistenza delle società umane, che non esista fatto etnico che non sia, per definizione, un fatto etnoculturale, dispiegato come tale in un divenire storico, cioè politico. L’ignoranza di questa realtà costituisce un elemento importante della questione occidentale, su cui desideriamo attirare l’attenzione. La lettura che tende a scegliere, per i popoli europei, l’assegnazione identitaria a un «mondo bianco», è come tale la manifestazione di un’influenza senza precedenti di temi intrinsecamente estranei: quelli della società americana. E la loro inflazione nelle sfere dell’identità, sia di sinistra che di destra, non può essere de-correlata dal crescente peso dei discorsi anglosassoni, in particolare attraverso le reti di influenza.
Le società europee si sono tutte costruite su una fondamentale coerenza etnica, che nessuno studio storico serio potrebbe negare. Al contrario per gli Stati Uniti, a causa dell’eterogeneità intrinseca del loro sviluppo demografico, la multietnicità è emersa come tema decisivo, generando conflitti irriducibili. E questa realtà si applica effettivamente alla maggior parte dei paesi del mondo occidentale non europeo. Ecco perché, al di là dell’Atlantico, il fatto di essere nero o di essere bianco è stato, fin dal periodo coloniale, una questione identitaria determinante, in gran parte distinta dal fatto di essere americano. Volere dissolvere in questo stesso paradigma la questione dell’identità dei popoli d’Europa, anche se in nome della loro sopravvivenza, è quindi fin dall’inizio ragionare da non-europei. Si tratta di decretare a priori che un modo di esistenza che coniughi ethnos e polis, inerente all’europeità, non possa essere valido. Ciò significa dimenticare che la sostanza dei nostri popoli può essere assicurata solo se essi proiettano la loro azione creativa nello spazio che appartiene loro: quello di un continente multiplo con le proprie sfide. Ed è per questo motivo, forse più di ogni altro, che la questione dell’identità dell’Europa, ai nostri occhi, non può trovare soluzione che nell’affermazione della sua esistenza civilizzatrice, attraverso decisioni politiche che tengano conto delle realtà storiche in costante cambiamento.
Éléments, “Où finit l’Europe ? Où commence l’Occident ? (3/3)“, Intervista di François Bousquet a Walter Aubrig, 03/09/2024, traduzione a cura di Piero Sorelli della Roccella.