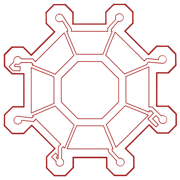Una tragedia immane, dopo oltre un decennio di guerra e propaganda. L’“asse della resistenza” incassa la sconfitta, mentre l’Occidente e Israele hanno perso la loro “eccezionalità etica”.
Anni fa mi capitò di scrivere che la guerra in Siria era il cambio della marea tra il mondo a guida americana e un altro mondo. Continuo a pensarlo nonostante tutto e non perché l’attuale tragedia non sia immane – lo è, in proporzioni che tuttavia dovranno ancora essere valutate.
Vent’anni fa la potenza trionfante intraprese una crociata per l’americanizzazione dell’intero Medio Oriente: la “liberazione” dell’Iraq era in teoria la prima tappa del “contagio democratico” (chi si ricorda questa espressione?) che avrebbe dovuto divampare in tutti gli altri Stati e farne un giardino liberale. Se oggi ci sembra più assurdo dell’idea che atterrino i marziani, non lo era a quei tempi: la Cina dell’epoca aveva un pil pro capite ancora paragonabile agli Stati africani, la Russia era un Paese in saldo dove perfino Putin valutava l’idea di agganciarsi alla Nato, l’Iran di Khatami pareva sul punto di smobilitare da un momento all’altro, i sionisti fino al giorno prima avevano occupato il Libano del sud. Il piano condotto secondo i dettami del Project for a new american century invece finì in una delle più spaventose catastrofi di sempre, tanto che oggi i neocons che dominavano la politica di quei tempi sono stati spazzati via perfino all’interno del partito repubblicano: preistoria geopolitica.
La propaganda dopo le armi: l’ultimo colpo di coda dello scorpione
Poi ci sono state le cosiddette primavere arabe, c’è stata la Siria. Per chi ha oggi trenta o quarant’anni la Siria è stata “il nostro Vietnam” (rubo questa bella espressione all’amico Matteo Mazzoni). Nata in realtà da una complessa mistura di tensioni interne ed esterne – la carestia del periodo 2007-2010, l’onda lunga della grande crisi finanziaria del 2008, la sclerosi dell’apparato di potere assadista, l’insorgere dell’Islam politico e in generale il ruolo strategico del Paese come crocevia tra la “mezzaluna sciita” dall’Iran al Libano e la “mezzaluna sunnita” dalla Turchia al Golfo -, per noi europei la Siria è stata soprattutto l’ultimo colpo di coda dello scorpione di Langley, l’estremo tentativo degli Usa e della Nato di guadagnare a mezzo di “rivoluzione colorata” stile Otpor (una specialità della casa, come si era visto in Serbia e Georgia e si sarebbe poi ripetuto in Ucraina, con quali esiti oggi lo sappiamo) quello che sul campo di battaglia non si poteva ottenere.
La passeggiata dell’ambasciatore Robert Ford ad Hama fu il colpo di cannone dell’incrociatore Aurora, così come i maneggi che Victoria Nuland andava tramando e che si sarebbero palesati a Euromaidan. Per anni abbiamo visto schierato l’intero armamentario propagandistico: dalla blogger gay di Damasco che si scoprì essere un barbuto scozzese a Bana di Aleppo, la bambina che twittava in inglese oxfordiano senza saperne parlare quasi una parola e che dopo la liberazione di Aleppo finì sulle ginocchia di “zio” Erdogan. Un profluvio di violinisti, pianisti, artisti circensi esuli, “giovani che sognano la libertà” e tutta la compagnia di giro, prontamente ripresa dalle sezioni esteri dei giornali che ai buoni uffici degli uffici stampa sono sempre sensibilissime (piccolo inciso: per ragioni del tutto casuali io e l’amico che era con me durante un viaggio in Siria siamo stati, credo, i primi occidentali a mettere piede a Yarmouk – l’ultimo avamposto dell’Isis a Damasco – circa un mese dopo la liberazione. Da giornalista professionista ai tempi, luglio-agosto 2018, proposi un reportage, gratis, a ben due testate nazionali – senza ricevere risposte).
Era impossibile, anche solo per questo, non essere dalla parte della Siria che lotta. Era impossibile a maggior ragione pensando a ciò che rappresentava la Siria, l’ultimo bastione della più nobile idea che il mondo arabo abbia dato a sé stesso: il baathismo. Pervertito da Saddam Hussein in Iraq, piegato dalla miseria della corruzione e delle lotte claniche nella stessa Siria, come non sfuggiva già allora ai più accorti. Ma tuttavia ancora vivo, ancora capace di riunire contro di sé tutti – ma davvero tutti – i più luciferini attori di quella scacchiera: gli americani, i sionisti, gli islamisti, di volta in volta pronti ad aggredire la Siria o riparandosi dietro ai curdi o invadendo il Paese (gli Usa hanno invaso la Siria, per qualche motivo non è ci è mai interessato) o bombardandone le infrastrutture o – peggio ancora – armando la mano di milizie che se non erano l’Isis erano semplici sfumature lessicali della stessa ideologia pestilenziale.
Impossibile non innamorarsi del coraggio di Yahya Adnan al-Shughri, il soldato della Brigata 93 – di credo sunnita – che morì dicendo ai carnefici dell’Isis: “In nome di Allah, vi annienteremo”. Degli eroi dell’aeroporto di Kuwairas, l’“Alcazar” aleppino che resistette per due anni prima della liberazione. Delle città martiri di Nubl e Zahra, enclavi sciite della provincia di Aleppo. Dell’avamposto di Deir Ezzor, cinquemila valorosi assediati dall’Isis per tre anni, un mese e 22 giorni mentre il loro comandante, Issam Zahreddine, veniva inserito nella lista nera dell’Ue e il loro contingente bombardato “per errore” dagli americani. Di Alexander Prokhorenko, caduto a 25 anni per la liberazione di Palmira, circondato dalle orde nere. Delle milizie di Hezbollah che per anni hanno versato sangue per liberare Maaloula, la città simbolo del cristianesimo siriano. Di Qasem Soleimani, il generale iraniano che sbarrò la via all’Isis, assassinato a tradimento per ordine di Trump.
Una disfatta per l’“asse della resistenza”. Ma la storia è in moto
La Siria è stata sfinita, dalle sanzioni, da altre crisi, dalla persistenza di Erdogan, molto prima di essere finita. Il suo esercito che si era speso oltre ogni limite e che – si poteva dire già allora – senza l’intervento russo del 30 settembre 2015 non avrebbe potuto resistere fino a oggi, si è dissolto senza quasi sparare un colpo. Su quanto è accaduto in questi giorni molto si deve ancora comprendere e molto, forse, non si comprenderà mai. È un disastro per l’“asse della resistenza” ed è inutile provare a dire che non sia così: la Russia si trova a contrattare con i nuovi padroni l’incerta permanenza delle sue uniche basi sul Mediterraneo, l’Iran perde una parte rilevantissima della sua capacità di proiezione esterna e vede chiudersi il corridoio che lo univa al Libano, attraverso l’Iraq, Hezbollah, decapitata dalla morte di un grande leader come Nasrallah e depotenziata militarmente, perde l’unico alleato vicino. Le stesse modalità della disfatta, però, ci dicono che la storia è pronta a rimettersi in moto (ma non lo è sempre?). Se la Siria avesse ceduto nel 2011 o nel 2016 le orde dell’Isis ne avrebbero forse annientato per sempre la civiltà: al Jolani invece è stato costretto a fare molti compromessi per arrivare dove è arrivato, altri ne dovrà fare in avvenire, probabilmente anche con quel che resta della fu Repubblica Araba. L’alternativa è lo sterminio fisico di ogni uomo, donna e bambino cristiano, alawita, sciita, degli stessi sunniti laici: qualcosa che la feccia qaedista che lo segue forse avrebbe anche in animo di fare ma che i suoi padrini di Ankara difficilmente potranno permettergli. Quel che succederà domani in Turchia, un domani che Erdogan venisse rovesciato o sconfitto per via politica dall’opposizione laica, avrà conseguenze forse decisive anche per la Siria.
Poi c’è il quadro più vasto. Israele e la Turchia sono i veri trionfatori, ma la seconda molto più del primo. Qualcuno qui notava che quella dell’ultimo anno è stata la prima guerra che Israele ha combattuto divisa: là dove tutti i conflitti precedenti avevano cementato la coesione nazionale del Paese questa l’ha minata in modo forse irreparabile. Nell’immane bagno di sangue di Gaza Israele ha perso, soprattutto, la propria “eccezionalità etica” agli occhi degli occidentali: per un Paese che basa la sua intera esistenza sulla compiacenza dell’Occidente, e che a tutti gli effetti rappresenta l’ultima grande operazione coloniale europea, questo è un fatto dirimente. L’involuzione autoritaria del Paese, sotto Netanyahu ma anche a prescindere da Netanyahu, è evidente a chiunque. La retorica dell’“unica democrazia del Medio Oriente” ne esce sfigurata a prescindere da quello che sarà l’esito del campo: Israele, in avvenire, sarà visto come un sanguinario attore regionale al pari degli altri e non come una propaggine del savio Occidente liberale tra i barbari mediorientali, come era stato finora.
L’Occidente può rinunciare alla democrazia, pur di non rinunciare a sé stesso
Vent’anni dopo la sbornia neocon oggi sappiamo che qualunque cosa sia destinata a essere quel che resta di questo secolo, un quarto del quale è trascorso, non sarà “un nuovo secolo americano”. Nello sbandierato rapporto del Censis sull’ignoranza degli italiani si riportano anche dati più sottaciuti ma più rilevanti del numero di persone che non conoscono Mazzini: il 66,3% delle persone attribuisce agli Usa la responsabilità delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, solo il 31,6% aderisce all’ipotesi di innalzare le spese militari al 2% del Pil, come richiesto dagli Usa e posto da Trump quale condizione per la permanenza nella Nato (è una fanfaronata, ovviamente: gli americani non se ne andranno dall’Europa finché non li cacceremo. Ma è indicativo). Gli indignati estensori dell’indagine scrivono che “il 70,8% degli italiani esprime oggi un più o meno viscerale antioccidentalismo ed è pronto a imputare le colpe dei mali del mondo ai Paesi dell’Occidente”.
Il bluff è scoperto: si è capito che l’eccezionalità occidentale era un gioco di ombre, che la democrazia è una variabile secondaria nel buon funzionamento della Megamacchina. Se c’è bene, se non c’è ne faremo a meno: come del resto si è fatto infinite volte in tutto il Sudamerica, ma anche in tutta l’Europa mediterranea (Italia esclusa, e sa Dio se non ci siamo andati vicini anche noi), nella Corea del Sud di cui si torna a parlare. L’idea che modello americano e democrazia viaggiassero a braccetto è stata vera solo per qualche tempo, in qualche posto, e solo perché ce lo potevamo permettere.
Il ventennio incominciato con l’idea che il “contagio democratico” sarebbe stato il grimaldello dell’Occidente per scardinare ogni nemico vicino e lontano – la Russia, l’Iran, la Cina – si chiude con l’annullamento di un’elezione regolare in Romania (proprio la Romania che fu simbolo e motore dei moti del 1989) in base a una velina dei servizi segreti su non si sa bene quale manovra operata tramite TikTok. Mentre in Siria cade la dittatura laica e giunge non una promessa di democrazia che non è mai esistita, neanche a marzo del 2011, ma una nuova autocrazia islamica il cui avvento non viene festeggiato nemmeno da coloro che le hanno spianato la strada per quasi tre lustri.
Ciascuno tragga, da queste coincidenze storiche, le considerazioni che ritiene.