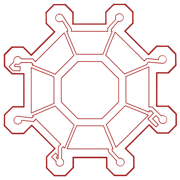La Nuova Destra è nata nel 1968. Non è un movimento politico ma una scuola di pensiero. Le attività che la contraddistinguono da ormai più di trent’anni (pubblicazione di libri e di riviste, indizione di convegni e di conferenze, organizzazione di seminari e di università estive, ecc.) si collocano sin dall’inizio in una prospettiva metapolitica.
La metapolitica non è un’altra maniera di fare politica. Non ha nulla di una “strategia” mirante ad imporre un’egemonia intellettuale, né pretende squalificare altri possibili approcci o atteggiamenti. Si basa semplicemente sulla constatazione che le idee svolgono un ruolo fondamentale nelle coscienze
collettive e, più in generale, nell’intera storia degli uomini. Eraclito, Aristotele, Agostino, Tommaso d’Aquino, Cartesio, Immanuel Kant, Adam Smith o Karl Marx hanno, ai loro tempi, provocato grazie alle loro opere delle rivoluzioni decisive, il cui effetto si fa sentire ancora oggi. La storia è certamente il risultato della volontà e dell’azione degli uomini, ma questa volontà e questa azione si esercitano sempre nel contesto di un certo numero di convinzioni, di credenze, di rappresentazioni che conferiscono loro un senso e le orientano. La Nuova Destra ha l’ambizione di contribuire al rinnovamento di queste rappresentazioni socio-storiche.
Il modo di procedere metapolitico è ancora oggi confortato da una riflessione sull’evoluzione delle società occidentali all’alba del XXI secolo. Si constata infatti, da un lato, la crescente impotenza dei partiti, dei sindacati, dei governi e dell’insieme delle forme classiche di conquista e di esercizio del potere, e, dall’altro, un’accelerata obsolescenza di tutte le linee di frattura che avevano caratterizzato la modernità, a cominciare dal tradizionale distinguo tra sinistra e destra. Si osserva peraltro un’esplosione senza precedenti delle conoscenze, che si moltiplicano senza che le loro conseguenze siano sempre pienamente percepite. In un mondo in cui gli insiemi chiusi hanno ceduto il posto a reti
interconnesse e i punti di riferimento si fanno sempre più vaghi, l’azione metapolitica consiste nel tentare di ridare un senso al più alto livello attraverso nuove sintesi, nello sviluppare al di fuori delle giostre politiche un modo di pensare risolutamente trasversale, ed infine nello studiare tutti gli ambiti del sapere al fine di proporre una visione del mondo coerente.
Questo è il nostro obiettivo da trent’anni a questa parte.
Il presente manifesto ne offre la dimostrazione. La sua prima parte (“Situazioni”) offre un’analisi critica della nostra epoca. La seconda (“Fondamenti”) esprime le basi della nostra visione dell’uomo e del mondo. Entrambe sono ispirate da un approccio multidisciplinare che fa piazza pulita della maggior parte delle linee divisorie intellettuali attualmente riconosciute. Tribalismo e globalismo, nazionalismo
e internazionalismo, liberalismo e marxismo, individualismo e collettivismo, progressismo e conservatorismo si contrappongono infatti nella stessa compiacente logica del terzo escluso. Da un secolo, queste contrapposizioni fittizie mascherano il dato essenziale: l’ampiezza di una crisi che
impone un rinnovamento radicale dei nostri modi di pensare, di decidere e di agire. Sarebbe perciò impresa vana andare alla ricerca, nelle pagine che seguono, delle tracce di precursori dei quali noi non saremmo altro che gli eredi: la Nuova Destra ha saputo far fruttare le più diverse acquisizioni teoriche che l’hanno preceduta. Praticando una lettura estensiva della storia delle idee, essa non esita a far
proprie quelle che le paiono giuste in tutte le correnti di pensiero. Questo modo di procedere trasversale provoca peraltro regolarmente la collera dei cerberi del pensiero, che si trovano d’accordo per congelare le ortodossie ideologiche al fine di paralizzare qualunque nuova sintesi che minacci la
loro confortevole situazione intellettuale.
Sin dalle origini, infine, la Nuova destra raccoglie uomini e donne che vivono nella loro città ed intendono partecipare in maniera vissuta alla sua crescita. In Francia come in altri paesi, essa costituisce una comunità di lavoro e di riflessione, i cui membri non sono necessariamente degli intellettuali ma si interessano tutti, a questo o a quel titolo, alla battaglia delle idee. La terza parte di questo manifesto (“Orientamenti”) esprime quindi la nostra posizione sui grandi dibattiti dell’attualità e i nostri orientamenti per il futuro dei nostri popoli e della nostra civiltà.
I. SITUAZIONI
Ogni pensiero critico è prima di tutto una visione prospettica dell’epoca in cui si manifesta. Noi oggi ci situiamo in un periodo-cardine, una svolta sotto forma di “interregno”, che si inserisce sullo sfondo di una crisi di grande importanza: la fine della modernità.
1. Che cos’è la modernità?
La modernità designa il movimento politico e filosofico degli ultimi tre secoli della storia occidentale. Si caratterizza principalmente per cinque processi convergenti: l’individualizzazione, attraverso la distruzione delle vecchie comunità di appartenenza; la massificazione, attraverso l’adozione di comportamenti e modi di vita standardizzati; la desacralizzazione, attraverso il riflusso dei grandi racconti religiosi a vantaggio di una interpretazione scientifica del mondo; la razionalizzazione, attraverso il dominio della ragione strumentale tramite lo scambio mercantile e l’efficacia tecnica; l’universalizzazione, attraverso l’estensione planetaria di un modello di società implicitamente considerato come l’unico razionalmente possibile, e quindi come superiore.
Questo movimento ha radici antiche. Per più di un verso, rappresenta una secolarizzazione di nozioni e prospettive prese a prestito dalla metafisica cristiana, che sono state trasferite sulla vita profana dopo averle svuotate di ogni dimensione di trascendenza. Nel cristianesimo troviamo infatti in germe le grandi trasformazioni che hanno irrigato le ideologie laiche dell’era post-rivoluzionaria. L’individualismo era già presente nel concetto di salvezza individuale e di rapporto intimo privilegiato che il credente
intrattiene con Dio, rapporto che prevale su qualunque radicamento terreno. L’egualitarismo trova la sua sorgente nell’idea che gli uomini siano tutti egualmente chiamati alla redenzione, in quanto tutti a pari titolo dotati di un’anima individuale il cui valore assoluto è condiviso dall’intera umanità. Il progressismo nasce dall’idea che la storia possiede un inizio assoluto e una fine necessaria, il suo
sviluppo essendo globalmente assimilato al piano divino. L’universalismo, infine, è l’espressione naturale di una religione che afferma di detenere una verità rivelata, valida per tutti gli uomini e che ne esige la conversione. La stessa vita politica si fonda su concetti teologici secolarizzati. Il
cristianesimo, oggi ridotto alla condizione di un’opinione fra le altre, è stato a sua volta vittima, suo malgrado, di quel movimento che ha avviato: nella storia dell’Occidente, lo si ricorderà come la religione dell’uscita dalla religione.
Le diverse scuole filosofiche della modernità, in concorrenza e a volte in contrasto nei rispettivi fondamenti, si trovano nondimeno d’accordo sull’essenziale: l’idea che esista una soluzione unica e universalizzabile per tutti i fenomeni sociali, morali e politici. In questo quadro, l’umanità è percepita come una somma di individui razionali che, per interesse, per convinzione morale, per simpatia o anche per paura, sono chiamati a realizzare la loro unità nella storia. In questa prospettiva, la diversità del mondo diventa un ostacolo e tutto ciò che differenzia gli uomini è visto come accessorio o contingente, superato o pericoloso. Nella misura in cui non è stata solamente un corpus di idee, ma anche una modalità di azione, la modernità ha cercato in tutti i modi di strappare gli individui alle loro appartenenze particolari, con lo scopo di sottometterli a un modo universale di associazione. Il più efficace, nell’uso, si è dimostrato il mercato.
2. La crisi della modernità
L’immaginario della modernità è stato dominato dai desideri di libertà e di eguaglianza. Questi due valori cardinali sono stati traditi. Staccati dalle comunità che li proteggevano, dando senso e forma alla loro esistenza, gli individui si trovano ormai sotto il tallone di immensi meccanismi di dominio e di decisione al cospetto dei quali la loro libertà resta puramente formale. Essi subiscono il potere globalizzato del mercato, della tecnoscienza o della comunicazione senza mai poter deciderne il corso.
Anche la promessa di eguaglianza ha subìto un duplice fallimento: il comunismo l’ha tradita instaurando i regimi totalitari più omicidi della storia; il capitalismo se ne è fatto gioco legittimando con una eguaglianza di principio le ineguaglianze economiche e sociali più odiose. La modernità ha proclamato dei “diritti” senza peraltro offrire i mezzi per esercitarli. Ha esasperato tutti i bisogni e ne crea di continuo di nuovi, riservando però l’accesso ad essi a una piccola minoranza, il che alimenta la frustrazione e la collera di tutti gli altri. Dal canto suo, l’ideologia del progresso, che aveva risposto all’attesa degli uomini coltivando la promessa di un mondo sempre migliore, oggi attraversa una crisi
radicale: il futuro, che si sta rivelando imprevedibile, non è più portatore di speranza, ma incute paura ai più. Ogni generazione affronta ormai un mondo diverso da quello dei padri: questa perpetua novità fondata sulla squalifica della filiazione e delle vecchie esperienze, aggiunta alla trasformazione continuamente accelerata dei modi di vita e degli ambienti dove si vive, non produce felicità, bensì
angoscia.
La “fine delle ideologie” designa l’esaurimento storico dei grandi racconti mobilitanti che si sono incarnati nel liberalismo, nel socialismo, nel comunismo, nel nazionalismo, nel fascismo o nel nazismo. Il XX secolo ha suonato a morto per la maggior parte di queste dottrine, i cui effetti concreti sono stati i genocidi, gli etnocidi e i massacri di massa, le guerre totali tra le nazioni e la concorrenza permanente tra gli individui, i disastri ecologici, il caos sociale, la perdita di tutti i punti di riferimento significativi. Distruggendo il mondo vissuto a profitto della ragione strumentale, la crescita e lo sviluppo materiali si sono tradotti in un impoverimento senza precedenti dello spirito. Hanno generalizzato la preoccupazione, l’inquietudine di vivere in un presente sempre incerto, in un mondo privo sia di passato che di futuro. La modernità ha così partorito la civiltà più vuota che l’umanità abbia mai conosciuto: il linguaggio pubblicitario è diventato il paradigma di tutti i linguaggi sociali; il regno del denaro impone l’onnipresenza della merce; l’uomo si trasforma in oggetto di scambio in un’atmosfera di edonismo povero; la tecnica rinserra il mondo vissuto nella rete pacificata e razionalizzata del
riserbo; la delinquenza, la violenza e l’inciviltà si propagano in una guerra di tutti contro tutti e di ciascuno contro se stesso; l’individuo, incerto, sguazza nei mondi derealizzati della droga, del virtuale e del massmediale; le campagne si desertificano, trasformandosi in periferie invivibili e in megalopoli mostruose; l’individuo solitario si fonde in una folla anonima ed ostile, mentre le vecchie mediazioni
sociali, politiche, culturali o religiose diventano sempre più incerte e indifferenziate.
Questa crisi diffusa che stiamo attraversando segnala che la modernità giunge alla fine, nel momento stesso in cui l’utopia universalista che ne era a fondamento si sta trasformando in una realtà sotto l’egida della globalizzazione liberale. La fine del XX secolo segna, contemporaneamente alla fine dei tempi moderni, l’ingresso in una postmodernità caratterizzata da una serie di tematiche nuove: l’emergere della preoccupazione ecologica, la ricerca della qualità della vita, il ruolo delle “tribù” e delle “reti”, il recupero di importanza delle comunità, la politica di riconoscimento dei gruppi, la moltiplicazione dei conflitti infra- o sovra-statali, il ritorno delle violenze sociali, il declino delle religioni istituzionalizzate, la crescente opposizione dei popoli alle loro élites, e così via. Non avendo più nulla da dire e constatando il crescente malessere delle società contemporanee, i sostenitori dell’ideologia dominante sono ridotti a dover tenere un discorso incantatorio, martellato dai media in un universo in pericolo di implosione. Implosione, non più esplosione: il superamento della modernità non assumerà la forma di un “grande tramonto” (versione profana della parusia), ma si manifesterà attraverso l’apparizione di migliaia di aurore, cioè tramite la dischiusura di spazi sovrani liberati dal dominio moderno. La modernità non sarà oltrepassata con un ritorno all’indietro, ma con un ricorso a taluni valori premoderni in un’ottica risolutamente postmoderna. L’anomia sociale e il nichilismo contemporaneo saranno scongiurati a prezzo di una rifondazione radicale di tale portata.
3. Il liberalismo, nemico principale
Il liberalismo incarna l’ideologia dominante della modernità, la prima ad apparire, che sarà anche l’ultima a scomparire. In un primo tempo, il pensiero liberale ha reso autonoma l’economia rispetto alla morale, alla politica e alla società, nelle quali era precedentemente incastonata. In un secondo tempo, esso ha fatto del valore mercantile l’istanza suprema dell’intera vita comune. L’avvento del “regno della quantità” designa questo passaggio dalle economie di mercato alle società di mercato, vale a dire l’estensione a tutti gli ambiti dell’esistenza delle leggi dello scambio mercantile coronato dalla “mano invisibile”. Il liberalismo, d’altronde, ha generato l’individualismo moderno sulla base di un’antropologia falsa tanto dal punto di vista descrittivo che da quello normativo, fondata su un individuo unidimensionale che trae i propri “diritti imprescrittibili” da una “natura” fondamentalmente non sociale e che si suppone cerchi di massimizzare di continuo il proprio interesse eliminando ogni considerazione non quantificabile e ogni valore che non discenda dal calcolo razionale.
Questa duplice pulsione individualista ed economicista si accompagna a una visione “darwiniana” della vita sociale. Quest’ultima è ricondotta in ultima analisi alla concorrenza generalizzata, nuova versione della “guerra di tutti contro tutti”, allo scopo di selezionare i “migliori”. Ma, a parte il fatto che la concorrenza “pura e perfetta” è un mito, dal momento che le preesistono sempre dei rapporti di forza,
essa non dice assolutamente niente sul valore di quel che viene selezionato: ne scaturiscono sia il meglio che il peggio. L’evoluzione seleziona i più adatti a sopravvivere, ma l’uomo non si accontenta, per l’appunto, di sopravvivere: egli ordina la propria vita sulla base di gerarchie di valori nei confronti
dei quali il liberalismo pretende di rimanere neutrale.
Il carattere iniquo del dominio liberale ha provocato nel XIX secolo una legittima reazione, con l’apparizione del movimento socialista; ma quest’ultimo si è fuorviato sotto l’influsso delle teorie marxiste. Ebbene: malgrado ciò che li contrappone, liberalismo e marxismo appartengono fondamentalmente al medesimo universo, ereditato dal pensiero dei Lumi: lo stesso individualismo di fondo, lo stesso universalismo egualitario, lo stesso razionalismo, lo stesso primato del fattore economico, la stessa insistenza sul valore emancipatore del lavoro, la stessa fede nel progresso, la stessa aspirazione alla fine della storia. Da vari punti di vista, il liberalismo si è limitato a realizzare con maggiore efficacia alcuni degli obiettivi che condivideva con il marxismo: sradicamento delle identità collettive e delle culture tradizionali, disincanto del mondo, universalizzazione del sistema di produzione.
I danni causati dal mercato hanno provocato, nello stesso modo, l’apparizione e il rafforzamento dello Stato assistenziale. Nel corso della storia, il mercato e lo Stato avevano già fatto la loro comparsa di pari passo; il secondo cercava di assoggettare a prelievo fiscale degli scambi intracomunitari non mercantili, che in precedenza non potevano essere rilevati, e faceva di uno spazio economico
omogeneo uno strumento della propria potenza. In seguito, la dissoluzione dei legami comunitari provocata dalla mercantilizzazione della vita sociale ha reso necessario il progressivo rafforzamento di uno Stato assistenziale incaricato di procedere alle redistribuzioni necessarie per ovviare alla scomparsa delle solidarietà tradizionali. Lungi dall’ostacolare la corsa del liberalismo, quegli interventi statali gli hanno consentito di prosperare evitando l’esplosione sociale, quindi assicurando la sicurezza
e la stabilità indispensabili agli scambi. In cambio, però, lo Stato assistenziale, il quale non è altro che una struttura redistributiva astratta, anonima ed opaca, ha generalizzato l’irresponsabilità, trasformando i componenti della società in altrettanti assistiti, che non reclamano più tanto il rovesciamento del sistema liberale, quanto piuttosto l’estensione indefinita e senza contropartita dei diritti di cui godono.
Inoltre, il liberalismo comporta la negazione della specificità del politico, la quale implica sempre l’arbitrarietà della decisione e la pluralità delle finalità. La “politica liberale” appare, da questo punto di vista, come una contraddizione in termini. Mirando a formare il legame sociale a partire da una teoria della scelta razionale che indicizza la cittadinanza sull’utilità, essa si riduce a un ideale di gestione “scientifica” della società globale, che pone sotto l’esclusivo orizzonte della competenza tecnica. Lo Stato di diritto liberale, troppo spesso sinonimo di repubblica dei giudici, crede contemporaneamente di poter astenersi dal proporre un modello di vita buona ed aspira a neutralizzare i conflitti inerenti alla diversità della società tramite procedure puramente giuridiche miranti a determinare ciò che è giusto
piuttosto che ciò che è bene. Lo spazio pubblico si dissolve nello spazio privato, mentre la democrazia rappresentativa si riduce ad un mercato nel quale si incontrano un’offerta sempre più ristretta (riorientamento dei programmi verso il centro e convergenza delle politiche) e una domanda sempre
meno motivata (astensionismo).
Nell’epoca della globalizzazione, il liberalismo non si presenta più come un’ideologia, ma come un sistema mondiale di produzione e riproduzione degli uomini e delle merci, sovrastato dall’ipermoralismo dei diritti dell’uomo. Nelle sue forme economica, politica e morale, il liberalismo
rappresenta il blocco centrale delle idee di una modernità che si sta consumando. E quindi l’avversario principale di tutti coloro che operano per il suo superamento.
II. FONDAMENTI
“Conosci te stesso”, diceva la massima delfica. La chiave di ogni rappresentazione del mondo, di ogni impegno politico, morale o filosofico risiede prima di tutto in un’antropologia. Le nostre azioni su compiono del resto attraverso certi ordini della prassi, che rappresentano altrettante essenze delle relazioni degli uomini fra di loro e con il mondo: il politico, l’economico, la tecnica e l’etica.
1. L’uomo: un momento del vivente
La modernità ha negato l’esistenza di una natura umana (teoria della tabula rasa) oppure l’ha rapportata a dei predicati astratti sconnessi dal mondo reale e dall’esistenza vissuta. A prezzo di questa rottura radicale è emerso l’ideale di un “uomo nuovo”, malleabile all’infinito tramite la trasformazione progressiva o brutale del suo ambiente. Questa utopia è sfociata nelle esperienze totalitarie e nei sistemi concentrazionari del XX secolo. Nel mondo liberale, si è tradotta nella credenza superstiziosa nell’onnipotenza dell’ambiente, che ha generato non meno delusioni, in particolare nell’ambito educativo: in una società strutturata dall’uso della razionalità astratta, sono infatti le capacità cognitive a costituire il principale elemento di determinazione dello status sociale.
L’uomo è innanzitutto un animale e come tale si colloca nell’ordine del vivente, la cui durata si misura in centinaia di milioni di anni. Se si compara la storia della vita organica a una giornata di 24 ore, l’apparizione della nostra specie interviene soltanto negli ultimi trenta secondi. Il processo di
ominizzazione si è svolto lungo parecchie decine di migliaia di generazioni. Nella misura in cui la vita si espande prima di tutto per trasmissione dell’informazione contenuta nel materiale genetico, l’uomo non nasce come una pagina bianca: ciascuno di noi è già portatore delle caratteristiche generali della nostra specie, alle quali si aggiungono predisposizioni ereditarie a certe attitudini particolari e a certi comportamenti. L’individuo non decide questa eredità, che ne limita l’autonomia e la plasticità ma gli permette anche di resistere ai condizionamenti politici e sociali.
L’uomo però non è soltanto un animale: ciò che vi è in lui di specificamente umano – coscienza della propria coscienza, pensiero astratto, linguaggio sintattico, capacità simbolica, attitudine alla constatazione oggettiva e al giudizio di valore – non contraddice la sua natura, ma la prolunga, conferendole una dimensione supplementare ed unica. Negare le determinazioni biologiche dell’uomo o ridurlo ad esse riconducendone i tratti specifici alla zoologia sono dunque due atteggiamenti egualmente assurdi. La componente ereditaria della nostra umanità forma soltanto lo zoccolo della nostra vita sociale e storica: dato che i suoi istinti non sono programmati nel loro oggetto, l’uomo è
sempre titolare di una parte di libertà (deve fare delle scelte sia morali che politiche) il cui unico vero limite naturale è la morte. L’uomo è prima di tutto un erede, ma può disporre della sua eredità. Noi ci costruiamo storicamente e culturalmente sulla base dei presupposti della nostra costituzione biologica, che sono il limite della nostra umanità. Ciò che sta al di là di questo limite può essere chiamato Dio, cosmos, nulla o Essere: la questione del “perché” non vi ha più alcun senso, giacché ciò che si trova al di là dei limiti umani è, per definizione, impensabile.
La Nuova Destra propone dunque una visione dell’uomo equilibrata, che tenga conto nel contempo dell’innato, delle capacità personali e dell’ambiente sociale. Essa rifiuta le ideologie che mettono abusivamente l’accento su uno solo di questi fattori di determinazione: biologico, economico o
meccanico che sia.
2. L’uomo: un essere radicato, a rischio e aperto
L’uomo non è per natura né buono né cattivo, ma è capace di essere l’uno o l’altro. Da questo punto di vista è un essere aperto e “a rischio”, sempre suscettibile di oltrepassarsi o di degradarsi. Le regole sociali e morali, così come le istituzioni e le tradizioni, permettono di scongiurare questa minaccia
permanente, facendo sì che l’uomo si impegni a costruirsi nel riconoscimento delle norme che fondano la sua esistenza conferendole senso e punti di riferimento.
L’umanità, definita come l’insieme indistinto degli individui che la compongono, designa o una categoria biologica (la specie), o una categoria filosofica scaturita dal pensiero occidentale. Dal punto di vista socio-storico, l’uomo in sé non esiste, perché l’appartenenza all’umanità è sempre mediata a
una particolare appartenenza culturale. Questa constatazione non è un portato del relativismo. Tutti gli
uomini hanno in comune la natura umana, senza la quale non potrebbero capirsi, ma la loro comune appartenenza alla specie si esprime sempre a partire da un contesto particolare. Essi condividono le stesse aspirazioni essenziali, che si cristallizzano però sempre in forme differenti, a seconda delle epoche e dei luoghi. L’umanità, in questo senso, è irriducibilmente plurale: la diversità fa parte della
sua stessa essenza. La vita umana si colloca necessariamente all’interno di un contesto che precede il giudizio, foss’anche critico, che gli individui e i gruppi esprimono sul mondo, e modella tanto le aspirazioni quanto la finalità che sono loro proprie: nel mondo reale esistono soltanto persone
concretamente situate. Le differenze biologiche non sono, in sé, significative se non in riferimento a dati culturali e sociali. Quanto poi alle differenze tra le culture, esse non sono né l’effetto di un’illusione né caratteristiche transitorie, contingenti o secondarie. Le culture hanno tutte un proprio “centro di gravità”, come lo definiva Herder: culture diverse danno risposte diverse ai quesiti essenziali. Per questo ogni tentativo di unificarle finisce col distruggerle. L’uomo si colloca per natura nel registro della cultura: essere caratterizzato dalla singolarità, si situa sempre all’interfaccia tra l’universale (la sua specie) e il particolare (ciascuna cultura, ciascuna epoca). L’idea di una legge assoluta, universale ed eterna, chiamata a determinare in ultima istanza le nostre scelte morali, religiose o politiche appare
dunque priva di fondamento. Tale idea è alla base di tutti i totalitarismi.
Le società umane sono nel contempo conflittuali e comunicative, senza che si possa estendere una di
queste caratteristiche a beneficio dell’altra. La fede irenica nella possibilità di far scomparire gli antagonismi in seno a una società riconciliata e trasparente nei confronti di se stessa non ha più validità della visione iperconcorrenziale (liberale, razzista o nazionalista) che fa della vita una perpetua guerra tra individui o gruppi. Se anche l’aggressività è parte integrante dell’attività creativa e della
dinamica della vita, l’evoluzione ha favorito nell’uomo l’emergere di comportamenti cooperativi (altruistici) che non sempre vengono tenuti nella sola sfera della sua parentela genetica. D’altro canto, le grandi costruzioni storiche hanno potuto durare solo stabilendo un’armonia fondata sul riconoscimento di beni comuni, sulla reciprocità fra diritti e doveri, sul mutuo soccorso e sulla suddivisione. Né pacifica né bellicosa, né buona né cattiva, né bella né brutta, l’esistenza umana si svolge in una tensione tragica fra questi poli attrattivi e repulsivi.
3. La società: un corpo di comunità
L’esistenza umana è indissociabile dalle comunità e dagli insiemi sociali nei quali si colloca. L’idea di uno “stato di natura” primitivo in cui avrebbero coesistito individui autonomi è una pura finzione: la società non risulta da un contratto che gli uomini sottoscrivono con l’obiettivo di massimizzare il proprio interesse, bensì da un’associazione spontanea la cui forma più antica è sicuramente la famiglia
allargata.
Le comunità nelle quali si incarna lo stato sociale disegnano un tessuto complesso di corpi intermedi situati fra l’individuo, i gruppi di individui e l’umanità. Alcune di esse sono ereditate (native), altre vengono scelte (cooperative). Il legame sociale, del quale la vecchia destra non è mai stata capace di riconoscere l’autonomia e che non si confonde affatto con la sola “società civile”, si definisce in primo
luogo come un modello per le azioni degli individui, non come l’effetto globale di tali azioni; si fonda su un consenso condiviso verso questa anteriorità del modello. L’appartenenza collettiva non annulla l’identità individuale, ma ne costituisce la base: quando si abbandona la comunità di origine, in genere lo si fa per raggiungerne un’altra. Native o cooperative, le comunità hanno tutte come fondamento la
reciprocità. Le comunità si costruiscono e si conservano nella certezza, provata da ciascuno dei loro componenti, che tutto ciò che viene richiesto a loro può e deve essere richiesto anche agli altri. Reciprocità verticale dei diritti e dei doveri, della contribuzione e della redistribuzione, dell’obbedienza e dell’assistenza; reciprocità orizzontale dei doni e dei controdoni, della fraternità, dell’amicizia, dell’amore. La ricchezza della vita sociale è proporzionale alla diversità delle appartenenze che propone: tale diversità è continuamente minacciata per difetto (conformizzazione, indifferenziazione) o per eccesso (secessione, atomizzazione).
La concezione olista, secondo la quale il tutto eccede la somma delle sue parti e possiede qualità che gli sono proprie, è stata combattuta dall’individualismo universalistico moderno, che ha associato la comunità alla gerarchia subita, alla chiusura o allo spirito di campanile. Questo individualismo universalistico si è manifestato nelle due figure del contratto (politico) e del mercato (economico). Ma, in realtà, la modernità non ha liberato l’uomo affrancandolo dalle antiche appartenenze familiari, locali,
tribali, corporative o religiose. Non ha fatto altro che assoggettarlo ad altre costrizioni, più dure perché
più lontane, più impersonali e più esigenti: una soggezione meccanica, astratta ed omogenea ha preso il posto dei multiformi contesti organici. Diventando più solitario, l’uomo è diventato anche più vulnerabile e più sguarnito. Si è distaccato dal senso perché non può più identificarsi in un modello, perché per lui non ha più senso porsi dal punto di vista del tutto sociale. L’individualismo è sfociato
nella perdita di affiliazioni e nella messa in disparte, nella crisi delle istituzioni (la famiglia, ad esempio, non socializza più) e nella captazione del legame sociale da parte delle burocrazie statali. Al momento del bilancio, il grande progetto di emancipazione moderno può essere analizzato come un’alienazione su grande scala. Dato che tendono a radunare individui che si sentono estranei gli uni agli altri e non manifestano più alcuna fiducia reciproca, le società moderne non possono ipotizzare alcun rapporto sociale che non sia sottomesso ad un’istanza “neutrale” di regolamentazione. Le cui forme pure sono lo scambio (sistema mercantile della legge del più forte) e la sottomissione (sistema totalitario di obbedienza all’onnipotente Stato centrale). La forma mista che va attualmente affermandosi si traduce in una proliferazione di regole giuridiche astratte che passano gradualmente al setaccio ogni aspetto dell’esistenza, in modo tale che il rapporto con gli altri diventa oggetto di un controllo permanente, mirante a scongiurare la minaccia di implosione.
Soltanto il ritorno alle comunità e alle aggregazioni politiche di dimensioni umane permetterà di rimediare all’emarginazione, alla dissoluzione del legame sociale, alla sua reificazione e alla sua giuridicizzazione.
4. Il politico: un’essenza e un’arte
Il politico è legato al fatto che le finalità della vita sociale sono sempre molteplici. Possiede un’essenza e leggi proprie, che non sono riducibili né alla razionalità economica né all’etica, né all’estetica, né alla metafisica, né al sacro. Presuppone che vengano distinte e accettate nozioni come quelle di pubblico e privato, comando e obbedienza, deliberazione e decisione, cittadino e straniero, amico e nemico. Se vi è una morale in politica – dal momento che l’autorità punta al bene comune e si ispira alla norma composta dai valori e dalle abitudini della collettività al cui interno viene esercitata –, ciò non significa per questo che una morale individuale sia politicamente applicabile. I regimi che rifiutano di riconoscere l’essenza del politico, che negano la pluralità dei fini o che favoriscono la spoliticizzazione, sono per definizione “impolitici”.
Il pensiero moderno ha sviluppato l’idea illusoria di una “neutralità” della politica, riducendo il potere all’efficacia amministrativa, all’applicazione meccanica di norme giuridiche, tecniche o economiche: il “governo degli uomini” avrebbe dovuto essere ricalcato sull’”amministrazione delle cose”. Ma la sfera pubblica è tuttora il luogo di affermazione di una visione particolare della “vita buona”. Da questa concezione che ci si fa del bene discende l’idea di ciò che è giusto, e non l’inverso.
Il primo scopo di ogni azione politica è, all’interno, far regnare la pace civile, ovvero la sicurezza e l’armonia fra i componenti della società, e all’esterno proteggerli dalle minacce. In rapporto a tale scopo, la scelta che viene operata tra valori in concorrenza (maggiore libertà, eguaglianza, unità, diversità, solidarietà, ecc.) contiene necessariamente in sé una componente di arbitrarietà: non si dimostra, ma si afferma e si giudica sulla base dei risultati. La diversità tra le visioni del mondo è una delle condizioni che consentono al politico di emergere. La democrazia, dal momento che riconosce il pluralismo delle aspirazioni e dei progetti e mira ad organizzarne il confronto pacifico a tutti i livelli della vita pubblica, è un regime eminentemente politico. Sotto questo profilo, è preferibile alle classiche confische della legittimità da parte del denaro (plutocrazia), della competenza (tecnocrazia), della legge divina (teocrazia) o dell’eredità (monarchia), ma altresì alle forme più recenti di neutralizzazione del politico attraverso la morale (ideologia dei diritti dell’uomo), l’economia (globalizzazione mercantile), il diritto (governo dei giudici) o i media (società dello spettacolo). Se l’individuo come persona si mette alla prova all’interno di una comunità, come cittadino si costruisce nella democrazia, unico regimo che gli offre la partecipazione alle discussioni e alle decisioni pubbliche, nonché l’eccellenza attraverso l’educazione e la costruzione di sé.
La politica non è una scienza, abbandonata alla ragione o al solo metodo, bensì un’arte, che esige in primo luogo la prudenza. Essa implica sempre un’incertezza, una pluralità di scelte, una decisione sulle finalità. L’arte di governare conferisce un potere di arbitrato fra le possibilità, congiunto ad una capacità di costrizione. Il potere è sempre soltanto un mezzo, che vale esclusivamente in funzione delle finalità a cui si suppone serva.
In Jean Bodin, erede dei legisti, la fonte dell’indipendenza e della libertà risiede in una illimitata sovranità del potere del principe, concepita sul modello del potere assolutistico papale. Questa concezione è quella di una “teologia politica” fondata sull’idea di un organo politico supremo, un “Leviatano” (Hobbes) che si presume controlli i corpi, le menti e le anime. Essa ha ispirato lo Stato nazionale assolutista, unificato, centralizzato, che non sopporta né i poteri locali né la condivisione del diritto con poteri territoriali vicini e si crea tramite l’unificazione amministrativa e giuridica, l’eliminazione dei corpi intermedi (accusati di essere delle “feudalità”) e il progressivo sradicamento delle culture locali. Ed è progressivamente sfociata nell’assolutismo monarchico, nel giacobinismo rivoluzionario e poi nei moderni totalitarismi; ma anche nella “Repubblica senza cittadini”, dove non esiste più niente tra la società civile atomizzata e lo Stato amministrativo. A questo modello di società politica la Nuova Destra oppone quello, ereditato da Altusio, in cui la fonte dell’indipendenza e della libertà risiede nell’autonomia e lo Stato si definisce innanzitutto come una federazione di comunità organizzate e di molteplici lealtà.
In questa concezione, che ha ispirato le costruzioni imperiali e federali, l’esistenza di una delega al sovrano non fa mai perdere al popolo la facoltà di fare o di abrogare le leggi. Il popolo, nelle sue diverse collettività organizzate (o “stati”) è l’unico detentore ultimo della sovranità. I governanti sono
superiori a qualunque cittadino preso individualmente, ma rimangono sempre inferiori alla volontà generale espressa dal corpo dei cittadini. Il principio di sussidiarietà si applica a tutti i livelli. La libertà di una collettività non è in antinomia con una sovranità condivisa. L’ambito del politico, infine, non si riduce allo Stato: la persona pubblica si definisce come uno spazio pieno, un tessuto continuo di
gruppi, famiglie, associazioni, collettività locali, regionali, nazionali o sovranazionali. Il politico non consiste nel negare questa continuità organica, ma nel basarsi su di essa. L’unità politica discende da una diversità riconosciuta; in altre parole, deve venire a patti con una certa “opacità” del sociale: la perfetta “trasparenza” della società nei confronti di se stessa è un’utopia che non incoraggia la comunicazione democratica, ma, al contrario, favorisce la sorveglianza totalitaria.
4. L’economico: al di là del mercato
Per quanto lontano si risalga nella storia delle società umane, talune regole presiedono sempre alla produzione, alla circolazione e al consumo dei beni necessari alla sopravvivenza degli individui e dei gruppi. Pertanto, contrariamente ai presupposti sia del liberalismo che del marxismo, l’economia non ha mai formato l’”infrastruttura” della società: la sovradeterminazione economica (“economicismo”) è l’eccezione, non la regola. Numerosi miti associati alla maledizione del lavoro (Prometeo, stupro della Terra-Madre), del denaro (Creso, Gullveig, Tarpea), dell’abbondanza (Pandora) rivelano del resto che l’economia è stata assai presto intesa come la “parte maledetta” di ogni società, l’attività che minaccia di spezzarne l’armonia. L’economia era allora svalutata non perché non fosse utile, ma per il fatto stesso che era soltanto quello. Così come si era ricchi in quanto si era potenti, e non l’inverso: la potenza era accompagnata da un dovere di condivisione e di protezione nei confronti degli affidati. Il “feticismo della merce” non è solo un inconveniente del capitalismo moderno, ma rinvia a una costante antropologica: la produzione in abbondanza di beni differenziati solleva l’invidia, il desiderio mimetico, che produce a sua volta disordine e violenza.
In tutte le società premoderne, l’economico è incastrato, contestualizzato negli altri ordini dell’attività umana. L’idea secondo la quale, dal baratto al mercato moderno, gli scambi economici sarebbero sempre stati regolati dal confronto tra offerta e domanda e dal conseguente emergere di un equivalente astratto (il denaro) e di valori oggettivi (valori d’uso, di scambio, di utilità, ecc.) è una favola inventata dal liberalismo. Il mercato non è un modello ideale, che sarebbe possibile universalizzare in virtù della sua astrattezza. Prima di essere un meccanismo è un’istituzione, e questa istituzione non può essere astratta dalla sua storia, né dalle culture che l’hanno generata. Le tre grandi forme di circolazione dei beni sono la reciprocità (dono associato al controdono, suddivisione paritaria o egualitaria), la redistribuzione (centralizzazione e ripartizione della produzione da parte di un’autorità unica) e lo scambio. Esse non rappresentano degli “stadi di sviluppo”, ma si sono più o meno sempre trovate a coesistere. La società moderna è caratterizzata dall’ipertrofia dello scambio mercantile: passaggio dall’economia con mercato all’economia di mercato, poi alla società di mercato. L’economia liberale ha tradotto l’ideologia del progresso in religione della crescita: s suppone che il “sempre più” di consumo e di produzione condurrà l’umanità alla felicità. È innegabile che lo sviluppo economico moderno ha soddisfatto certi bisogni primari sino ad allora inaccessibili alla maggior parte delle persone; ma è nondimeno vero che l’accrescimento artificiale dei bisogni grazie alle strategie di seduzione del sistema degli oggetti (pubblicità) sfocia per forza in una impasse. In un mondo dalle risorse limitate e soggetto al principio di entropia, una certa decrescita costituisce l’orizzonte inevitabile dell’umanità.
Per l’ampiezza delle trasformazioni messe in atto, la mercantilizzazione del mondo è stata, fra il XVI e il XX secolo, uno dei fenomeni più importanti che l’umanità abbia conosciuto. La sua demercantilizzazione sarà una delle principali poste in gioco nel XXI secolo. Per arrivarci, bisogna ritornare all’origine dell’economia: “oikos-nomos”, le leggi generali del nostro habitat nel mondo, leggi che includono gli equilibri ecologici, le passioni umane, il rispetto dell’armonia e della bellezza della natura, e più in generale tutti gli elementi non quantificabili che la scienza economica ha arbitrariamente escluso dai suoi calcoli. Ogni vita economica implica la mediazione di un ampio ventaglio di istituzioni culturali e di strumenti giuridici. Oggi, l’economia deve essere ricontestualizzata all’interno del mondo vivente, nella società, nella politica e nell’etica.
5. L’etica: costruzione di sé
Le categorie fondamentali dell’etica sono universali: ritroviamo dappertutto la distinzione tra il nobile e l’ignobile, il bene e il male, il buono e il cattivo, l’ammirabile e lo spregevole, il giusto e l’ingiusto. In compenso, la designazione degli atti che si accompagnano a ciascuna di queste categorie varia a seconda delle epoche e delle società. La Nuova Destra respinge qualunque concezione puramente
morale del mondo, ma ovviamente ammette che nessuna cultura può fare a meno di distinguere il valore etico degli atteggiamenti e dei comportamenti. La morale è indispensabile a quell’essere aperto che è l’uomo; è una conseguenza della sua libertà. Pur esprimendo delle regole generali che costituiscono ovunque la condizione della sopravvivenza delle società, si ricollega anche alle abitudini
(mores) e non può essere completamente dissociata dai contesti al cui interno si applica. Ma non può essere considerata sotto l’esclusivo punto di vista della soggettività. La massima “right or wrong my country”, ad esempio, non significa che il mio paese ha sempre ragione, ma che resta il mio paese anche quando ha torto. Il che implica che io possa eventualmente dargli torto, e dunque che dispongo di una norma che va al di là della mia sola appartenenza ad esso.
Sin dal tempo dei Greci, l’etica indica per gli europei le virtù il cui esercizio costituisce il fondamento della “vita buona”: la generosità contro l’avarizia, l’onore contro la vergogna, il coraggio contro la vigliaccheria, la giustizia contro l’iniquità, la temperanza contro l’esagerazione, il senso del dovere
contro la diserzione, l’audacia contro la cautela, il disinteressamento contro la cupidigia e via dicendo. Il buon cittadino è quello che tende sempre verso l’eccellenza in ciascuna di queste virtù, diceva Aristotele. Questa volontà di eccellenza non esclude affatto che esistano vari modi di vita
(contemplativa, attiva, lucrativa, ecc.), ciascuno dei quali è legato a codici morali diversi, che si trovano disposti in ordine gerarchico nella città: la tradizione europea, espressa dall’antico modello trifunzionale, fa ad esempio prevalere la saggezza sulla forza e la forza sulla ricchezza.
La modernità ha soppiantato l’etica tradizionale, al contempo aristocratica e popolare, con due tipi di morale borghese: la morale utilitaristica di Bentham, fondata sul calcolo materialistico dei piaceri e delle pene (è bene ciò che aumenta il piacere della maggioranza degli individui), e la morale deontologica di Kant, fondata su una concezione unitaria di ciò che è giusto, verso la quale dovrebbero
tendere tutti gli individui, conformandosi a una legge morale universale. Quest’ultimo approccio sottintende l’ideologia dei diritti dell’uomo, che è contemporaneamente morale minima e arma strategica dell’etnocentrismo occidentale. Si tratta di un’ideologia basata su una contraddizione in
termini. Tutti gli uomini hanno dei diritti, ma non possono esserne titolari in quanto esseri isolati: il diritto sanziona un rapporto di equità, che implica la dimensione sociale. Nessun diritto è dunque concepibile senza un contesto specifico in grado di definirlo, una società in grado di riconoscerlo e definire i doveri che ne rappresentano la contropartita e degli strumenti di costrizione sufficienti a farlo applicare. Quanto alle libertà fondamentali, esse non si decretano, ma esigono di essere conquistate e garantite. Il fatto che gli europei abbiano conseguito questo risultato imponendo a forza di lotte un diritto delle genti fondato sull’autonomia non implica minimamente che tutti i popoli del pianeta siano tenuti a considerare allo stesso modo la garanzia dei diritti.
Contro l’”ordine morale”, che confonde norma sociale e norma morale, bisogna poi sostenere la pluralità delle forme della vita sociale, pensare assieme l’ordine e la sua trasgressione, Apollo e Dioniso. Si potrà uscire dal relativismo e dal nichilismo di quello che Nietzsche ha chiamato “l’ultimo uomo”, che oggi si svelano su un fondale di materialismo pratico, solamente ricreando un senso, vale a dire facendo ritorno ai valori condivisi, portatori di certezze concrete sperimentate e difese da comunità consapevoli di se stesse.
6. La tecnica: mobilitazione del mondo
La tecnica accompagna l’uomo sin dalle origini: l’assenza di specifiche difese naturali, la deprogrammazione dei nostri istinti e lo sviluppo delle nostre capacità cognitive vanno di pari passo con una crescente trasformazione del nostro ambiente. Ma la tecnica è stata per lungo tempo regolata
da imperativi non tecnici: necessaria armonia tra l’uomo, la città e il cosmo, rispetto della natura come dimora dell’Essere, sottomissione della potenza (prometeica) alla saggezza (olimpica), ripudio dell’hybris, preoccupazione per la qualità piuttosto che per la produttività, e così via.
L’esplosione tecnica della modernità si spiega con la scomparsa di queste codificazioni etiche, simboliche o religiose. Affonda le sue lontane radici nell’imperativo biblico “Riempite la Terra e dominatela” (Genesi), che Cartesio farà suo due millenni dopo invitando l’uomo a “rendersi signore e possessore della natura”. La cesura dualista teocentrica tra l’essere increato e il mondo creato si è in tal modo trasformata in cesura dualista antropocentrica tra il soggetto e l’oggetto, in cui il secondo è offerto senza riserve al dominio del primo. La modernità ha inoltre assoggettato la scienza (contemplativa) alla tecnica (operativa), dando così vita alla “tecnoscienza” integrata, la cui unica ragion d’essere è una trasformazione sempre più accelerata del mondo. Nel solo XX secolo, il nostro modo di vita ha conosciuto più sconvolgimenti che nei quindicimila anni che lo hanno preceduto. Per la prima volta nella storia dell’umanità, ogni nuova generazione deve integrarsi in un mondo che quella precedente non ha sperimentato.
La tecnica si sviluppa per sua stessa natura come un sistema autonomo: ogni nuova scoperta viene immediatamente assorbita nella potenza globale di operatività che contribuisce a rendere più complessa e a rafforzare. Il recente sviluppo delle tecnologie di stoccaggio e circolazione
dell’informazione (cibernetica, informatica) accelera a una velocità prodigiosa questa integrazione sistemica, di cui Internet è l’esempio più conosciuto: questa rete non ha né centro decisionale né controllo di ingresso e uscita, ma mantiene e accresce di continuo l’interazione fra i milioni di terminali che le sono collegati.
La tecnica non è neutra, ma obbedisce a un certo numero di valori che ne guidano il corso: operatività, efficacia, efficienza. Il suo assioma è semplice: tutto quello che è possibile può essere e sarà effettivamente realizzato, essendo inteso che solo un sovrappiù di tecnica potrà rimediare ai difetti dell’attuazione delle tecniche già esistenti. La politica, la morale, il diritto vengono soltanto dopo, per giudicare gli effetti desiderabili o indesiderabili dell’innovazione. La natura cumulativa del progresso tecnoscientifico – che conosce stagnazioni, ma mai regressione – ha a lungo confortato l’ideologia del progresso, certificando l’accrescimento dei poteri dell’uomo sulla natura e riducendo i rischi e le incertezze. La tecnica ha così dato all’umanità nuovi mezzi di esistenza, ma nel contempo gli ha fatto perdere le ragioni per vivere, dal momento che il futuro sembra dipendere unicamente dall’indefinita estensione del dominio razionale del mondo. L’impoverimento che ne risulta viene sempre più nettamente percepito come la scomparsa di una vita autenticamente umana sulla Terra. Dopo aver esplorato l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande, la tecnoscienza inizia adesso a dominare lo stesso uomo, soggetto e nel contempo oggetto delle proprie manipolazioni (clonazione, procreazione artificiale, schedatura genetica, ecc.). L’uomo diventa il semplice prolungamento degli strumenti che ha creato, adottando una mentalità tecnomorfa che ne aumenta la vulnerabilità.
Tecnofobia e tecnofilia sono due atteggiamenti inaccettabili. La conoscenza e le sue applicazioni non sono biasimevoli in sé, ma l’innovazione non può valere per il solo fatto della sua novità. Contro il riduzionismo scientista, il positivismo arrogante e l’oscurantismo ottuso, è importante subordinare lo sviluppo tecnico alle nostre scelte sociali, etiche e politiche, nonché alle nostre aspettative (principio di prudenza), e reinserirlo nella simbologia di una visione del mondo come pluriverso e continuum.
7. Il mondo: un pluriverso
La diversità è implicita nel movimento stesso della vita, che evolve in maniera sfuggente, facendosi più complessa. La pluralità e la varietà delle razze, delle etnie, delle lingue, delle abitudini o delle religioni caratterizza lo sviluppo dell’umanità sin dalle origini. Di fronte a questo fatto, si manifestano due atteggiamenti opposti. Per gli uni, questa diversità bioculturale è un fardello e bisogna sempre ed
ovunque ridurre gli uomini a ciò che hanno in comune, il che non manca di comportare, per reazione, tutta una serie di effetti perversi. Per gli altri, fra i quali ci iscriviamo, le differenze sono ricchezze che è opportuno difendere e coltivare. La Nuova Destra manifesta una profonda avversione per l’indifferenziato. Essa ritiene che un buon sistema è quello che trasmette perlomeno tante differenze
quante ne ha ricevute. La vera ricchezza del mondo consiste prima di tutto nella diversità delle culture e dei popoli.
La conversione dell’Occidente all’universalismo è stata la causa principale della sua volontà di convertire a sua volta il resto del mondo, un tempo alla sua religione (crociate), ieri ai suoi principii politici (colonialismo), oggi al suo modello economico e sociale (sviluppo) o ai suoi principii morali
(diritti dell’uomo). Intrapresa sotto l’egida dei missionari, dei militari e dei mercanti, l’occidentalizzazione del pianeta ha rappresentato un movimento imperialista alimentato dal desiderio di cancellare qualsiasi alterità imponendo al mondo un modello di umanità pretesamente superiore,
invariabilmente presentato come “progresso”. In questo quadro, l’universalismo omogeneizzante non era altro che la proiezione e la maschera di un etnocentrismo allargato alle dimensioni del pianeta.
Questa occidentalizzazione-globalizzazione ha modificato la maniera in cui intendiamo il mondo. Le tribù primitive si definivano “gli uomini”, lasciando intendere di considerarsi le uniche rappresentanti della propria specie. Un romano e un cinese, un russo e un inca potevano vivere nella medesima epoca senza avere consapevolezza della reciproca esistenza. Quei tempi sono finiti: a causa della smisurata pretesa dell’Occidente di rendere il mondo interamente presente a se stesso, viviamo in una nuova epoca nella quale le differenze etniche, storiche, linguistiche o culturali coesistono nella piena consapevolezza della loro identità e dell’alterità che la riflette. Per la prima volta nella storia, il mondo è un pluriverso, un ordine multipolare nel quale grandi insiemi culturali si trovano messi a confronto
l’uno con l’altro in una temporalità planetaria condivisa, vale a dire in tempo zero. Tuttavia, la modernizzazione si distacca a poco a poco dall’occidentalizzazione: nuove civiltà accedono ai moderni strumenti della potenza e della conoscenza, senza per questo rinnegare le loro eredità storiche e culturali a profitto dei valori o delle ideologie occidentali.
L’idea secondo cui potremmo giungere alla “fine della storia”, caratterizzata dal trionfo planetario della razionalità mercantile, generalizzando il modo di vita e le forme politiche dell’Occidente liberale, è falsa. Stiamo viceversa vivendo l’emergere di un nuovo “nomos della Terra”, un nuovo ordinamento delle relazioni internazionali. L’Antichità e il Medioevo avevano visto svilupparsi in modo ineguale grandi civiltà autarchiche. Il Rinascimento e l’Età classica furono segnati dall’emergere e dal consolidarsi degli Stati nazionali in concorrenza tra loro per il dominio dell’Europa e poi del mondo. Il XX secolo ha visto disegnarsi un ordine bipolare nel quale si affrontavano il liberalismo e il marxismo, la potenza talassocratica americana e la potenza continentale sovietica. Il XXI secolo sarà segnato
dall’avvento di un mondo multipolare articolato attorno a civiltà emergenti: l’europea, la nordamericana, l’iberoamericana, l’arabo-musulmana, la cinese, l’indiana, la giapponese e così via. Queste civiltà non sopprimeranno i vecchi radicamenti locali, tribali, provinciali o nazionali; in
compenso si imporranno come la forma collettiva ultima nella quale gli individui potranno identificarsi al di qua della loro comune umanità. Esse saranno probabilmente chiamate a collaborare in taluni ambiti per difendere i beni comuni dell’umanità, in particolare quelli ecologici. In un mondo multipolare, la potenza si definisce come capacità di resistere all’influenza degli altri piuttosto che di imporre la propria. Il nemico principale di questo pluriverso di grandi insiemi autocentrici è ogni civiltà che si pretende universale, si crede investita di una missione redentrice e vuole imporre il proprio modello a tutte le altre.
8. Il cosmo: un continuum
La Nuova Destra aderisce a una concezione unitaria del mondo, di cui sia la materia che la forma costituiscono soltanto variazioni di un medesimo tema. Il mondo è nel contempo uno e molteplice, integrando livelli diversi di visibilità e di invisibilità, diverse concezioni del tempo e dello spazio, diverse leggi di organizzazioni delle proprie componenti elementari. Microcosmo e macrocosmo si
interpenetrano e si rispondono. La Nuova Destra respinge pertanto la distinzione assoluta tra l’essere creato e l’essere increato, così come l’idea che il nostro mondo non sia altro che il riflesso di un retromondo. Il cosmo come realtà (physis) è il luogo di manifestazione dell’Essere, il luogo nel quale si disvela la verità (aletheia) della nostra coappartenenza a questo cosmo. “Panta rei”, ha scritto Eraclito: nel tutto si tiene l’apertura al tutto.
L’uomo trova e dà senso alla sua vita soltanto aderendo a ciò che la oltrepassa, a ciò che supera i limiti della sua costituzione. La Nuova Destra riconosce pienamente questa costante antropologica, che si manifesta in tutele religioni. Essa ritiene che il ritorno del sacro si compierà in un ricorso ai miti fondatori e nell’implosione delle false dicotomie: soggetto e oggetto, corpo e pensiero, anima e spirito, essenza ed esistenza, razionalità e sensibilità, ambito mitico e ambito logico, natura e sovranatura, ecc.
Il disincanto del mondo esprime la chiusura dello spirito moderno, incapace di proiettarsi al di là del materialismo e dell’antropocentrismo che ne sono parte costitutiva. La nostra epoca ha trasferito al solo soggetto umano gli antichi attributi divini (metafisica della soggettività), trasformando così il mondo in oggetto, vale a dire in insieme di mezzi messi a disposizione illimitata dei suoi fini. Questo ideale di impossessamento utilitario del mondo si è accoppiato a una concezione lineare della storia, dotata di un inizio (stato di natura, paradiso terrestre, età dell’oro, comunismo primitivo) e di una fine (società senza classi, regno di Dio, stadio ultimo del progresso, ingresso nell’era della pura razionalità, trasparente e irenica), egualmente necessari.
Per la Nuova Destra, passato, presente e futuro non sono momenti distinti di una storia orientata e vettorializzata, bensì le dimensioni permanenti di ogni istante vissuto. Sia il passato che il futuro si mantengono presenti in ogni attualità. A questa presenza – categoria fondamentale del tempo – si contrappone l’assenza: oblio dell’origine e oscuramento dell’orizzonte. Questa concezione del mondo si
esprimeva già nell’antichità europea, ove la si ritrova sia nei racconti cosmogonici, sia nelle forme di pensiero presocratiche. Il paganesimo della Nuova Destra non esprime altro che la simpatia cosciente nei confronti di questa antica concezione del mondo, sempre viva nel cuore e negli spiriti – proprio perché non è di ieri, ma di sempre. Di fronte ai surrogati settari delle religioni decadute e a certe parodie neopagane dei tempi di confusione, la Nuova Destra si colloca nella prospettiva della memoria più lunga: è sempre in un rapporto con l’origine che si inserisce il senso di quel che accade.
III. ORIENTAMENTI
1. Contro l’indifferenziazione e il tribalismo, per identità forti
La minaccia senza precedenti di omogeneizzazione che plana sul mondo porta per reazione a irrigidimenti identitari: irredentismi sanguinosi, nazionalismi convulsi e sciovinisti, tribalizzazioni selvagge e così via. La responsabilità di questi atteggiamenti condannabili incombe in primo luogo alla globalizzazione (politica, economica, tecnologica, finanziaria) che li ha prodotti. Negando agli individui il diritto di porsi all’interno di identità collettive ereditate dalla storia, imponendo un modo uniforme di rappresentazione, il sistema occidentale ha paradossalmente fatto nascere forme deliranti di affermazione di sé. La paura dell’Identico ha preso il posto della paura dell’Altro. Questa situazione è aggravata in Francia dalla crisi dello Stato, che per due secoli ha preteso di essere il principale produttore simbolico della società e il cui cedimento provoca un vuoto più importante che nelle altre nazioni occidentali. La questione dell’identità è chiamata ad assumere un’importanza sempre maggiore nei decenni a venire. Spazzando via i sistemi sociali che attribuivano agli individui un posto in un ordine riconosciuto, la modernità ha infatti stimolato l’interrogativo sull’identità, risvegliato un desiderio di collegamento e di riconoscimento sulla scena pubblica; ma non ha saputo né voluto soddisfarlo. Il “turismo universale” non è che un’alternativa risibile al ripiegamento su se stessi.
Di fronte all’utopia universalista e agli irrigidimenti particolaristici, la Nuova Destra afferma la forza delle differenze, che non sono né uno stadio transitorio verso un’unità superiore né un dettaglio accessorio della vita privata, bensì la sostanza stessa dell’esistenza sociale. Queste differenze sono certamente native (etniche, linguistiche), ma anche politiche. La cittadinanza designa nel contempo l’appartenenza, la lealtà e la partecipazione a una vita pubblica che si distribuisce a vari livelli: si può essere contemporaneamente cittadini del proprio quartiere, della propria città, della propria regione, della propria nazione e dell’Europa, a seconda della natura del potere devoluto a ciascuna di queste scale di sovranità. Non si può invece essere cittadini del mondo, perché il “mondo” non è una categoria politica. Voler essere cittadini del mondo significa rapportare la cittadinanza ad un’astrazione che fa parte del vocabolario di una Nuova Classe liberale.
La Nuova Destra difende la causa dei popoli, perché il diritto alla differenza è a suo avviso un principio che vale unicamente in virtù della sua generalità: si è autorizzati a difendere la propria differenza soltanto se si è capaci anche di difendere quella degli altri; il che significa che il diritto alla differenza non può essere strumentalizzato per escludere i diversi. La Nuova Destra difende inoltre le etnie, le lingue e le culture regionali minacciate di scomparsa, nonché le religioni native. Sostiene i popoli in lotta contro l’imperialismo occidentale.
2. Contro il razzismo, per il diritto alla differenza
Il razzismo non può essere definito come la preferenza per l’endogamia, che discende dalla libertà di scelta degli individui e dei popoli (il popolo ebraico, ad esempio, deve la sua sopravvivenza soltanto al rifiuto del matrimonio misto). Dinanzi all’inflazione dei discorsi semplificatori, propagandistici e moralizzatori, bisogna ritornare al vero senso delle parole: il razzismo è una teoria che postula o che
tra le razze esistano diseguaglianze qualitative tali da di distinguere razze globalmente “superiori” e “inferiori”, o che il valore di un individuo si deduce interamente dalla sua appartenenza razziale, o ancora che il dato razziale costituisce il fattore esplicativo centrale della storia umana.
Questi tre postulati sono stati sostenuti insieme oppure separatamente. Tutti e tre sono falsi. Sebbene le razze esistano, e divergano in rapporto a questo o a quel criterio statisticamente isolato, non vi sono tra di esse differenze qualitative assolute. Non esiste d’altronde nessun paradigma che abbracci l’intera specie umana e che consenta di collocarle in un qualche ordine gerarchico globale. È chiaro,
poi, che un individuo vale prima di tutto per le qualità che gli sono proprie. Il razzismo non è una malattia dello spirito, generata dal pregiudizio o dalla superstizione “premoderna” (favola liberale dell’irrazionalità come fonte di tutto il male sociale). È una dottrina errata, storicamente datata, che ha
origine dal positivismo scientista, secondo il quale si può “scientificamente” misurare in assoluto il valore delle società umane, e dall’evoluzionismo sociale, che tende a descrivere la storia dell’umanità come una storia unitaria divisa in “stadi” corrispondenti alle diverse tappe del “progresso” (alcuni popoli sarebbero, provvisoriamente o definitivamente, più “avanzati” di altri).
Di fronte al razzismo, esistono un antirazzismo universalista e un antirazzismo differenzialista. Il primo sfocia indirettamente nello stesso risultato del razzismo che denuncia. Altrettanto allergico alle differenze quanto lo è quest’ultimo, nei popoli riconosce unicamente la comune appartenenza alla specie e tende a considerare le loro specifiche identità transitorie o secondarie. Riconducendo l’Altro all’Identico in una prospettiva strettamente assimilazionista, esso è dunque per definizione incapace di riconoscere e rispettare l’alterità per quello che è. L’antirazzismo differenzialista, nel quale si riconosce la Nuova Destra, ritiene viceversa che l’irriducibile pluralità della specie umana ne costituisca la ricchezza e si sforza di ridare un senso positivo all’universale, non contro la differenza bensì a partire da essa. Per la Nuova Destra, la lotta contro il razzismo non passa né attraverso la negazione delle razze né attraverso la volontà di fonderle in un insieme indifferenziato, bensì attraverso il duplice rigetto dell’esclusione e dell’assimilazione. Né apartheid, né melting-pot: accettazione dell’altro in quanto altro in una prospettiva dialogica di reciproco arricchimento.
3. Contro l’immigrazione, per la cooperazione
A causa della sua rapidità e del suo carattere massiccio, l’immigrazione di popolamento, così come la conosciamo oggi in Europa, costituisce un fenomeno indiscutibilmente negativo. Essa rappresenta essenzialmente un modo di sradicamento forzato, le cui motivazioni sono nel contempo di ordine economico – movimenti spontanei o organizzati dai paesi poveri verso i paesi ricchi in condizioni di minore vitalità demografica – e simbolico – attrattiva della civiltà occidentale, che si impone grazie alla svalutazione delle culture autoctone a profitto di un modo di vita consumistico. La sua responsabilità ricade in prima battuta non sugli immigrati, ma sui paesi industrializzati, i quali, dopo aver imposto la divisione internazionale del lavoro, hanno ridotto l’uomo allo stato di merce delocalizzabile. L’immigrazione non è auspicabile né per i migranti, che devono abbandonare il paese natale per un altro in cui sono accolti come suppletivi di bisogni economici, né per le popolazioni che li accolgono, che si trovano, senza averlo scelto, poste di fronte a trasformazioni a volte brutali del loro ambiente
umano e urbano. È chiaro che i problemi dei paesi terzi non si risolveranno con trasferimenti generalizzati di popolazioni. La Nuova Destra è pertanto favorevole a una politica di restrizione dell’immigrazione, accoppiata a una cooperazione accresciuta con i paesi del Terzo mondo, nei quali le solidarietà organiche e i modi di vita tradizionali sono ancora vivi, allo scopo di superare gli squilibri indotti dalla globalizzazione liberale.
Riguardo alle popolazioni di origine immigrata che risiedono oggi in Francia, e delle quali sarebbe illusorio attendersi il ritorno a casa in massa, lo Stato nazionale giacobino non ha saputo proporre altro che un modello di assimilazione puramente individuale a una cittadinanza astratta, che non vuol saperne delle identità collettive e delle differenze culturali. Il numero dei migranti, la distanza culturale che talvolta le separa dalla popolazione di accoglienza, e soprattutto la profonda crisi che attanaglia tutti i tradizionali crogioli di integrazione (partiti, sindacati, religioni, scuola, esercito, ecc.), rendono oggi questo modello sempre meno credibile. La Nuova Destra ritiene che l’identità etnoculturale delle varie comunità che vivono oggi in Francia non debba più essere circoscritta all’ambito privato, e debba viceversa essere oggetto di un vero e proprio riconoscimento nella sfera politica. Essa aderisce dunque ad un modello di tipo comunitario, che consenta agli individui che lo desiderano di non recidere le proprie radici, di mantenere di vita le proprie strutture collettive e di non essere costretti a pagare il rispetto di una necessaria legge comune con l’abbandono della cultura di appartenenza. Questa cultura comunitaria potrebbe, nel lungo periodo, tradursi in una dissociazione tra cittadinanza e nazionalità.
4. Contro il sessismo, per il riconoscimento dei generi
La differenza tra i sessi è la prima e la più fondamentale delle differenze naturali, giacché la nostra umanità si assicura la riproduzione soltanto per suo tramite: essendo originariamente sessuata, l’umanità non è una ma duplice. Al di là della biologia, questa differenza si ricolloca nei generi maschile e femminile, che determinano nella vita sociale due maniere di concepire l’altro e il mondo e costituiscono, per gli individui, il tipo di destino sessuato. Se l’esistenza di una natura femminile e di una natura maschile è poco contestabile, essa non esclude che gli individui di ciascun sesso possano divergere rispetto ad essa a seconda dei casi genetici o delle scelte socioculturali. Globalmente,
tuttavia, un buon numero di valori e di atteggiamenti si lasciano suddividere nei generi femminile e maschile, a seconda del sesso che è più suscettibile di veicolarli: cooperazione e competizione, mediazione e repressione, seduzione e dominio, empatia e distacco, relazionalità e astrazione, affettività e direttività, persuasione e aggressione, intuizione sintetica e intelligenza analitica, ecc. La concezione moderna di individui astratti e distaccati dalla loro identità sessuale, legata a un’ideologia “indifferenzialista” che neutralizza la differenza sessuata, non è meno pregiudizievole verso le donne di quanto non lo sia il sessismo tradizionale, che per secoli ha considerato le donne come degli uomini incompleti. Essa è una fra distorta del dominio maschile, il cui principale effetto è stato quello di escludere le donne dall’ambito della vita pubblica per poi finire con l’accogliervele… a condizione che si spoglino della loro femminilità.
Pretendendo che i generi maschile e femminile dipendano esclusivamente dalla costruzione sociale (“donne non si nasce, lo si diventa”), il femminismo universalista è caduto in una trappola androcentrica, che consiste nell’aderire a valori “universali” astratti, che in ultima analisi non sono altro che valori maschili. Il femminismo differenzialista, al quale la Nuova Destra aderisce, non esita viceversa ad auspicare che la differenza dei sessi si inserisca nella sfera pubblica e ad affermare diritti specificamente femminili (diritto alla verginità, diritto alla maternità, diritto all’aborto), pur favorendo, in contrasto sia con il sessismo che con l’utopia unisex, la promozione tanto degli uomini quanto delle donne, attraverso l’affermazione e la constatazione dell’eguale valore delle loro specifiche nature.
5. Contro la Nuova Classe, per un’autonomia che parta dalla base
La civiltà occidentale in via di unificazione promuove oggi l’ascesa planetaria di una casta dirigente la cui unica legittimità risiede nella manipolazione astratta (logico-simbolica) dei segni e dei valori del sistema esistente. Aspirando alla crescita ininterrotta del capitale e al regno definitivo di un’ingegneria sociale trionfante, questa Nuova Classe forma la colonna vertebrale dei media, delle grandi imprese nazionali o multinazionali, delle organizzazioni internazionali, dei principali corpi dello Stato. Essa produce e riproduce ovunque il medesimo tipo umano: competenze fredde, razionalità distaccata dal reale, individualismo astratto, convinzioni utilitariste, umanitarismo di facciata, indifferenza alla storia, incultura notoria, allontanamento dal mondo vissuto, sacrificio del reale al virtuale, propensione alla corruzione, al nepotismo e al clientelismo. Questo processo si situa all’interno della logica di
concentrazione e omogeneizzazione del dominio mondiale: più il potere si allontana dal cittadino, meno prova il bisogno di giustificare le proprie scelte e legittimare il proprio ordine; più la società propone compiti impersonali, meno si apre agli uomini di qualità; più il privato sconfina nel pubblico, meno i meriti individuali vengono riconosciuti da tutti; più si deve adempiere ad una funzione, meno si può svolgere un ruolo. La Nuova Classe spersonalizza e deresponsabilizza in tal modo la direzione effettiva delle società occidentali.
Dopo la fine della guerra fredda e il crollo del blocco sovietico, la Nuova Classe si trova di nuovo posta a confronto con tutta una serie di conflitti (fra il capitale e il lavoro, l’eguaglianza e la libertà, il pubblico e il privato) che per mezzo secolo si era sforzata di tenere fuori dalla scena. Nel frattempo la sua inefficacia, i suoi sprechi e la sua inefficienza appaiono sempre più evidenti. Il sistema tende a
chiudersi su se stesso cooptando delle rotelle intercambiabili del meccanismo, mentre i popoli provano indifferenza o collera nei confronti di un’élite amministrativa che non parla più la loro lingua. Su tutti i grandi temi sociali, tra governanti che ripetono lo stesso discorso tecnocratico del mantenimento del disordine costituito e governati che ne subiscono le conseguenze nella loro vita quotidiana si sta
scavando un fossato, e lo spettacolo massmediale si interpone per distogliere l’attenzione del mondo quale è e dirottarla verso il mondo come viene rappresentato. In alto il gergo duplice e burocratico dei tecnocrati, il cicaleccio moralistico e il conforto dei redditi; in basso il penoso confronto con la realtà, la persistente domanda di senso e il desiderio di valori condivisi.
Soddisfare l’aspirazione popolare (o “populista”), che non ha che disprezzo per le “élites” e indifferenza per le tradizionali divisioni politiche, oggi diventate obsolete, implica ridare maggiore autonomia alle strutture di base che corrispondono a modi di vita (nomoi) quotidianamente vissuti. Per ricreare in maniera più conviviale, lontano dall’anonimato di massa, dalla mercantilizzazione dei valori e dalla reificazione dei rapporti sociali, condizioni di vita sociale che consentano all’immaginario collettivo di
formare specifiche rappresentazioni del mondo, le comunità devono decidere da sole in tutti gli ambiti che le concernono, e i loro membri devono partecipare a tutti i livelli alle deliberazioni e decisioni democratiche. Non è lo Stato assistenziale, burocratico e tecnocratico, che deve decentralizzarsi venendo loro incontro. Sono le comunità stesse che devono concedere allo Stato il potere di intervenire esclusivamente negli ambiti per i quali esse non sono competenti.
6. Contro il giacobinismo, per l’Europa federale
La prima guerra dei Trent’anni, conclusa dai trattati di Westfalia, ha segnato la consacrazione dello Stato nazionale come modello dominante di organizzazione politica. La seconda guerra dei Trent’anni (1914-1945) ha viceversa firmato l’inizio della sua disgregazione. Lo Stato nazionale, nato dalla monarchia assoluta e dal giacobinismo rivoluzionario, è ormai troppo grande per gestire i piccoli problemi e troppo piccolo per affrontare quelli grandi. In un pianeta globalizzato, il futuro appartiene ai grandi insiemi di civiltà capaci di organizzarsi in spazi autocentrici e di dotarsi di una potenza sufficiente a resistere alle influenze altrui. Di fronte agli Stati Uniti e alle nuove civiltà emergenti,
l’Europa è così chiamata a costruirsi su una base federale, riconoscendo l’autonomia di tutte le sue componenti e organizzando la cooperazione fra le regioni e le nazioni che la compongono. La civiltà europea si farà grazie all’addizione, e non alla negazione, delle sue culture storiche, permettendo a tutti i suoi abitanti di riassumere pienamente coscienza delle origini comuni. Il principio di sussidiarietà
deve esserne la chiave di volta: a tutti i livelli, l’autorità inferiore delega il suo potere all’autorità superiore solamente nei campi che sfuggono alla sua competenza.
Contro la tradizione centralizzatrice che confisca tutti i poteri a vantaggio di un solo livello, contro l’Europa burocratica e tecnocratica che consacra gli abbandoni di sovranità senza riportarli a un livello superiore, contro un’Europa che rischia di essere solo uno spazio unificato di libero scambio, contro l’”Europa delle nazioni”, semplice addizione di egoismi nazionali che non premunisce contro un ritorno delle guerre straniere, contro una “nazione europea” che non sarebbe altro che una proiezione ingrandita dello Stato nazionale giacobino, l’Europa (occidentale, centrale e orientale) deve riorganizzarsi dalla base al vertice; gli Stati esistenti devono federarsi all’interno per potersi federare meglio all’esterno, in una pluralità di statuti particolari, temperati da uno statuto comune. Ogni livello di associazione deve avere in questa situazione un proprio ruolo e una propria dignità, non derivati dall’istanza superiore ma fondati sulla volontà e sul consenso di tutti coloro che ne sono parte. Al vertice dell’edificio spetterebbero dunque solo le decisioni relative all’insieme dei popoli e delle comunità federati: diplomazia, difesa, grandi decisioni economiche, messa a punto delle norme
giuridiche fondamentali, protezione dell’ambiente, ecc. L’integrazione europea è necessaria anche in taluni ambiti della ricerca, dell’industria e delle nuove tecnologie della comunicazione. La moneta unica deve essere gestita da una Banca centrale assoggettata al potere politico europeo.
7. Contro la spoliticizzazione, per il rafforzamento della democrazia
La democrazia non ha fatto la sua comparsa con la Rivoluzione del 1789, ma costituisce, sin dai tempi della città greca e delle antiche “libertà” germaniche, una tradizione costante in Europa. Essa non si riconduce né alle “democrazie popolari” dei paesi dell’Est di un tempo, né alla democrazia parlamentare liberale oggi dominante nei paesi occidentali. Democrazia non significa né il regime dei partiti né il corpo di procedure dello Stato di diritto liberale, ma in primo luogo il regime nel quale il popolo è sovrano. Non è la discussione perpetua, ma la decisione in vista del bene comune. Il popolo può delegare la propria sovranità ai dirigenti che incarica, non spogliarsene a loro vantaggio. La legge della maggioranza, indicata dal voto, non porta a ritenere che la verità dipenda dal maggior numero: è semplicemente una tecnica che permette di assicurare, per quanto possibile, la concordanza di vedute fra il popolo e i suoi dirigenti. La democrazia è infine il regime maggiormente in grado di farsi carico del pluralismo della società: risoluzione pacifica dei conflitti di idee e rapporti non coercitivi fra la maggioranza e la minoranza; la libertà di espressione delle minoranze viene dedotta dalla possibilità che esse hanno di costituire la maggioranza di domani.
Nella democrazia, dove il popolo è il soggetto del potere costituente, il principio fondamentale è quello dell’eguaglianza politica. Questo principio è distinto da quello dell’eguaglianza giuridica di tutti gli uomini, che non può dar vita ad alcuna forma di governo (l’eguaglianza comune a tutti gli uomini è un’eguaglianza apolitica, perché le manca il corollario di un’ineguaglianza possibile). L’eguaglianza democratica non è un principio antropologico (non ci dice niente sulla natura dell’uomo), non presuppone che tutti gli uomini siano naturalmente eguali, ma solo che tutti i cittadini siano politicamente eguali, perché appartengono tutti egualmente alla stessa comunità politica. Si tratta dunque di un’eguaglianza sostanziale, fondata sull’appartenenza. Come ogni principio politico, implica
la possibilità di una distinzione; nel caso in questione, quella tra cittadini e non-cittadini. Il concetto essenziale della democrazia non è l’individuo, né l’umanità, bensì l’insieme dei cittadini politicamente riuniti in popolo. La democrazia è il regime che, collocando nel popolo la fonte della legittimità del potere, si sforza di realizzare per quanto possibile l’identità fra governanti e governati: la differenza oggettiva, esistenziale, tra gli uni e gli altri non può mai essere una differenza qualitativa. Questa identità è l’espressione politica di quella del popolo che, per il tramite dei suoi governanti, acquisisce la possibilità di essere politicamente presente a se stesso. La democrazia implica quindi un popolo capace di agire politicamente nella sfera della vita pubblica. L’astensionismo, il ripiego sulla vita privata, la privano di senso.
La democrazia è oggi minacciata da tutta una serie di degenerazioni e patologie: crisi della rappresentanza, intercambiabilità dei programmi politici, mancata consultazione del popolo nelle grandi decisioni che ne toccano l’esistenza, corruzione e tecnocratizzazione, discredito dei partiti trasformatisi in macchine per farsi eleggere i cui dirigenti vengono selezionati unicamente sulla base della loro capacità di farsi selezionare, spoliticizzazione per effetto della duplice polarità moraleeconomia, preponderanza di lobbies che difendono i propri interessi particolari contro l’interesse generale, e via dicendo. A ciò si aggiunge il fatto che siamo usciti dalla problematica politica moderna: i partiti sono tutti più o meno riformisti, i governi sono tutti più o meno impotenti. La “presa del potere”, nel senso leninista dell’espressione, non sfocia più in niente. Nell’universo delle reti, la rivolta è possibile, la rivoluzione no.
Riscoprire lo spirito democratico implica il non accontentarsi esclusivamente della democrazia rappresentativa, e il cercare invece di mettere in atto a tutti i livelli una vera democrazia partecipativa (“quel che tocca tutti deve essere affare di tutti”). A tale scopo occorre destatalizzare il politico, ricreando spazi di cittadinanza alla base: ciascun cittadino deve essere un attore dell’interesse
generale, ciascun bene comune deve essere designato e difeso come tale nella prospettiva di un ordine politico concreto. Il cliente consumatore, lo spettatore passivo e l’avente diritto privato saranno superati soltanto da una forma radicalmente decentrata di democrazia di base, che assegni ad ognuno un ruolo nella scelta e nella padronanza del proprio destino. Anche la procedura referendaria potrebbe essere riattivata dall’iniziativa popolare. Contro l’onnipotenza del denaro, unica autorità suprema della società moderna, occorre per quanto è possibile imporre la separazione tra la ricchezza e il potere politico.
8. Contro il produttivismo, per la suddivisione del lavoro
Il lavoro (dal latino tripalium, strumento di tortura) non ha mai occupato un posto centrale nelle società arcaiche o tradizionali, comprese quelle che non hanno mai conosciuto la schiavitù. Poiché risponde alle costrizioni della necessità, il lavoro non realizza la nostra libertà, al contrario dell’opera, in cui ciascuno esprime la propria realizzazione. È stata la modernità, nella sua logica produttivistica di
mobilitazione totale delle risorse, a fare del lavoro nel contempo un valore in sé, il principale modo di socializzazione, una forma illusoria dell’emancipazione e dell’autonomia degli individui (“la libertà attraverso il lavoro”). Funzionale, razionale e monetarizzato, questo lavoro “eteronomo”, che gli individui compiono il più delle volte per sottomissione piuttosto che per vocazione, ha senso solo in vista dello scambio mercantile, e si inserisce sempre all’interno di un calcolo contabile. La produzione serve ad alimentare un consumo che l’ideologia del bisogno offre di fatto a mo’ di compensazione del tempo perduto per produrre. I compiti di prossimità di un tempo sono così stati progressivamente monetarizzati, spingendo gli uomini a lavorare per gli altri al fine di pagare chi lavora per loro. Il senso della gratuità e della reciprocità si è andato un po’ alla volta perdendo in un mondo in cui niente ha più valore ma tutto ha un prezzo (ovvero in cui ciò che non può essere quantificato in termini di denaro è considerato trascurabile o inesistente). Nella società salariale, tutti perdono perciò troppo spesso il loro tempo nel tentare di guadagnarsi da vivere.
Il fatto nuovo è che, grazie alle nuove tecnologie, produciamo sempre più beni e servizi con sempre meno uomini. Questi aumenti di produttività fanno della disoccupazione e della precarietà dei fenomeni ormai strutturali e non più congiunturali. Essi favoriscono peraltro la logica del capitale, che si serve della disoccupazione e della delocalizzazione per ridurre il potere negoziale dei salariati. Ne risulta che l’uomo non è più soltanto sfruttato, ma reso sempre più inutile: l’esclusione rimpiazza l’alienazione in un mondo globalmente sempre più ricco ma in cui si conta un numero in continua crescita di poveri (fine della teoria classica dello “svuotamento”). L’impossibile ritorno alla piena occupazione implica dunque la necessità di rompere con la logica del produttivismo e di considerare sin d’ora l’uscita progressiva dall’era dei salari come modo centrale di inserimento nella vita sociale.
La diminuzione del tempo di lavoro è un dato secolare che rende obsoleto l’imperativo biblico (“lavorerai con il sudore della tua fronte”). La riduzione negoziata e la suddivisione del tempo di lavoro devono essere incoraggiate, con possibilità di accomodamenti flessibili (annualizzazione, congedi sabbatici, soggiorni di formazione, ecc.) per tutti i compiti “eteronomi”: lavorare meno per lavorare meglio e per liberare il tempo di vita. In una società nella quale l’offerta mercantile si estende sempre più, mentre aumenta il numero di coloro il cui potere di acquisto ristagna o diminuisce, è del resto imperativo dissociare progressivamente il lavoro dal reddito, studiando la possibilità di instaurare un’allocazione generale di esistenza o reddito minimo di cittadinanza, versato senza contropartita a tutti i cittadini dalla nascita sino alla morte.
9. Contro la fuga in avanti finanziaria, per un economia al servizio del mondo vivente
Aristotele distingueva l’”economia”, che mira a soddisfare i bisogni degli uomini, dalla “crematistica”, la cui unica finalità è la produzione, la circolazione e l’appropriazione del denaro. Il capitalismo industriale è stato a poco a poco dominato da un capitalismo finanziario che mira ad organizzare una redditività massima a breve termine a detrimento dello stato reale delle economie nazionali e dell’interesse a lungo termine dei popoli. Questa metamorfosi si è tradotta nella smaterializzazione dei bilanci d’impresa, nella titolizzazione del credito, nello scatenamento della speculazione, nell’emissione anarchica di obbligazioni non affidabili, nell’indebitamento dei singoli, delle imprese e delle nazioni, nel ruolo di primo piano degli investitori internazionali e dei fondi di investimento mirati a guadagni speculativi, eccetera. L’ubiquità dei capitali consente ai mercati finanziari di imporre la loro legge ai
politici. L’economia reale è soggetta all’incertezza e alla precarietà, mentre un’immensa bolla finanziaria mondiale esplode regolarmente in sacche regionali, dando vita a scosse che si propagano in tutto il sistema.
Il pensiero economico si è dal suo canto immobilizzato in dogmi alimentati da formalismi matematici che possono pretendere al titolo di scienza solo escludendo per principio tutti gli elementi non quantificabili. Gli indici macroeconomici (Pil, Pnl, tasso di crescita e così via), ad esempio, non danno alcuna indicazione sullo stato reale di una società: le catastrofi, gli incidenti o le epidemie vi vengono contabilizzati in maniera positiva, giacché aumentano l’attività economica.
Contro una ricchezza arrogante che pensa solamente ad accrescersi speculando sulle ineguaglianze e sulle sofferenze che crea, bisogna rimettere l’economia al servizio dell’uomo accordando la priorità ai bisogni reali degli individui e alla loro qualità della vita, introducendo su scala internazionale una tassa sui movimenti di capitali, annullando il debito del Terzo mondo e contemporaneamente rivedendo drasticamente il sistema dello “sviluppo”: priorità all’autosufficienza e alla soddisfazione dei mercati
interni, rottura con il sistema della divisione internazionale del lavoro, emancipazione delle economie locali dai diktat della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, adozione di regole sociali e ambientali per inquadrare gli scambi internazionali. È infine opportuno uscire progressivamente dal duplice vicolo cieco rappresentato dall’economia amministrata inefficace e dall’economia mercantile ipercompetitiva, rafforzando il terzo settore (associazioni, mutue, cooperative) e le organizzazioni autonome di aiuto reciproco (sistema di scambi locali), fondati sulla responsabilità condivisa, sulla libera adesione e sulla mancanza di fini di lucro.
11. Contro il gigantismo, per le comunità locali
La tendenza al gigantismo e alla concentrazione produce individui isolati e dunque vulnerabili e sprovvisti di difese. L’emarginazione generalizzata e l’insicurezza sociale sono la logica conseguenza di questo sistema che ha fatto strame di tutte le istanze di reciprocità e di solidarietà. Di fronte alle
antiche piramidi verticali di dominio che non ispirano più fiducia, di fronte alle burocrazie che raggiungono con sempre maggiore rapidità il loro livello di incompetenza, stiamo entrando in un mondo fluido di reti cooperative. L’antica opposizione tra società civile omogenea e Stato assistenziale monopolistico viene gradualmente superata dalla istituzione di un intero tessuto di organizzazioni
creatrici di diritti e di collettività deliberative e operative. Queste comunità si formano a tutti i livelli della vita sociale: dalla famiglia al quartiere, dalla frazione alla città, dalla professione alla sfera del tempo libero, ecc. Soltanto a questo livello locale può essere ricreata un’esistenza all’altezza degli
uomini, non parcellizzata, liberata dagli imperativi pressanti della velocità, della mobilità e del rendimento, sostenuta da valori condivisi e fondamentalmente orientata verso il bene comune. La solidarietà non deve più essere percepita come la conseguenza di un’eguaglianza anonima (mal) garantita dallo Stato assistenziale, bensì come il risultato di una reciprocità messa in atto alla base da collettività organiche che riassumano il compito di svolgere funzioni di rassicurazione, condivisione ed equità. Soltanto persone responsabili all’interno di comunità responsabili possono istituire una giustizia sociale che non sia sinonimo di assistenzialismo.
Il ritorno al locale, che può essere eventualmente facilitato dal telelavoro in comune, è di natura tale da restituire alle famiglie la loro vocazione naturale di educazione, socializzazione e aiuto reciproco, consentendo l’interiorizzazione di regole sociali oggi imposte esclusivamente dall’esterno. La rivitalizzazione delle comunità locali deve anche andare di pari passo con una rinascita delle tradizioni popolari, la cui modernità ha provocato il deperimento o, peggio ancora, la mercantilizzazione. Mantenendo vivi la convivialità e il senso della festa, le tradizioni inculcano ritmi e forniscono punti di riferimento. Scandendo nel contempo le età e le stagioni, i grandi momenti dell’esistenza e i periodi dell’anno, alimentano l’immaginario simbolico e tengono vivo il legame sociale. Esse non sono mai immobili, ma in costante rinnovamento.
12. Contro le città cementificate, per città a dimensione umana
L’urbanistica subisce da cinquant’anni a questa parte la dittatura della bruttezza, del nonsenso o del breve termine: città-dormitorio prive di orizzonti, zone a padiglioni prive d’anima, periferie grigie che servono da depositi municipali, interminabili centri commerciali che sfigurano l’ingresso delle città, proliferazione dei “non luoghi” anonimi che si rivolgono ad utenti frettolosi, centri-città abbandonati ai
soli esercizi commerciali e spogliati della loro vita tradizionale (bar, università, teatri, cinema, piazze, ecc.), edifici privi di uno stile comune affastellati l’uno accanto all’altro, quartieri degradati e lasciati all’abbandono fra due rabberciamenti o, al contrario, sorvegliati in permanenza da vigili e telecamerespia, desertificazione delle campagne e sovrappopolazione urbana…
Gli habitat non vengono più costruiti per vivere, ma per sopravvivere in un ambiente urbano sfigurato dalla legge della massima redditività e della funzionalità razionale. Ma un luogo è prima di tutto un legame: lavorare, circolare, abitare sono verbi che non indicano più funzioni isolabili ma atti complessi, che interessano la vita sociale nella sua totalità.
La città deve essere ripensata come il luogo di incontro di tutte le nostre potenzialità, il labirinto delle nostre passioni e delle nostre azioni, piuttosto che come l’espressione geometrica e fredda della razionalità pianificatrice. Architettura e urbanistica si inseriscono del resto in una storia e in una geografia particolari, di cui devono essere il riflesso. Ciò implica la rivalutazione di un’urbanistica radicata e armonica, la riabilitazione degli stili regionali, lo sviluppo delle frazioni e delle città medie a rete attorno a capitali regionali, l’estrazione delle regioni rurali dalle nicchie nelle quali sono state confinate, la distruzione progressiva delle città-dormitorio e della concentrazioni strettamente commerciali, l’eliminazione dell’onnipresente pubblicità e la diversificazione dei mezzi di trasporto:
abolizione della dittatura dell’automobile individuale, trasporto di merci via rotaia, rivitalizzazione dei trasporti in comune, presa in considerazione degli imperativi ecologici.
13. Contro la demonia della tecnica, per un’ecologia integrale
In un mondo finito, non tutte le curve possono essere eternamente ascendenti: sia le risorse che la crescita hanno necessariamente i loro limiti. La rapida generalizzazione, su scala planetaria, del livello occidentale di produzione e di consumo condurrebbe in pochi decenni all’esaurimento della quasi totalità delle risorse naturali disponibili e ad una serie di sconvolgimenti climatici e atmosferici dalle conseguenze imprevedibili per la specie umana. Lo sfiguramento della natura, l’impoverimento esponenziale della biodiversità, l’alienazione dell’uomo da parte della macchina, la degradazione della nostra alimentazione dimostrano abbondantemente che “sempre più” non è sinonimo di “sempre meglio”. Questa constatazione, che si pone senza equivoci in contrasto con l’ideologia del progresso e con ogni altra concezione monolineare della storia, è stata fatta, assai fondatamente, dai movimenti ecologisti. Essa ci impone di assumere consapevolezza delle nostre responsabilità nei confronti dei mondi organico e inorganico al cui interno ci muoviamo.
La “megamacchina” conosce esclusivamente il principio di redditività. Bisogna contrapporle il principio di responsabilità, che ordina alle generazioni presenti di agire in maniera tale che le generazioni future conoscano un mondo che non sia meno bello, meno ricco e meno diverso di quello che noi abbiamo conosciuto. In parallelo, occorre riaffermare il primato dell’essere sull’avere. Spingendosi oltre, l’ecologia integrale richiama al superamento dell’antropocentrismo moderno e alla consapevolezza di
una coappartenenza dell’uomo e del cosmo. Questa trascendenza immanente fa della natura un partner e non un avversario. Non cancella la specificità dell’uomo ma gli nega il posto esclusivo che gli era stato assegnato dal cristianesimo e dall’umanesimo classico. Alla hybris economica e al prometeismo tecnico oppone il senso della misura e la ricerca dell’armonia. Si impone una concertazione mondiale per stabilire norme obbligatorie in materia di difesa della biodiversità – l’uomo ha anche dei doveri verso gli animali e i vegetali – e di diminuzione dell’inquinamento terrestre e atmosferico. Le imprese o le collettività che inquinano devono essere tassate in misura proporzionale delle loro esternalità negative. Una certa deindustrializzazione del settore agro-alimentare dovrebbe
favorire la produzione e il consumo locali, e nel contempo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. I sistemi che rispettano il rinnovamento ciclico delle risorse naturali devono essere difesi nel Terzo mondo e adottati nuovamente in forme prioritarie nelle società “sviluppate”.
14. Per la libertà della mente ed un ritorno al dibattito di idee
Il declinante pensiero moderno, incapace di rinnovarsi, impotente e deluso dinanzi al fallimento del suo progetto, si è a poco a poco trasformato in una vera e propria polizia intellettuale, la cui funzione è di scomunicare tutti coloro che si allontanano dai dogmi dell’ideologia dominante. Gli ex rivoluzionari “pentiti” si sono allineati al sistema esistente, conservando però, degli antichi amori, il gusto delle purghe e degli anatemi. Questo nuovo tradimento dei chierici si basa sulla dittatura di un’opinione pubblica modellata dai media sul criterio dell’isteria purificatrice, della sensibilità acquietante o dell’indignazione selettiva. Invece di cercare di capire il secolo che viene, si rimuginano polemiche obsolete, si riciclano argomentazioni che non sono altro che strumenti per escludere o screditare. La riduzione del politico a gestione ottimale di una crescita sempre più problematica esclude del resto la scelta di un cambiamento radicale di società e anche, più semplicemente, la possibilità di una
discussione aperta sulle finalità ultime dell’azione collettiva.
Il dibattito democratico si trova così ad essere annientato: non si discute più, si denuncia; non si argomenta più, si accusa; non si dimostra più, si impone. Ogni pensiero, ogni opera sospetta di “deviazionismo” o di “distorsione” si vede accusata di simpatia cosciente o incosciente per idee presentate come altrettanti spauracchi. I censori, incapaci di sviluppare un proprio pensiero o di confutare quello degli altri, inseguono ormai le intenzioni. Questo impoverimento senza precedenti dello spirito critico è ulteriormente aggravato in Francia dalla tendenza parigina all’autocompiacimento, che riduce a qualche quartiere della capitale la cerchia degli ambienti frequentabili. Si finisce così col dimenticare le regole normali della discussione. Si dimentica che la libertà di opinione, di cui si accetta con indifferenza la scomparsa, non sopporta per principio alcuna eccezione. Temendo le scelte e disprezzando le aspirazioni del popolo, si preferisce ad esse l’ignoranza
delle masse.
Per farla finita con questa cappa di piombo, la Nuova Destra predica un ritorno al pensiero critico, e nel contempo si batte per una totale libertà di espressione. Contro ogni censura, contro il pensiero usa-egetta e la futilità delle mode, la Nuova Destra afferma più ce mai la necessità di un vero lavoro del
pensiero. Si batte per un ritorno al dibattito di idee, al di fuori dei vecchi spartiacque che imbrigliano gli approcci trasversali e le nuove sintesi. Fa appello al fronte comune degli spiriti liberi contro gli eredi di Trissotin, di Tartufo e di Torquemada.
Alain de Benoist e Charles Champetier
DIORAMA LETTERARIO Numero 229-230 (ottobre-novembre 1999)