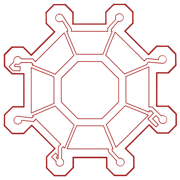E’ possibile accostarsi a d’Annunzio come a un contemporaneo senza falsare quei valori storici dai quali tuttavia non può prescindere la lettura di un testo poetico? Non è solo possibile, rispondiamo noi citando nel titolo di questo contributo il celebre testo di Jan Kott su Shakespeare, ma è questo l’unico modo di comprendere il grande poeta, scrittore e drammaturgo italiano. L’originalità dell’interpretazione passa attraverso questa intuizione di fondo: l’uomo, stritolato nell’ingranaggio della storia, ritrova la propria dimensione umana, la dimensione dell’intelligenza, interrogandosi sul senso della vita e del proprio destino.
Ossessioni tragiche, oscure neurosi, selvagge nefandezze e fantasie oniriche, bagni di sangue e cupidigie irriducibili, voglie di vendette e languori splenetici attraversano la produzione letteraria e teatrale dannunziana mettendole i coturni, innalzandola cioè verso aure sublimi o sprofondandola in notturni deliri: d’Annunzio pretende infatti un teatro, una rappresentazione inverosimile, innaturale, mitica, per sfuggire ai condizionamenti della scena quotidiana. Mito, dunque, in quanto condensazione/spostamento del reale, il che implica un’ulteriore manifestazione del travestimento.
La tensione allo scacco è il punto di fondo delle opere narrative e teatrali di Gabriele d’Annunzio, proprio in contrasto con il progetto di rivincita e di conquista che appartiene al superuomo.
Sia a opera dello stesso Gabriele, sia a opera dei suoi biografi, la vita di d’Annunzio è stata vista secondo due angolature opposte ed entrambe poco significative: da un lato il mito del vivere inimitabile, che comporta la ricostruzione a posteriori della biografia come esempio di una predestinazione mirabile all’eccezionalità nell’arte e nelle vicende, nell’azione e nella parola; dall’altro lato, la separazione completa della biografia dell’opera, onde l’aneddotica erotica ed economica finisce a essere del tutto staccata dalla scrittura. Il fatto è che d’Annunzio ha, almeno in parte, costruito la propria biografia come materiale della scrittura, non come esempio autonomo di straordinaria capacità d’azione e di vita. La vita è in funzione dell’opera, come i Taccuini dimostrano perfettamente e mirabilmente. Gli stessi caratteri d’oltranza e di sfida che ha la vita hanno senso soltanto se vengono messi a confronto con l’opera in cui si riversano, portandovi dentro la capacità estrema di trasgressione. d’Annunzio, insomma, crea una vita che deve figurare immediatamente come quella che, sola, può fornire le occasioni di un’arte ugualmente unica e inimitabile e, anzi, sempre in grado di rinnovarsi. Una narrazione della biografia dannunziana che non abbia come prospettiva d’interpretazione questa connessione della vita con la scrittura in quanto, appunto, funzione di questa non può che portare al pettegolezzo e alla catalogazione amatoria.
Avvicinarsi alla lettura dell’opera vastissima di d’Annunzio comporta alcune difficoltà iniziali (tuttavia oggi meno gravi e condizionanti di qualche anno fa, per merito della molta attenzione storica, filologica, documentaria, critica che è stata dedicata a d’Annunzio, e che ha fatto in gran parte giustizia dei troppi pregiudizi accumulatisi su di lui), in quanto significa prendere posizione nei riguardi dei giudizi negativi di carattere moralistico, politico, di gusto, che datano addirittura dai tempi di Primo vere e dall’ammonizione autorevole del Chiarini al giovanissimo autore a evitare in futuro ogni immoralismo, ma che hanno avuto le formulazioni più gravi nel secondo dopoguerra, in seguito all’abbastanza generica e superficiale assimilazione del linguaggio dannunziano a quello della retorica fascista e dell’azione politica a quella di Mussolini. E’, comunque, certamente singolare il caso di d’Annunzio, sì abilissimo nel captare di volta in volta le indicazioni delle mode culturali e letterarie non tanto italiane, quanto europee, attento al successo, pronto a identificare il mutarsi delle attese e dei gusti del pubblico, eppure costantemente cosciente di scrivere sul margine estremo di una tradizione che si va perdendo e morendo per l’urgere, intorno, di valori economici e di norme di vita mediocre e comune, propri della società di massa e dell’ideologia borghese, e totalmente negativi dei miti della bellezza e dell’arte. L’opera dannunziana coinvolge nella sua enormità quantitativa l’intero museo della tradizione letteraria, iconografica, musicale, decorativa, ma anche tutti i motivi, i temi, le inquietudini, le idee, le poetiche contemporanee, dal Carducci al Verga, dal naturalismo al simbolismo, dal Maupassant a Gide, da Swinburne a Claudel, e l’elenco potrebbe continuare a lungo: è, in fondo, un’enciclopedia, e come tale va letta, concedendo molto alla quantità e ancora più alla lotta, costante in d’Annunzio, fra la quantità dei materiali e la ricerca accanita e, a tratti, perfino ascetica del riscatto nella scrittura di tanto affollarsi di spunti, ragioni, reminiscenze, rifacimenti, riecheggiamenti, argomenti.
Il limite clamoroso della critica dannunziana è proprio nell’incapacità a raccogliere l’opera di d’Annunzio come una totalità, rinunciando alla scelta, all’antologia, alla formula definitrice di valori: ed è, del resto, un caso abbastanza singolare che d’Annunzio abbia avuto, fino, almeno, agli ultimi anni, anche dai critici in apparenza più favorevoli e ben disposti, un’attenzione sostanzialmente riduttiva (per non parlare della notevole disgrazia di essere capitato nelle mani dei ricercatori di “plagi”, anche illustri, come Lucini e Thovez, pronti a trasformarsi in pubblici accusatori di fronte al mondo e ai posteri). Si pensi al caso di Borghese, con la celebrazione della sensualità dannunziana nel momento della delusione e della stanchezza, che è formula destinata a durare almeno fino all’opera di Salinari, ma che, nella sostanza, taglia fuori non tanto il d’Annunzio eroico, che poi non è molto significativo dal punto di vista della quantità, quanto il d’Annunzio della rappresentazione della trasgressione sociale e morale e anche naturalistica; e, d’altra parte, il motivo della sensualità è un luogo comune della critica dannunziana, che coinvolge anche Croce, là dove, se mai, a ben vedere, si tratta piuttosto della forma attraverso cui entrano, nel museo totale di d’Annunzio, i luoghi e le situazioni della natura, anch’essa destinata a scomparire, in quanto bellezza, sotto i colpi della speculazione economica del mondo borghese, come appare dai celebri passi paralleli della distruzione delle ville e dei parchi di Roma ne Le Vergini delle Rocce e della rovina della villa veneta ne Il fuoco. Non meno indipendenza da tale formula risulta, in ultima analisi, essere anche la scelta, compiuta dai critici più severi, come Cecchi, del d’Annunzio “notturno” contro quello “solare” ed eroico, che è giudizio destinato ad avere particolare fortuna in ambito ermetico: impostazione critica che non tiene conto di quanto remote siano, nella storia dell’opera dannunziana, l’invenzione lirica e memoriale e il ripiegamento meditativo, datati almeno all’inizio del Novecento, e che, insieme alla formula della sensualità sublimata fuori dai sensi, non fa che perpetuare, appena dandole una riverniciatura d’apparenza di nuovo, quella del d’Annunzio come “poeta dei sensi”, anche in questo caso per non dover fare veramente in conti con tutto quello che d’Annunzio ha voluto effettivamente fare e, per di più, ponendo uno iato di comodo là dove c’è, invece, continuità di poetica e di idea della funzione della scrittura in concorrenza con la tradizione sull’orlo della morte della bellezza e dell’arte, ma anche in opposizione quantitativa e qualitativa rispetto alla produzione industriale di massa. Al polo opposto, l’approccio all’opera dannunziana deve ormai superare (non senza fatica, evidentemente) la diffidenza politica nei confronti del nazionalista, dell’interventista, dell’autore della marcia di Ronchi e della conquista di Fiume, non tanto perché tutta l’azione politica di d’Annunzio sia da estrarre fuori e da mettere da parte rispetto a quello che sarà, dopo, il fascismo, quanto perché non è possibile considerarla se non in rapporto con l’opera letteraria, come un aspetto o momento di essa, in quanto significativa di una scelta alternativa e compensativa rispetto alle difficoltà della scrittura, sempre più coinvolta nello sforzo disperato di salvare la bellezza dalla definitiva rovina nell’economicità come superato valore borghese, quindi sempre più spinta ai margini dell’effabilità, verso la morte, il silenzio.
Non interessa, in altre parole, tanto la distinzione possibile o no fra d’Annunzio e il fascismo (ma è significativo che, nei primissimi anni del fascismo, un giornalista attento e intelligente come Hemingway facesse nettamente la distinzione, di comportamento, ma, soprattutto, di idee), quanto il valore che la scelta dell’azione significa per l’intellettuale e lo scrittore d’Annunzio che, alla fine, ha verificato che le antinomie della storia non riescono a risolversi nella scrittura, che, piuttosto, rivela il fallimento, lo scacco: la rinuncia, appunto, della scrittura in quanto insufficiente, per cercare di attuare nella storia il tentativo di ripresa di iniziativa e di potere (e non diverso significato ha anche l’interesse per la macchina, in particolare per l’aviazione). In questa prospettiva, la lettura dannunziana deve proporsi anzitutto una piena disponibilità a riconoscervi alcuni fra i motivi fondamentali della cultura e della storia dell’ultimo Ottocento e del primo Novecento, in ambito europeo (e l’ampiezza delle letture dannunziane, anche ai fini del riecheggiamento e delle riproposta entro le teche del proprio museo di bellezza di ciò che altri e altrove hanno detto, ha anche il significato di un’apertura estremamente inquieta e attenta a una dimensione e a tradizioni ben lontane dalle limitazioni nazionali, anche come gusto, di tanti suoi contemporanei, mentre ugualmente significativo appare il coinvolgimento, nella cultura dannunziana, delle arti figurative e della musica): la crisi del naturalismo; il simbolismo; l’idea della morte dell’arte nella mediocrità borghese; la conseguente polemica antiborghese e la rappresentazione della malattia e della morte come le allegorie di una tragedia storica che segna la crisi dei valori eroici e della bellezza; la rinascita della tragedia, anche come tragedia politica e moderna, contro il dramma borghese; la risoluzione della struttura narrativa dalla costruzione romanzesca alla ricostruzione della memoria; la tensione verso la lirica pura, che coesiste con la poesia civile e politica; lo sforzo dell’innalzamento dell’edificio del poema moderno come viaggio nei miti classici e rivisitazione e rilettura di essi, onde fondare i nuovi miti dell’oggi; il senso profondo e quasi ossessivo della condizione di insufficienza e di scacco storico ed esistenziale che è connessa con l’azione e con la vita contemporanea, onde accade che i protagonisti dannunziani urtino costantemente contro la rovina e la sconfitta e ne siano vinti o travolti nella morte; la centrale concezione della scrittura come l’unico mezzo per dare dignità e durata alla volgarità e alla disfatta che è l’esistenza e che anche è l’arte nel mondo dell’industria e dell’economicità; la volontà del museo come estremo compito dell’artista, che deve fondarlo e popolarlo sull’orlo della sparizione; infine il senso vivissimo dell’arte come trasgressione rispetto alle norme del vivere borghese, quindi dell’attentato che la scrittura è sempre nei confronti dei comportamenti, dei principi, delle regole della società (e, poiché la vita non ha significato se non è riportata ad essere oggetto della scrittura, essa non può che essere ugualmente trasgressiva, soltanto in questo modo riuscendo a fornire alla scrittura i materiali che le occorrono). Sono, oltre tutto, motivi e temi che non sono ancora superati, oggi. La lettura dell’opera dannunziana può, allora, valere anche come invito a rivedere in essa, contro tutte le allusioni delle ideologie del nuovo che hanno attraversato il Novecento e che ancor di più numerose ed esclusive si sono fatte negli ultimi decenni, la formulazione di problemi tuttora fondamentali, spesso ripetuti e riproposti come se fossero originali e nuovi, in realtà ancora irrisolti proprio nei termini in cui d’Annunzio li aveva dapprima impostati (o, comunque, ne aveva accettato, cogliendola con estrema e sempre vigile acutezza, l’impostazione datane da altri, in Europa, fra Ottocento e Novecento). Se motivi e ragioni dell’opera di d’Annunzio ancora tanta resistenza e tanta opposizione incontrano, è anche perché permane un’idea di letteratura come ordine e misura, in rapporto con la quale la dismisura dannunziana appare un attentato e un’ingiuria, oppure l’idea della letteratura come rispecchiamento della sola realtà storico-fenomenica (e non come conoscenza e interpretazione). Avvicinarsi all’intera opera di d’Annunzio vale anche come invito a riconoscere di nuovo il carattere estremamente complesso e polivalente della letteratura, la pluridimensionalità dei modi e delle forme di essa, e, altresì ad attraversare veramente l’esperienza fondamentale della crisi dell’arte della vita che troppi ottimisti ufficiali di diversi regimi hanno cercato di cancellare o, almeno, di esorcizzare durante tutto il Novecento, per approdare, proprio in questi ultimi anni, a null’altro che a riprodurli, ahimè, in forme obiettivamente involgarite e parodiche di vitalismo o di rifiuto del fatto artistico, di recupero del privato ovvero della vita, poiché è vero quel che scrisse Marx, che la tragedia può essere seriamente tale soltanto la prima volta, poi non è che, appunto, una parodia di tragedia.