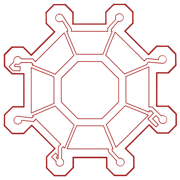Ho tentato di rispondere a questa domanda recensendo sul n. 355 (maggio-giugno 2020) di Diorama Letterario il nuovo saggio di Colin Crouch pubblicato da Laterza: “Combattere la post-democrazia”.
Ci sono situazioni in cui abbiamo in mente un concetto in maniera chiara e definita, ma restiamo irretiti nel più fastidioso degli inghippi linguistici, e tra una perifrasi e l’altra continuiamo a ripeterci «ce l’ho sulla punta della lingua!». Probabilmente non sapremo mai se durante la stesura di “Combattere la Postdemocrazia” Colin Crouch abbia provato questa sensazione di attesa, accompagnata da punte di insofferenza abbastanza pronunciate da spazientire chi le raggiunga. Certamente, però, mentre ci approssimavamo alla conclusione di questo suo nuovo saggio che fa da contrappunto al celeberrimo “Postdemocrazia”, si faceva sempre più viva l’impressione che mancassero all’appello due parole fondamentali per descrivere la deriva in cui sono incappati i sistemi politici del nostro tempo. Due parole – deficit democratico – raramente proferite dagli autori liberali.
Facendo leva sulla supposta impossibilità di definire con precisione quanto potere possa e debba detenere il popolo, costoro si inseriscono nella crepa scavata dalla distinzione teorica tra democrazia ideale e democrazia reale, e rispondono alle richieste di maggiore considerazione delle istanze popolari chiamando in causa l’ineliminabilità del divario tra le aspettative del corpo elettorale e i risultati conseguiti dalla classe politica, senza tuttavia specificare quale debba essere la soglia al di fuori della quale tale divario non sia più accettabile.
La democrazia ideale, si dice piuttosto plausibilmente, è un modello a cui la democrazia reale, pur nell’impossibilità di conformarvisi al cento per cento, deve tendere. Bene. Ma anche prescindendo dal problema, in ogni caso ineludibile, del tasso minimo di corrispondenza tra le due dimensioni, sottoponendo al vaglio critico della storia il concetto attualmente accettato di democrazia ideale si constata una deformazione del suo significato originario. Una deformazione che esprime l’esigenza dello Stato liberale di accreditarsi agli occhi dell’opinione pubblica, mitigando le asperità derivanti dalla definizione di «regime-liberale» mediante l’aggiunta di un termine totemico come quello di «democrazia», così da beneficiare della sua carica mitopoietica e legittimante.
A distanza di diciassette anni dalla precedente pubblicazione sull’argomento, Colin Crouch riporta all’attenzione del pubblico il problema del cattivo stato di salute in cui versano le democrazie occidentali, imperniate sul modello di liberal-democrazia impostosi dietro l’influsso degli Stati Uniti nella seconda metà del Novecento, e rafforzatosi – per estensione ed esiti – al termine della Guerra Fredda.
Dopo aver diagnosticato l’indebolimento della sostanza democratica, la sua progressiva erosione, il sociologo britannico esorta il lettore ad opporvisi, persuaso dall’idea che non ci si possa più limitare ad una mera gestione della sua parabola discendente. In vista di questo scopo torna a denunciarne le distorsioni, ma sembra farlo alla luce della presenza sempre più marcata delle formazioni populiste nell’arena politica, mostrandosi resipiscente rispetto all’ipotesi ventilata in precedenza, quando aveva inserito il populismo nel novero dei possibili oppositori della post-democrazia.
Oltre a sovrapporlo discutibilmente alla estrema destra colpevolizzandone la xenofobia – da una parte, tacendo il fatto che la paura è da sempre una delle molle fondamentali della politica, dall’altra, considerando meno legittima di altre una delle paure politicamente rilevanti -, Crouch addebita al populismo la responsabilità di contribuire ad esasperare la tendenza post-democratica, senza considerare l’inclinazione dei populisti a rivendicare più, e non meno, democrazia; più, e non meno, partecipazione; cosicché finisce per dedicare molto più inchiostro alla demonizzazione del poliedro populista di quanto non ne offra alla definizione di un progetto proteso a correggere la tendenza discussa.
Per descrivere la mentalità populista Crouch pigia ripetutamente il tasto del «pessimismo nostalgico», applicando questa etichetta al fenomeno detestato con un tono che ricalca la propensione dei liberal-progressisti a tessere comunque l’apologia del presente, banalizzando le posizioni degli avversari senza discuterle sine ira et studio, così da screditare in partenza chiunque prospetti la revocabilità delle scelte da essi compiute o condivise.
A differenza di quanto egli scrive, è proprio in questa attitudine all’universalismo, e non nei tentativi di tutelare la specificità delle culture, che si può ravvisare quella ostilità di fondo per la diversità che imputa ai populisti. Certamente, nella forma mentis populista c’è anche una componente nostalgica, e c’è nella misura in cui essa attinge al mito di una età aurea nella quale il popolo, prima di essere – per dirla con le parole usate da Marco Tarchi nella sua definizione del fenomeno in questione – artificiosamente diviso da forze ostili, si sarebbe configurato come una unità coesa e solidale, paragonabile a un corpo i cui organi, ciascuno nel proprio dominio, agiscono armonicamente in funzione dell’interesse collettivo ponendo in essere pratiche cooperative e non antagonistiche. Ma quanto al pessimismo, i populisti, non sembrano esserne provvisti in grande quantità. Anzi, lo stesso richiamarsi ad un mito, ad una fictio, è un loro espediente per imprimere forza alla propria azione, infondendo nel popolo l’idea che conquistando le redini del potere politico sia possibile realizzare una società più equa. Sono insomma troppo ottimisti di fronte al futuro, si potrebbe ribattere a Crouch, e tutt’altro che regressivi.
Rispetto a Postdemocrazia, in questo saggio appare molto più sfumata la descrizione dell’antinomia tra società democratica e società liberale, chiave di volta, in realtà, per riuscire a decrittare l’arretramento della componente democratica nei regimi occidentali, caratterizzati dalla prevaricazione degli attori privati sui poteri pubblici e dalla crescente esclusione del popolo – teoricamente soggetto e non oggetto del krátos – dai processi decisionali.
La questione è stata discussa recentemente dallo stesso Yves Mény, uno studioso assai noto e non sospettabile di simpatie illiberali. In un saggio pubblicato lo scorso anno per le edizioni Il Mulino, “Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico”, col piglio disincantato dello scienziato politico, Mény ha ripercorso la storia del paradossale connubio tra liberalismo e democrazia, categorie che in passato hanno intessuto una relazione di reciproca ostilità, esprimendo visioni antitetiche del rapporto tra cittadini e Stato. Chiunque ne osservasse i rispettivi statuti dottrinari, infatti, vi ricaverebbe due identità politiche tra loro irriducibili, e difficilmente potrebbe rintracciarvi elementi tali da lasciar presagire la commistione successivamente provocata dalla diffusa influenza del pensiero di Benjamin Constant, John Stuart Mill e Alexis de Tocqueville, rivelatosi decisivo per riformulare la teoria democratica in funzione della sua compatibilità con lo Stato liberale e, conseguentemente, con la predilezione per la concezione atomistica della società che ne innerva l’impianto dottrinario. Seguendo una prospettiva storica, Mény nota come, nel suo percorso di trasformazione ininterrotta, la democrazia abbia assorbito al proprio «interno regole, principi e istituzioni ispirate dal liberalismo politico ed economico. Questa evoluzione – aggiunge – è stata accolta ovunque come un progresso, nonostante ogni avanzata liberale facesse arretrare la componente propriamente democratica e popolare dei sistemi occidentali».
Diversamente da Mény, volgendo lo sguardo alla Scandinavia e agli Stati Uniti degli anni Trenta, ma anche all’Europa occidentale delineatasi dopo il 1945, Crouch interpreta il recente passato come un periodo in cui la democrazia si poteva considerare salda. E perciò, quando analizza le trasformazioni verificatesi sul finire del ventesimo secolo, associa al sostantivo democrazia il prefisso post, tracciando una linea di demarcazione tanto definita da evocare una cesura. Qui emerge in tutta la sua criticità la controversa questione del rapporto tra politica ed economia, e, nello specifico, il nodo della compatibilità tra democrazia e capitalismo: l’una per definizione votata alla finitudine, all’esercizio delle proprie funzioni entro confini chiaramente definiti, l’altro contraddistinto dalla vocazione a trasgredirli, potendo placare la propria tendenza a gonfiarsi illimitatamente soltanto invertendo il rapporto di autorità che lo subordina alla politica.
Certo, le istituzioni e le consuetudini democratiche sopravvivono, rimangono «pienamente» in vigore, ma le loro possibilità di intervento sulle questioni di interesse pubblico subiscono significative limitazioni, e la democraticità dei processi decisionali viene inficiata da gruppi di interesse senza alcun radicamento territoriale: una caratteristica che, nell’attuale contesto di globalizzazione ipertrofica, consente loro di imbastire una vera e propria concorrenza asimmetrica con lo Stato nazionale, svestendolo in misura crescente delle proprie prerogative. Si pensi per esempio alle possibilità di ricatto di cui dispongono in materia fiscale le grandi imprese transnazionali, specializzate nell’alterare la formazione delle politiche pubbliche minacciando di trasferirsi altrove ogniqualvolta le norme in essere non siano di loro gradimento. E alle conseguenze indotte da una ingerenza di questo tipo, destinata a sfociare in varie forme di dumping e, come effetto a cascata, a provocare risentimento tra nazioni dello stesso continente, riattivando sterili campanilismi con esiti esiziali per il rapporto di convivenza e cooperazione tra popoli accomunati dalle medesime radici. Da questo punto di vista, è indicativa l’attuale condizione dei popoli europei, incapaci di pensarsi come soggetto collettivo unico e costruirsi un proprio grande spazio di identità.
D’altronde, come a volte si sente dire, oggi il mondo è retto dalle forze di mercato. Benché di primo acchito la perentorietà di questa affermazione possa ingenerare scetticismo, tanto da essere derubricata al livello di una boutade da bastian contrari, l’autorevolezza della fonte da cui è tratta induce lo stesso Crouch a farvi riferimento nel capitolo dedicato alla crisi finanziaria, e a definirla «un raro esempio di aperta professione di postdemocrazia».
L’asserzione è ripresa da uno studio di Adam Tooze sulla “Grande recessione” e costituisce lo stralcio di una intervista rilasciata da Alan Greespan appena un anno prima del fallimento di Lehman Brothers, in concomitanza con la campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane. Presidente della Federal Reserve dal 1987 al 2006, in quella occasione Greespan si compiacque del fatto che «negli Stati Uniti, grazie alla globalizzazione, le decisioni politiche sono state perlopiù sostituite dalle forze di mercato globali. Sicurezza nazionale a parte, chiunque sarà il nuovo presidente non fa alcuna differenza. Il mondo è retto dalle forze di mercato». Le stesse forze descritte da Crouch approfondendo due casi particolarmente rappresentativi dello stravolgimento postdemocratico causato dall’intreccio tra élites politiche ed élites economiche.
L’analisi del primo caso ci porta in Grecia, e afferisce il tema delle condizioni imposte durante la crisi dell’Eurozona ai paesi debitori. Dopo un excursus storico sulle dinamiche di approdo alla moneta unica, Crouch problematizza la legittimità democratica delle condizioni di rimborso del debito a cui ha dovuto sottostare il governo ellenico in barba all’esito del referendum consultivo tenutosi il 5 luglio 2015. Contrariamente a quanto accade alle imprese private in molti paesi ad economica di mercato, il popolo greco non si è potuto dichiarare insolvente, e le sue sorti sono state decise da quattro entità sprovviste di un mandato diretto del popolo.
Alla metafora della Troika, infatti, andrebbe sostituita quella dei «quattro cavalieri dell’Apocalisse», con la Banca centrale europea, la Commissione europea e il Fondo Monetario Internazionale nel ruolo di longa manus dell’Institute of International Finance. Se la richiesta della Troika di sostituire con un proprio emissario i capi di governo greco e italiano viene definita dall’autore come «antidemocratica», la partecipazione alle sue riunioni dell’Iif – documentata sul “The Guardian” del 2 aprile 2012 – si configura come «un esempio di post-democrazia allo stato puro, e può essere considerat[a] un caso di silenziosa infiltrazione delle decisioni pubbliche da parte di interessi economici privati e particolari».
Il secondo caso concerne l’attività lobbistica condotta dai gruppi di interesse prima e dopo la crisi, una attività risultata determinante ai fini della deregolamentazione dei servizi finanziari avutasi con le riforme neoliberiste degli anni Ottanta, avviate da Stati Uniti e Gran Bretagna e successivamente estese a gran parte del globo. Insieme alla priorità assegnata dai governi, «dopo lo scoppio della crisi, agli interessi del settore bancario», il ruolo svolto dalle lobbies economico-finanziarie nel processo di deregolamentazione esprime uno dei paradossi del neoliberismo, il quale contravviene «alle tanto decantate virtù della separazione tra politica ed economia».
Tale contraddizione costituisce un cambio di paradigma di cui, perlomeno esplicitamente, l’autore non fa menzione, anche perché, pur collocandosi all’interno della cornice liberale, tende a distinguere tra il liberalismo politico e il liberismo economico, come se il dispiegarsi del secondo non fosse ammannito dalle acquisizioni del primo.
Una tendenza, quella di Crouch, espressa chiaramente nei passaggi del libro in cui, sebbene registri con amarezza la crescita delle disuguaglianze socioeconomiche nella società contemporanea, si fa latore di una democrazia che «deve essere sempre aperta al lobbismo», a suo giudizio «parte integrante di una società libera». Va precisato che con l’espressione cambio di paradigma ci riferiamo al passaggio del campo liberale classico da un approccio volto a ridurre al minimo l’intervento dello Stato ad un approccio di tipo neoistituzionalista, che chiama in causa il concetto di buona governance di ispirazione angloamericana promuovendo l’intervento statale, nei limiti, però, della disposizione di un ambiente favorevole agli investimenti privati.
Alain de Benoist ha trattato il tema in un articolo pubblicato su Trasgressioni, illustrando come, con la teoria della governance e il passaggio al modello neoistituzionalista, il neoliberalismo non compia una svolta ideologica rispetto al liberalismo classico, ma attui piuttosto un cambio di atteggiamento. E con esso, si potrebbe aggiungere, il liberalismo palesa l’astrattezza del proprio modello fondativo, ovvero di una speculazione intellettuale tutt’altro che neutra, basata sul discutibile assunto di matrice smtihiana secondo cui il perseguimento dell’interesse individuale verrebbe naturalmente armonizzato da una «mano invisibile» capace di incanalarlo verso l’interesse della società nel suo complesso.
Ora, nei neoliberali resta intatta l’idea della superiorità paradigmatica del mercato, arena nella quale ciascun individuo persegue razionalmente il proprio interesse egoistico; il suo funzionamento a pieno regime e l’estensione della sua logica utilitaristica ad ogni ambito della società, tuttavia, non vengono più considerati l’espressione di uno stato di natura alterato dall’intervento delle istituzioni pubbliche, un dato di fatto da salvaguardare inducendo lo Stato a disimpegnarsi, ma divengono un obiettivo da realizzare mobilitando lo stesso Stato di cui per decenni hanno stigmatizzato l’«invadenza». Nella loro ottica, scrive de Benoist, lo Stato ha il compito di «mettere la società in capacità di concorrenza», intervenendo «sulla società affinché essa possa essere regolata dal mercato». Pertanto, «non si tratta più di creare una sfera mercantile che sfugga al controllo dello Stato, ma di mettere lo Stato al servizio degli imperativi del mercato».
In definitiva, l’aspetto più discutibile del libro di Crouch non risiede tanto nella sua dimensione descrittiva, che offre spunti molto interessanti nelle parti in cui si analizza il ruolo esercitato dalla globalizzazione in salsa capitalista nella perdita di terreno delle istituzioni democratiche a vantaggio di «élites privilegiate», benché sia poco condivisibile nelle parti relative all’arcipelago populista, che risentono, tra l’altro, di un utilizzo discutibile del consunto spartiacque destra-sinistra. Il vero problema sta nel presupposto su cui questo libro si fonda: l’idea, cioè, che liberalismo e democrazia siano categorie complementari. Come, di nuovo, ha mostrato Alain de Benoist in “Democrazia, il problema”, invece, mentre il liberalismo dissocia l’individuo dal cittadino, reggendosi sul postulato che l’interesse individuale sia anteriore e anteposto all’interesse collettivo, la democrazia prescrive esattamente il contrario: la Polis è – in tutto e per tutto – anteriore all’individuo.
Note:
1. Per approfondire le differenze tra populismo ed estrema destra cfr. Marco Tarchi, “Italia Populista”, Il Mulino, Bologna 2015. Più in generale, il testo si rivela utile per una discussione scientificamente fondata del concetto di populismo.
2. Cfr. Alain de Benoist, “La governance: storia e dottrina di un’idea liberticida”, in «Trasgressioni», n. 47, maggio-dicembre 2008.
3. Cfr. anche Alain de Benoist, “Perchè la democrazia deve essere reinventata”, in «Trasgressioni», n. 50, gennaio-agosto 2010.
Informazioni:
Per abbonarsi alle Riviste “Diorama Letterario” e “Trasgressioni”, scrivere direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: mtdiorama@gmail.com
Sito internet:
www.diorama.it, sezione “Abbonati a Diorama” e “Abbonati”.
E-mail:
mtdiorama@gmail.com