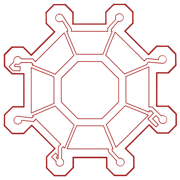Mentre associazioni umanitarie e media nostrani si indignano (e ci fanno spesso indignare) per la repressione della libertà di pensiero e dei diritti politici nei Paesi che non appartengono al blocco occidentale, assistiamo -qui da noi- all’apparente paradosso del tentativo, sempre più frequente, da parte di quegli stessi indignati ambienti, di inalveare l’esprimibilità delle opinioni nei labili argini segnati da un pensiero che si vuole “politicamente corretto” per postulato, che pretende per sé l’opzione morale di rappresentare l’oggettività universale del sentimento del Giusto.
Il fenomeno si accompagna con la negativizzazione di concetti un tempo positivi: sovranità, popolo, nazione nella loro declinazione in “ismi” diventano altrettanti baubau del cattiverio: essere sovranista o, peggio, populista significa oggi, per gli epigoni della società del Mercato, essere elemento di disturbo della governance liberista, l’unica ammissibile per i cantori della democrazia limitata.
La ricerca del nemico oggettivo della società dei “liberi, uguali e liquidi” ha trovato nuovi termini di disprezzo, che però -per statuto- non fanno parte dei discorsi d’odio, pur negativizzando una legittima posizione politica. Le identità forti e le loro teorizzazione o difesa sono da stigmatizzare e quindi da punire, di converso la divulgazione di modi di essere e di identità liquide, “non convenzionali” deve essere tutelata con ogni mezzo legale e quindi, in primis, con leggi ad hoc.
Dimentichi della semantica cangiante delle parole, gli epigoni della “Cultura del piagnisteo” vogliono sterilizzare i discorsi d’odio a suon di bastonate giudiziarie, con una produzione giuspenalistica che introduca fattispecie astratte di condotte non tipizzate, né meglio definite, con cui punire, ma anche dissuadere, il singolo dall’esprimere concetti che potrebbero essere fatti rientrare nella zona rossa dell’applicazione della norma criminale.
E non è un caso che la pervicace volontà di introdurre per via normativa una pedagogia del pensiero che ufficializzi la distinzione tra idee “buone” e pensieri “cattivi” si accompagni al declino dell’autorevolezza dei tradizionali organi di informazione: non è più la solidità degli argomenti, l’evidenza dei fatti, la nitidezza logica dei ragionamenti a sostenere un’affermazione, ma è l’entità della pena edittale a sconfessare la predicabilità di opinioni contrarie o anche solo dissonanti da quelle “corrette”.
Nel voler fissare concettualmente una linea di demarcazione tra il dicibile e l’indicibile, i nuovi reati d’opinione hanno già nel conio un pericolo applicativo: l’impostazione di queste norme tende infatti a far sì che non sia il Legislaltore, ma il giudice a integrare e a modellare l’indefinita fattispecie dello psicoreato sostituendo nei fatti la volontà del Legislatore, e cioè il criterio ermeneutico posto a monte dell’attività giurisdizionale, con la propria volontà o “peggio” con la propria visione politico-culturale.
E qui ci troviamo di fronte ad un secondo apparente paradosso: tanto più è illiberale la norma, tanto più libera sarà la possibilità di interpretazione di tale norma da parte del Giudice. E cioè l’arbitrio.
E’ stato del resto già notato che in un contesto connotato dalla prassi ermeneutica del Giusliberismo, “la zona franca [della normativa] stimola un’opzione morale del giudice, perseguita attraverso la creazione – giurisdizionale – di una “nuova legalità”, “alternativa a quella legislativa”, ma in questo alveo una simile prassi rischia di averi effetti liberticidi, permettendo in tal modo limitazioni assai invasive ai diritti fondamentali: il pendant della estrema genericità della norma è l’illimitata arbitrarietà del Giudice del caso concreto e la consapevolezza di tale arbitrarietà induce di conserva il soggetto a preferire di non esprimere le proprie opinioni: si genera così uno stato di paura nelle coscienze delle persone che si associa al diffuso sentimento dell’inutilità dell’esprimere pubblicamente le proprie idee (sentimento che trova le sue conseguenze ultime nella diserzione delle urne elettorali e nel disimpegno politico e civico, surrogati da uno sterile cianciare su tutto lo scibile umano sui canali telematici).
Ma in questo modo, per dirla con Giorgio Agamben, «è il linguaggio stesso come luogo della manifestazione della verità che viene confiscato agli esseri umani». Il danno che questi provvedimenti normativi (e la loro applicazione giudiziaria) possono produrre nella cultura politica è enorme e sproporzionato rispetto ai pretesi benefici che si perseguono, soprattutto se commisurati all’entità dei fenomeni che si pretende di reprimere.
***
Ricordo tra i tanti casi di lotta per la libertà d’espressione, le parole che nel 2010 Aung San Suu Kyi, al tempo leader del dissenso contro la giunta militare birmana, pronunciò nel suo primo intervento pubblico dopo sette anni di detenzione domiciliare: «la base della libertà democratica è la libertà di parola». La libertà di espressione in effetti è il fondamento di tutti i diritti politici e civili, senza di essa le altre libertà, quella di associazione, di voto, di insegnamento e apprendimento rimangono libertà vuote, in quanto se non si è liberi di esprimere le proprie idee si è menomati della possibilità di fare proselitismo, di modificare o comunque di incidere sulla coscienza popolare e sullo status quo.
Ed ecco l’effetto paradosso: queste parole, pronunciate a migliaia di chilometri di distanza, in un Paese con lingua, cultura, tradizioni e sistema politico diversi dal nostro, appaiono come la declamazione di principi inconfutabili. Le stesse parole dette in Italia, o in molti paesi europei, fanno invece additare come “persona sospetta”, come probabile nemico dell’ordine costituito, chi le pronuncia. La libertà di parola va dunque affermata e protetta se è conculcata o punita da ordinamenti estranei al nostro universo culturale, ma può (e secondo alcuni: deve) invece essere sanzionata e ristretta se mette a rischio convinzioni, valori e sicurezze su cui si fondano gli Stati democratici (democratici per autodefinizione). In altre parole uno Stato etico, ma fondato sull’etica dei valori di mercato, dove regna una libertà malsana: quella di spogliare i popoli dei loro averi, della loro cultura, della loro identità, sostituendole con un bagaglio permeabile allo statuto antropologico della Forma capitale.
Come osservava Pietro Barcellona in “Parole potere” (Castelvecchi 2013): «la comunicazione virtuale deformi la percezione dello spazio e del tempo, perché si propone come priva di centro e trasmette una sensazione di infinità e di potenza, ma nel suo flusso nasconde, invece, nuove forme di dominio che si fondano, da un lato, sull’assenza della verità dei corpi, dall’altro sulla rigidità del codice semantico, che non permette l’espressione di senso che abita la profondità degli esseri umani». Oggi si può realizzare un dominio senza la necessità di usare alcun potere coercitivo materiale: le nuove forme di servitù si fondano sulla riduzione al silenzio e sull’annichilimento dell’attitudine umana a creare espressioni e discorsi capaci di mettere in scena i propri bisogni, le proprie emozioni e i propri pensieri.
Questa forma di potere pervasivo che si manifesta attraverso l’introduzione di un lessico, che progressivamente sostituisce le precedenti forme di rappresentazione dello stare insieme, mira a creare aree sempre più vaste di sudditanza psicologica ai modi attuali di organizzazione della società: espressioni come ‘i mercati ci guardano’ o ‘se abbiamo molti debiti rischiamo il fallimento’ rievocano le formule che, in epoche remote, facevano appello all’occhio divino che guarda il mondo per ottenere l’ossequio all’autorità.
Vogliono limitare la libertà delle persone in nome di un amore che non è tale.